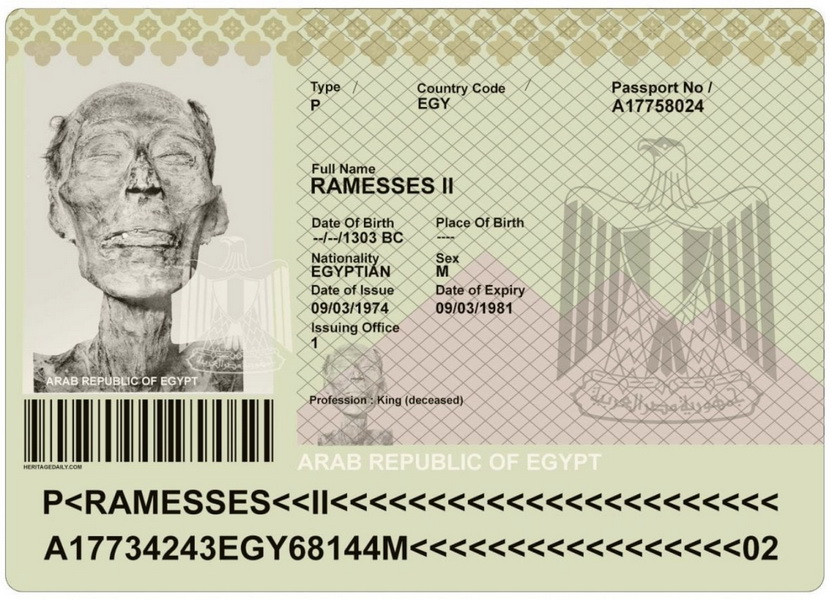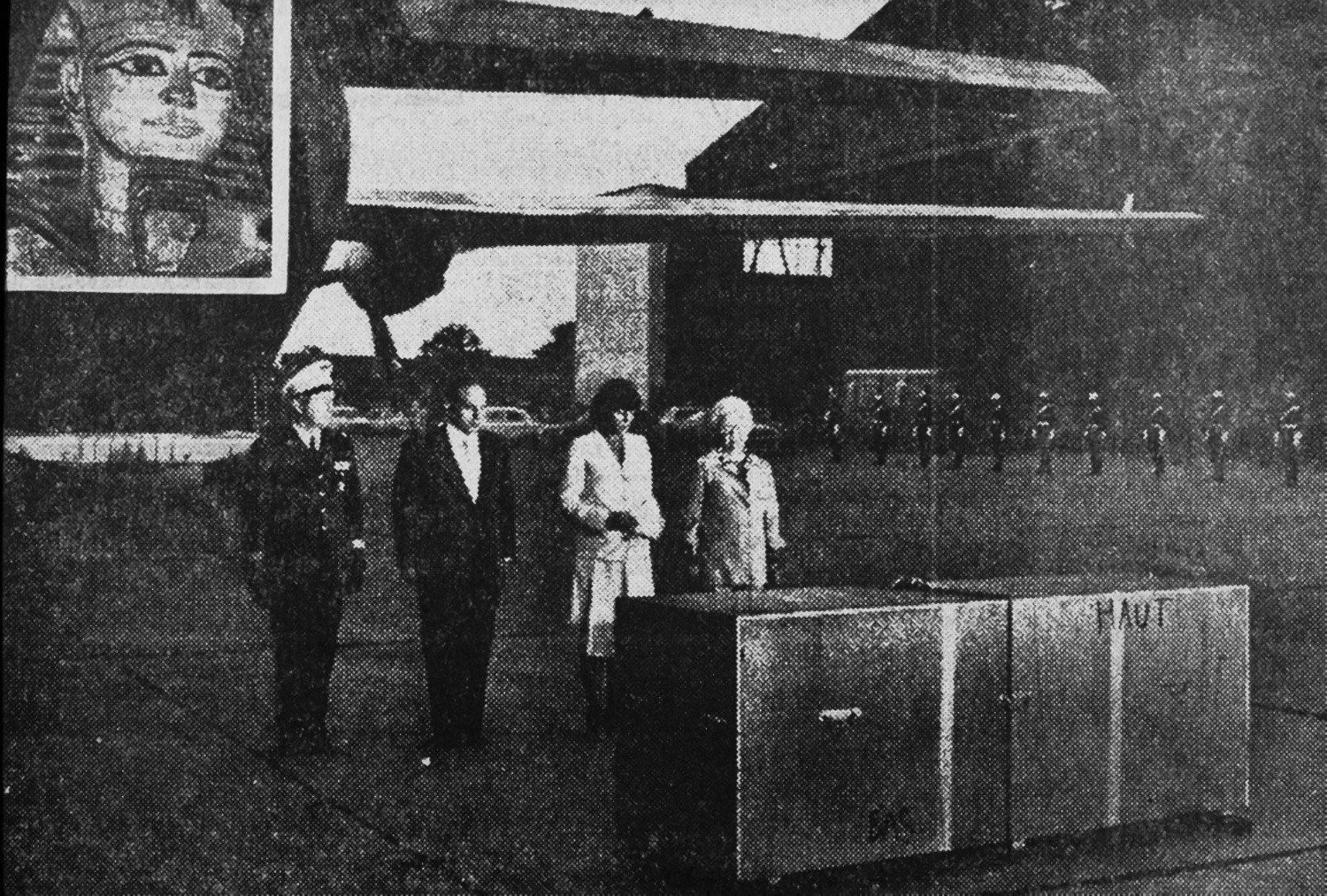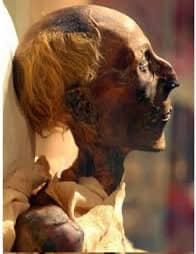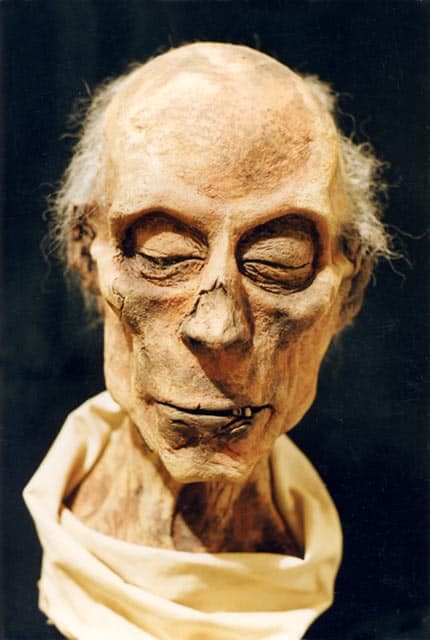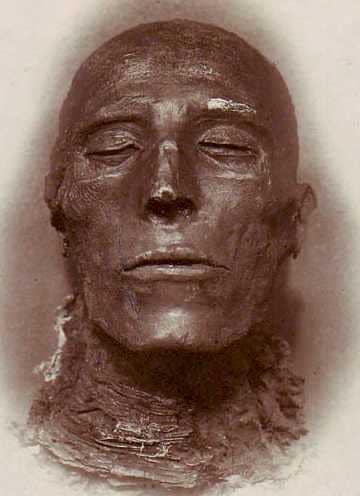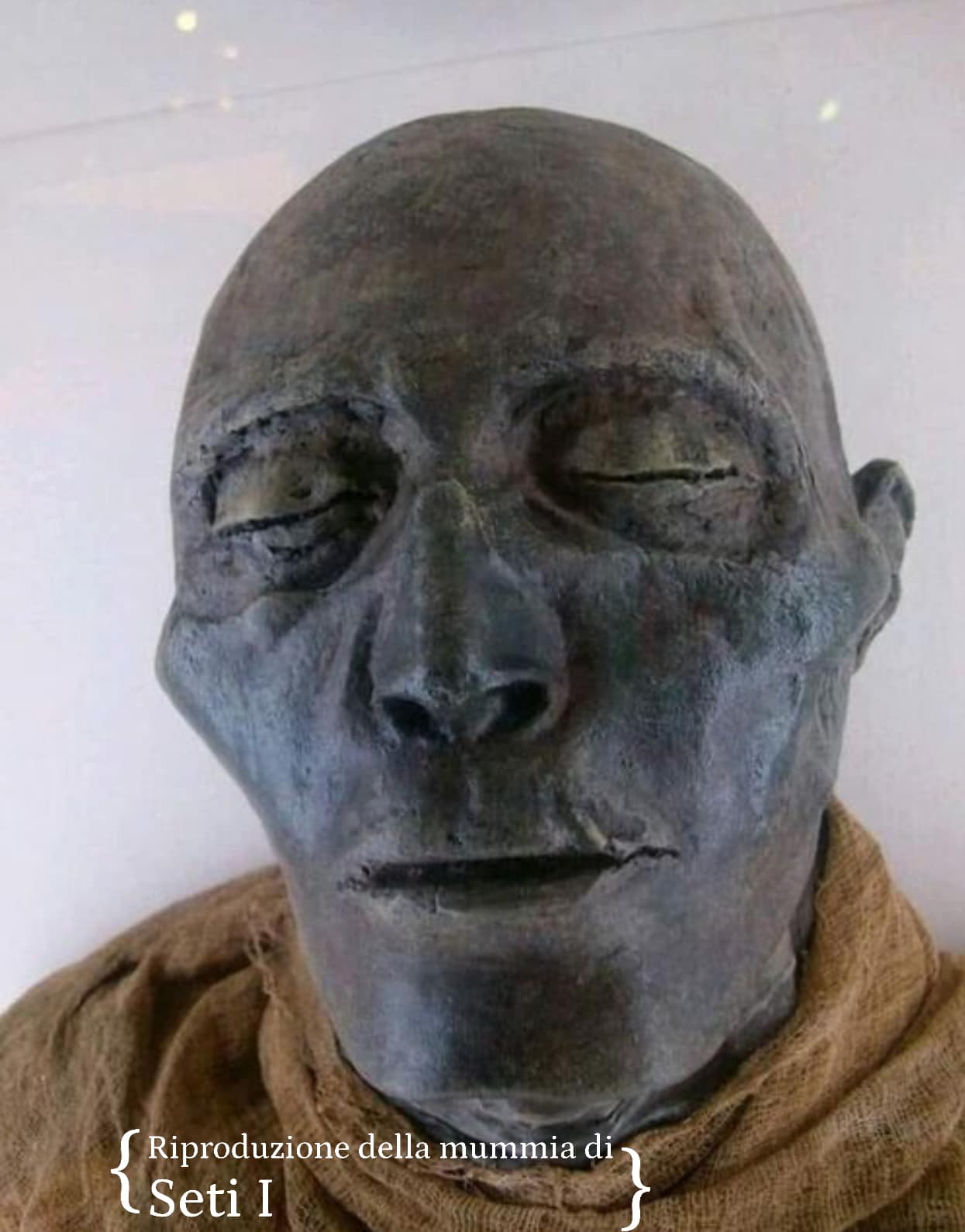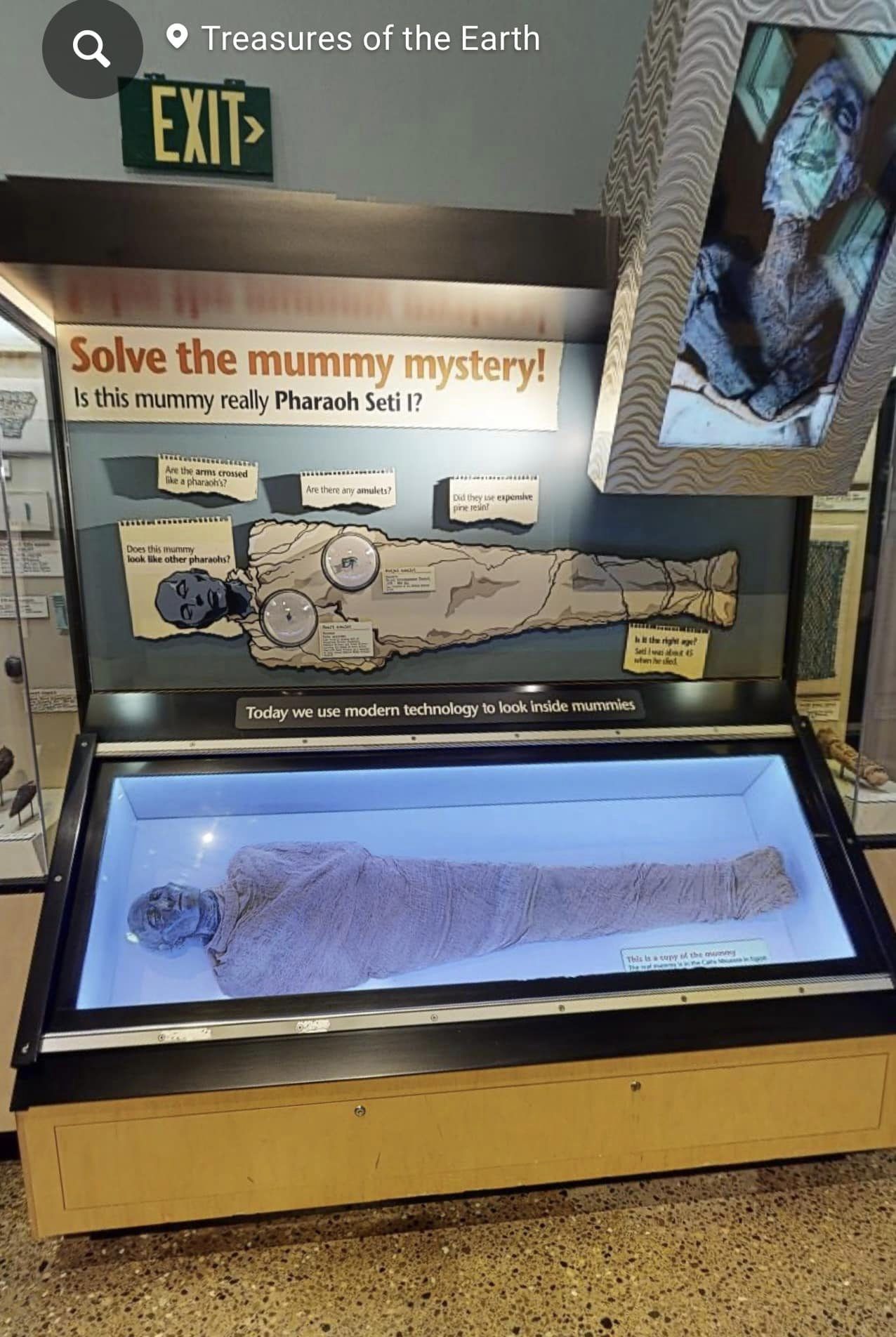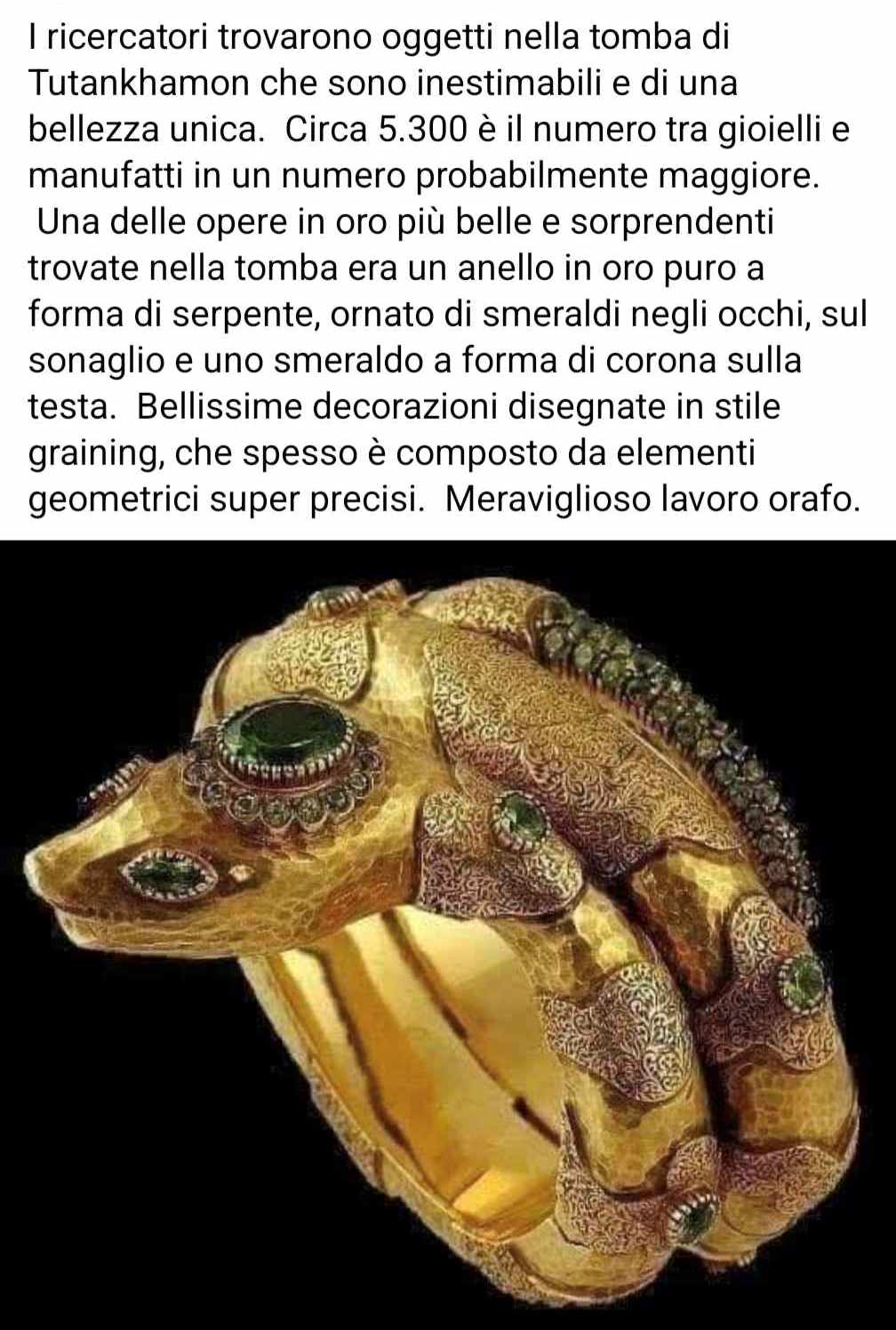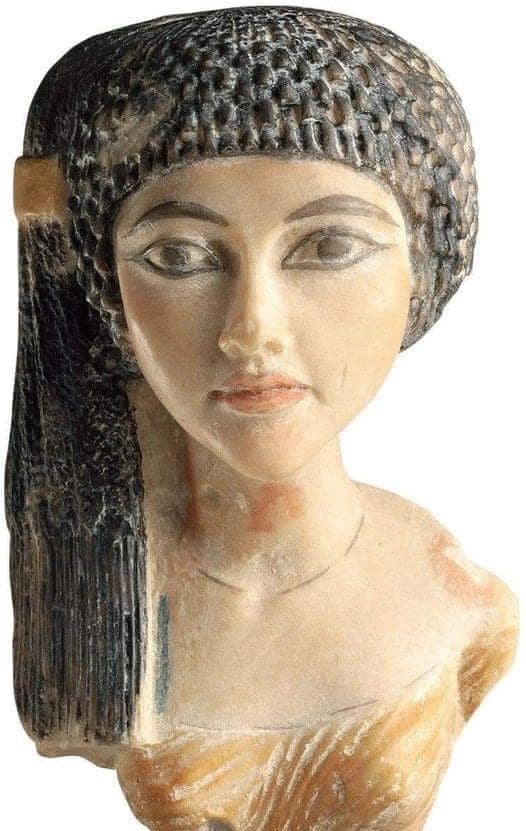Di Patrizia Burlini e Nico Pollone


Da qualche tempo sono riapparsi post su Heracleion-Thonis, la città sommersa di fronte ad Alessandria d’Egitto.
Eh sì, perché la rete funziona così: qualcuno pubblica una bufala acchiappa like e, a pioggia, molti riprendono la notizia, arricchendola di informazioni assurde ed inventate di sana pianta.
Generalmente, io commento i post che riportano notizie fake cercando di correggere le falsità riportate. Questo è successo recentemente su questa notizia e la reazione è stata:
– sono stata bannata e i miei commenti cancellati
– Sono stata totalmente ignorata e le informazioni false rimaste come tali
– Sono stata contraddetta cercando di dimostrare il contrario
Poiché circolano molte informazioni false e l’intelligenza artificiale si nutre di esse, quest’ultima, se interrogata, essendo le informazioni false più numerose delle informazioni corrette, ripeterà le notizie false. Ecco perché è importante correggere tali notizie.

https://chroniclesofukraine.quora.com/Underwater-Museum…
https://www.greenme.it/…/europa/museo-sottomarino-russia/
Ritorniamo adesso su Heracleion-Thonis. I resti della città, che vide il periodo di massima prosperità tra il VI e IV secolo a.C, si trovano a circa 2,5 km dalla costa, nella baia di Abu Qir, non distante da Alessandria.
Affondò nel VI o VII secolo d.C a causa di grandi terremoti o inondazioni.
Fu riscoperta nel 2000 dall’archeologo subacqueo francese Franck Goddio. Gran parte dei reperti scoperti si trovano oggi al Museo Archeologico di Alessandria.
Ed eccoci ora ai reperti spacciati come originali. I bufalari calcano la mano identificando Heracleion come Atlantide, ovviamente.
Tra le foto fake, quelle che mi fanno più sorridere sono
– il fantastico leone con la zampa appoggiata sul mondo (eh già perché gli egizi rappresentavano già il mondo come un globo ![]() …) che appartiene in realtà ad un cimitero subacqueo americano
…) che appartiene in realtà ad un cimitero subacqueo americano

Questo gruppo scultoreo si trova nel Neptune Memorial Reef,in Florida.
https://www.deeperblue.com/neptune-memorial-
– Il tempio sommerso, ovviamente quasi totalmente intatto, che invece altro non è che l’immagine di un videogioco, Assassin’s Creed Origins (illustrato anche nella nostra pagina ma con la dicitura che tutte le immagini provengono dal videogioco…https://laciviltaegizia.org/2023/08/10/heracleion/)


Città egizia sommersa. Immagini tratte dal videogioco Assassin’s Creed Origin