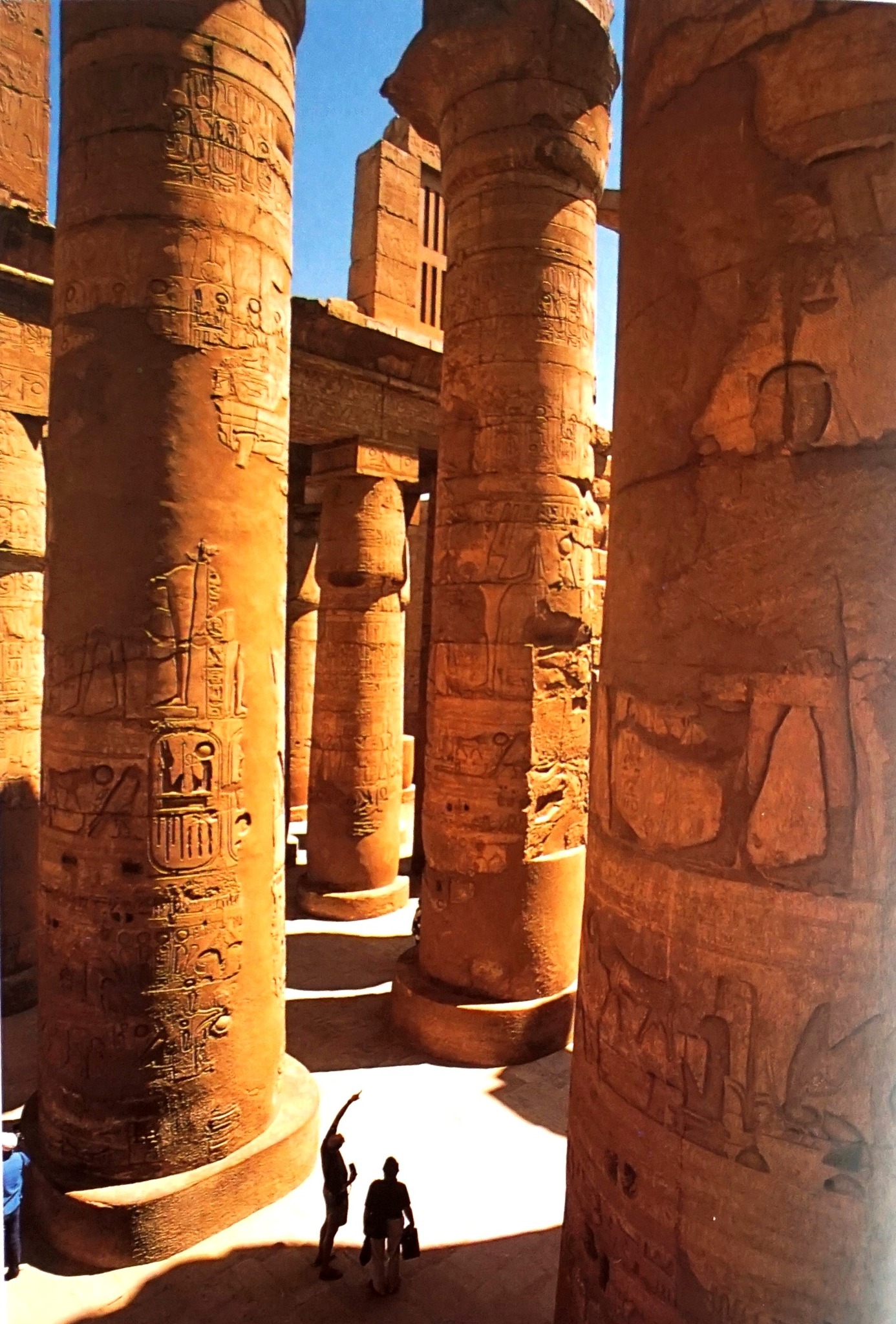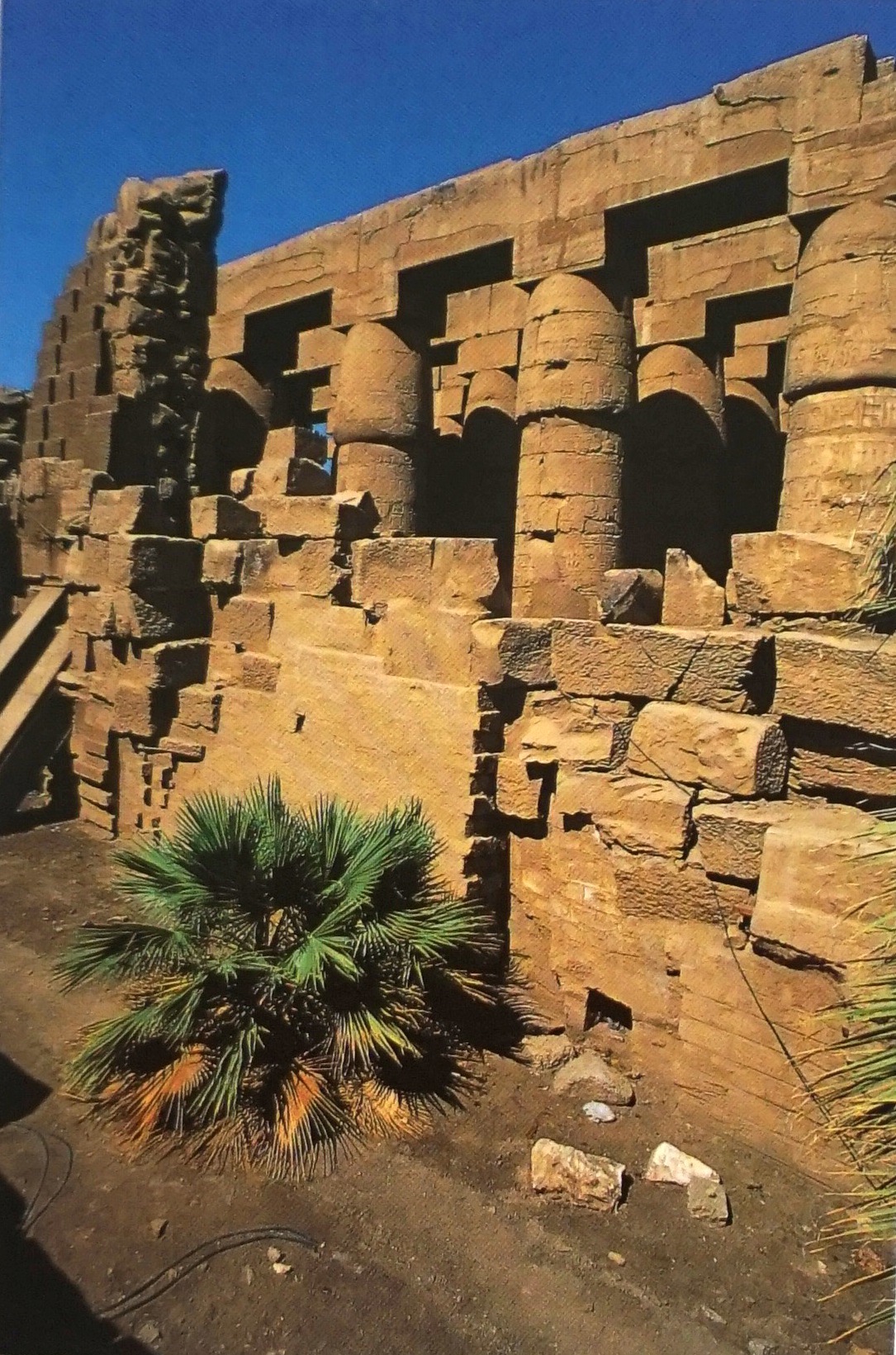A cura di Ivo Prezioso
David Roberts fu uno dei più famosi vedutisti del XIX secolo. Nato a Stockbridge, nei pressi di Edinburgo, il 24 ottobre 1796, nel settembre del 1838 intraprese un’avventurosa risalita del Nilo, sino ai templi rupestri di Abu Simbel. Durante la sua straordinaria esplorazione eseguì centinaia di schizzi e studi delle rovine egizie (oltre a numerose vedute delle moschee del Cairo). Dai disegni dell’artista, Louis Haghe ne trasse delle litografie che furono pubblicate tra il 1846 e 1848.

Ho pensato di proporne di volta in volta alcune tra le più belle sia per l’alto valore artistico delle tavole, sia perché costituiscono una preziosa testimonianza dei monumenti egizi, così come li vide Roberts.
Il Tempio di Dendera, 19-20 ottobre 1838
Roberts aveva pianificato accuratamente il suo viaggio allo scopo di ridurre le soste, e di conseguenza le spese, all’essenziale. Si era prefissato di raggiungere Abu Simbel nel più breve tempo possibile per poi risalire il Nilo sino al Cairo. Le Immagini n. 1 e n. 2 ci illustrano al meglio come si articolò la sua permanenza in Egitto.
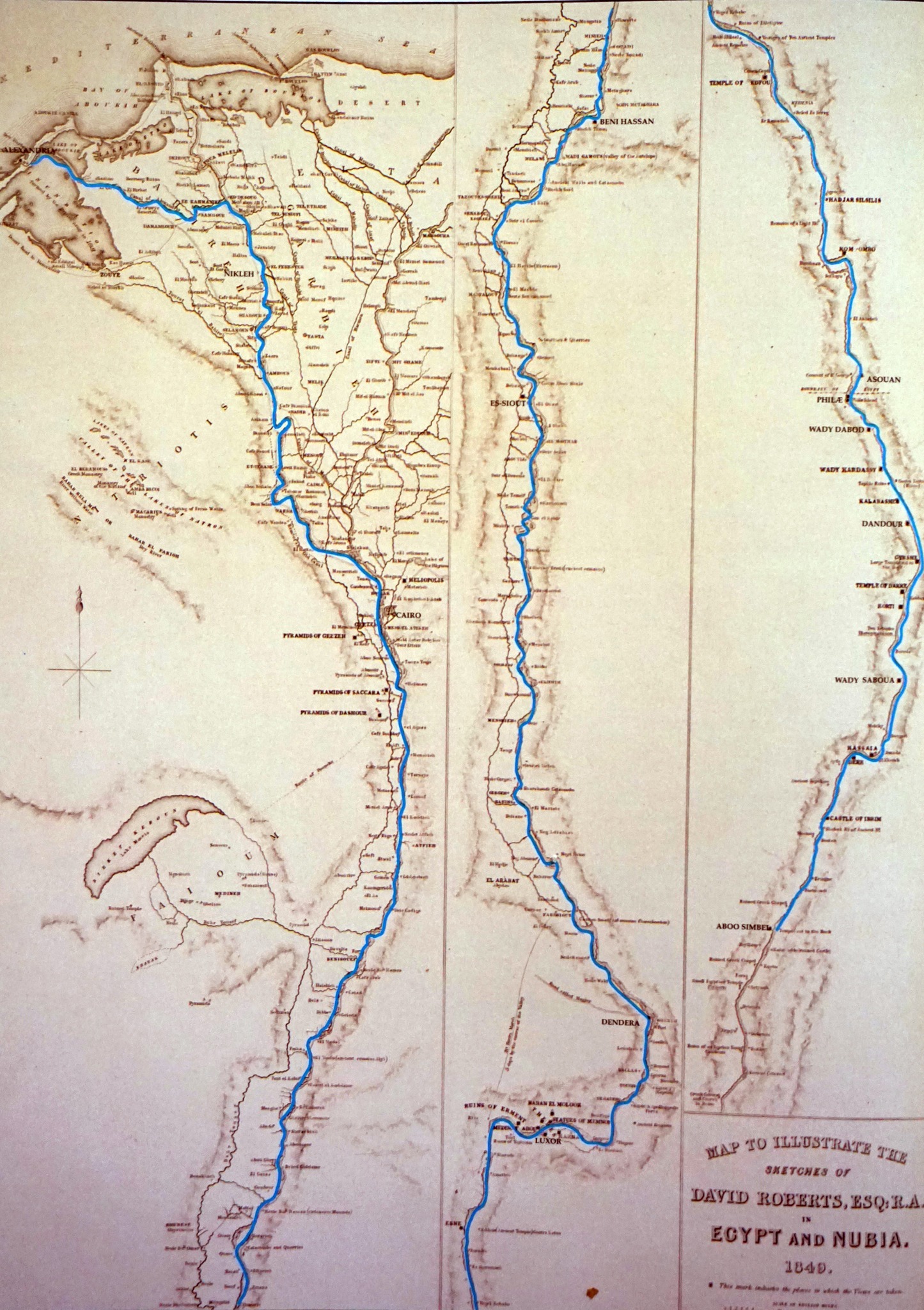
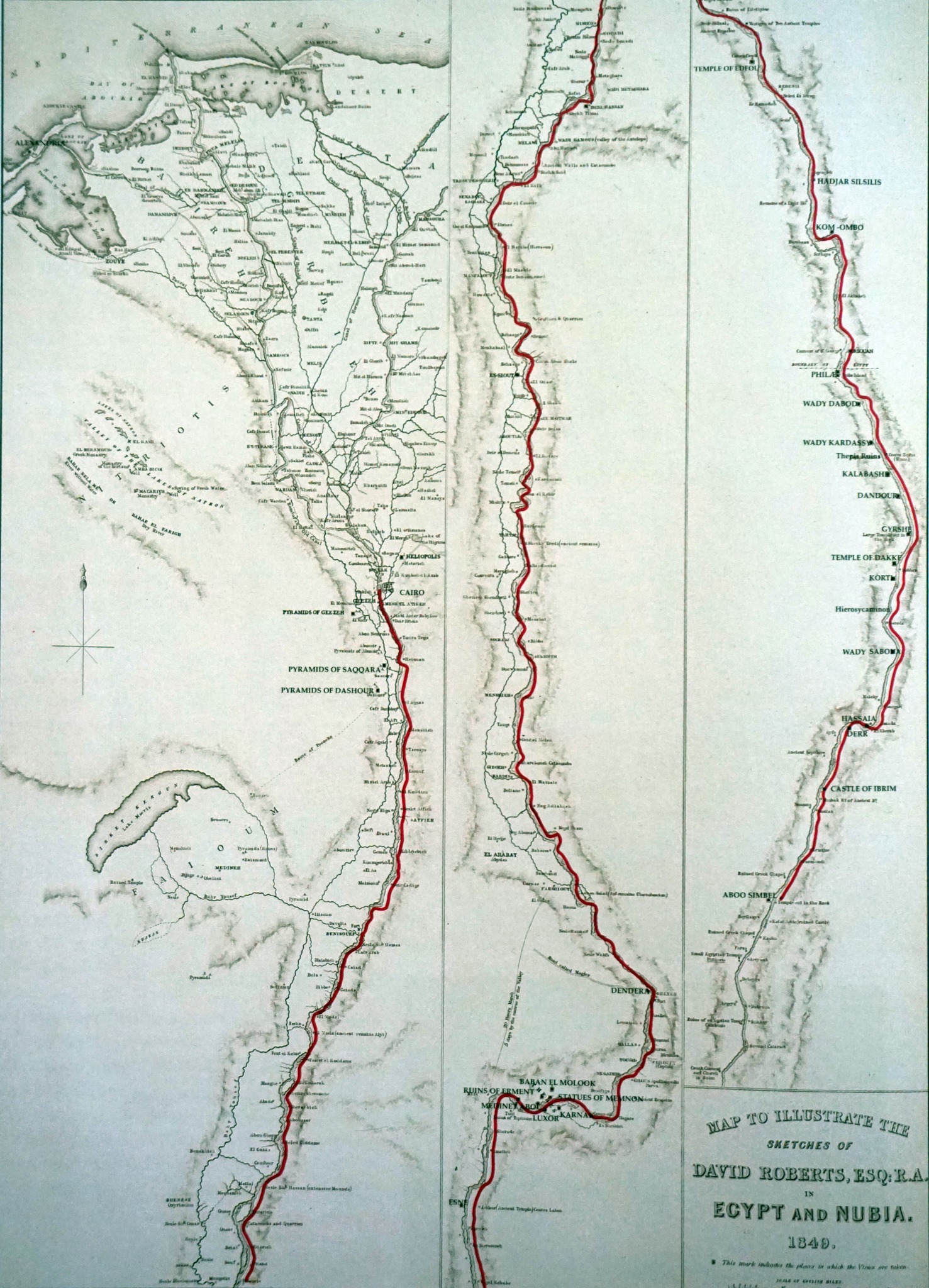
A tal fine, durante il viaggio di andata, fece tappa solo nei principali siti archeologici limitandosi ad osservare le spettacolari vestigia, quasi volesse assorbirne le suggestioni prima di accingersi all’arduo compito di trasferirne sulla carta forme e colori. Dal suo diario, infatti, si desume che nelle prime settimane si dedicò a scrivere appunti e a realizzare schizzi. Fanno eccezione le vedute di alcuni siti minori sui quali non si sarebbe soffermato al ritorno. Solo in alcuni casi la grandiosità e la suggestione dei luoghi prese il sopravvento e quasi lo costrinse a realizzare tavole relative a siti che avrebbe poi illustrato molto più approfonditamente durante il ritorno da Abu Simbel. E’ il caso di Dendera e di Luxor.
Roberts aveva lasciato Beni Hasan l’11 ottobre 1838 alla volta di Ibadah, l’antica Antinoe, delle cui vestigia, descritte anni prima da altri viaggiatori, non rimaneva praticamente traccia; per cui proseguì verso Asyut che raggiunse il giorno seguente. Anche qui si era conservato ben poco degli antichi monumenti. Ebbe però modo di visitare e ritrarre la Grande Moschea con il suo altissimo minareto e la necropoli rupestre che lo infastidì enormemente per lo sfacelo arrecato dai cercatori di mummie i quali, durante la loro opera sacrilega, avevano sparso all’intorno miseri resti umani mutilati e profanati. Questi scempi avevano avuto inizio già a partire dal Medioevo in quanto farmacisti arabi ed europei facevano largo uso di parti di mummia convinti delle loro proprietà taumaturgiche e benefiche. La devastante pratica si incrementò in maniera abnorme raggiungendo il suo culmine nel XVII secolo, per poi cominciare a declinare durante il Settecento (il secolo dei numi) pur rimanendo ancora in auge, nelle pratiche esoteriche, fino ai primi decenni del secolo scorso.
Partito da Asyut il 14 ottobre, aveva raggiunto il celebre santuario di Hathor dopo cinque giorni. Le imponenti rovine di Dendera lo emozionarono a tal punto che non poté resistere alla tentazione di ritrarne una prima panoramica (Immagine n. 3). Ma quelle splendide e gloriose rovine gli procurarono anche una grande malinconia in quanto lo indussero a riflettere sulla caducità delle cose umane. Il Tempio lo illustrerà, poi, magistralmente sulla via del ritorno da Abu Simbel al Cairo, quando sostò nuovamente a Dendera dal 6 all’8 dicembre 1838.

ABU SIMBEL, 7-9 novembre 1838: l’approdo
La mattina del 7 novembre Davids approdò presso la cittadina di Kossocko dove fu deciso che si sarebbe trascorsa l’intera giornata. All’imbrunire del giorno successivo erano in vista delle favolose rovine del tempio e solo l’oscurità, ormai incombente, differì l’ incontro con la metà tanto agognata. Dopo poche ore di sonno, l’artista giunse al cospetto dei due giganteschi templi scavati nella roccia: era l’alba di venerdì 9 novembre 1838.
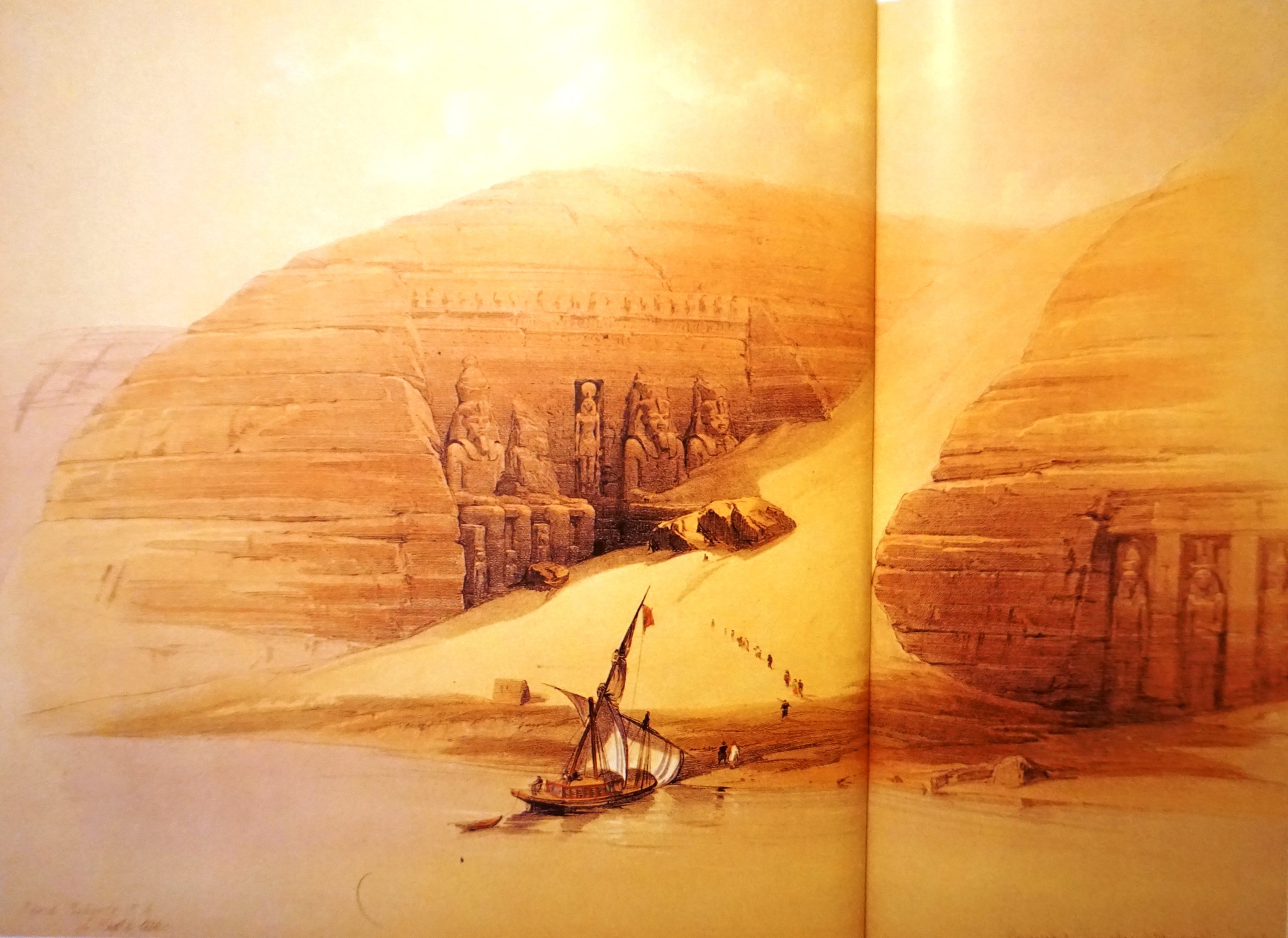
Abu Simbel era stata scoperta nel marzo 1813 dall’esploratore svizzero Johann Ludwig Burckardt e dopo soli venticinque anni la fama del sito era diventata sconfinata. Già nel 1815 l’inglese William John Bankes ed il ferrarese Giovanni Finati erano riusciti a penetrare nel tempio minore dedicato ad Hathor e alla regina Nefertari, ma nulla poterono contro l’immensa massa sabbiosa che ostruiva quello maggiore dal quale emergeva solo il busto di una delle quattro statue di Ramses II. Un nuovo infruttuoso tentativo fu operato dal console piemontese Drovetti, finché, il 1° agosto 1817 Giovanni Battista Belzoni, dopo aver impiegato oltre un mese nella immane opera di disinsabbiamento, riuscì a introdursi nel tempio.
Quando Roberts giunse sul luogo, il vallone che separava i due templi rupestri era ancora parzialmente ostruito da una grande colata di sabbia che giungeva a lambire le acque del Nilo, ma i monumenti erano in gran parte visibili. L’artista fu il primo a ritrarli in tutto il loro splendore con minuziosa cura per i particolari e le proporzioni architettoniche (Immagine n. 2).
ABU SIMBEL, 9 novembre 1838: il Grande Tempio.

<<9 novembre – E’ sconvolgente vedere questi capolavori dell’arte antica non solo massacrati dai cacciatori di souvenir, ma addirittura costellati delle firme dei vari Tomkins, Smith e Hopkins. Una delle mani del colosso meglio conservato è stata letteralmente distrutta da questi delinquenti che, non soddisfatti di essersi portati via a ricordo della loro spregevole impresa un dito della grande statua, hanno poi avuto l’ardire di scolpire i loro stupidi nomi sulla fronte del dio.>> (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.64-65)
Roberts scrisse che <<il monumento di Abu Simbel vale da solo il viaggio in Nubia>>.
Lo stato di conservazione delle colossali statue di Ramses II era eccezionale e dovuto certamente alla lunga permanenza sotto la coltre sabbiosa che le aveva preservate dalle ingiurie del tempo e degli elementi. Tuttavia, erano trascorsi solo pochi anni dalla scoperta e già la stupidità dei visitatori aveva lasciato un segno indelebile: decine di firme incise nella pietra ne deturpavano la ieratica bellezza. Inoltre, erano stati asportati numerosi frammenti, evidentemente da esibire come “souvenir” una volta rientrati in patria. Disgustato da un simile vandalico scempio, Roberts si augurò che la sabbia tornasse provvidenzialmente a ricoprire quel magnifico santuario.
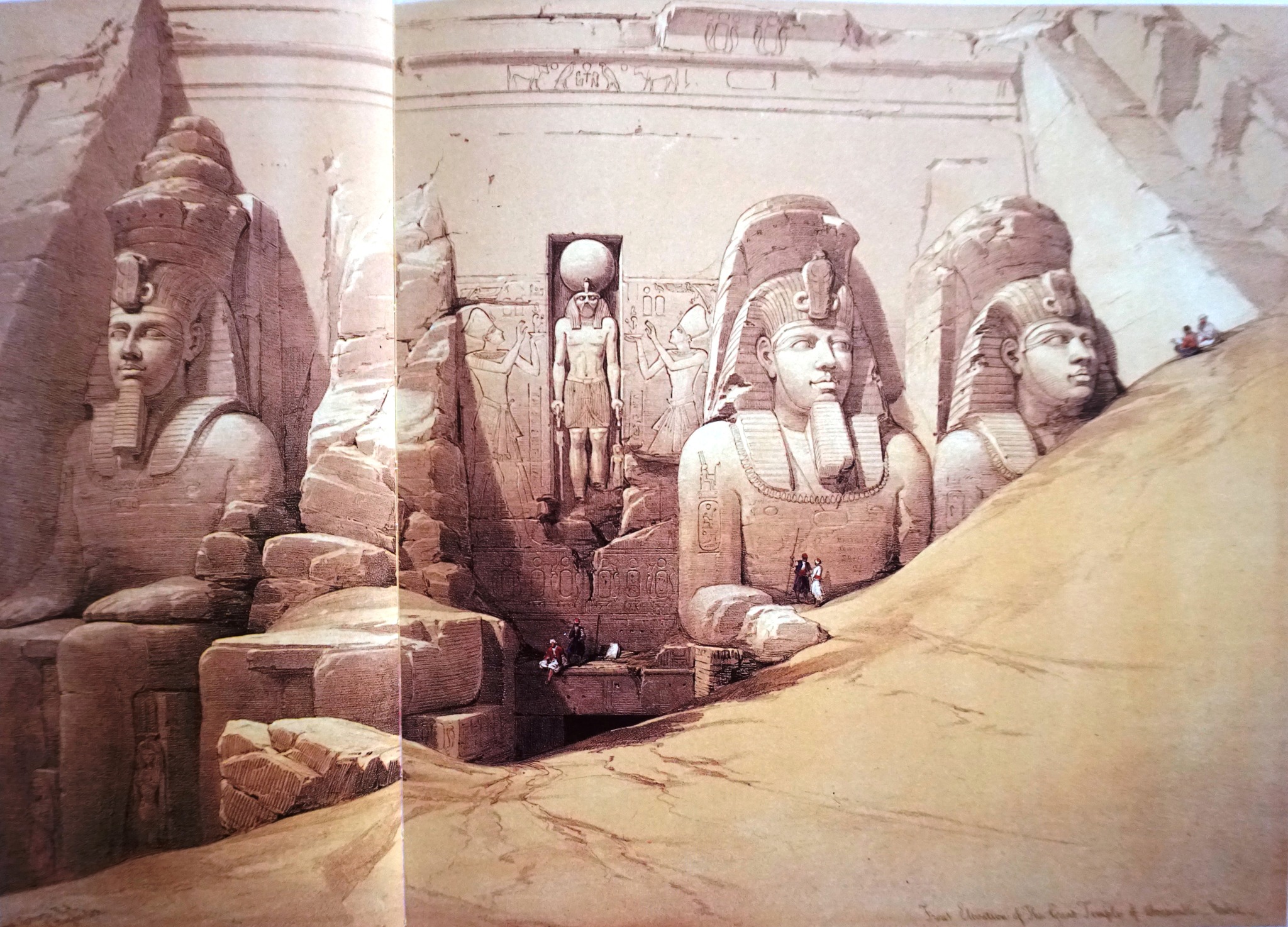
<<9 novembre – La bellezza e le dimensioni del tempio non sono sorpassate da nessun altro monumento egizio, neppure dai santuari tebani. Se lo si paragona alle teste di Iside che ornano i capitelli del tempio di Dendera, il più elaborato e meglio rifinito tra i templi egiziani, la povera dea sembra addirittura grossolana. E pensare che Dendera è di gran lunga più recente rispetto ad Abu Simbel>> (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.68-69)
Appare, perciò, quantomeno curioso che nella litografia, sul collo del piede della prima statua, faccia bella mostra di sé proprio il nome dell’artista. L’imbarazzante “incidente” è però, quasi certamente, da attribuirsi a Louis Hage che pensando di fare cosa gradita all’artista, aggiunse, del tutto a sproposito, il particolare nella litografia.
L’ipotesi è avvalorata dal fatto che la firma è seguita da “R.A.”, vale a dire “Royal Accademician” il che non avrebbe potuto essere in quanto Roberts divenne membro della Royal Accademy solo due anni dopo essere rientrato in patria.
ABU SIMBEL, 9-10 novembre 1838: l’interno del Grande Tempio e il naos
Interno
Dal punto di vista architettonico il santuario non è altro che una trasposizione nella roccia viva degli elementi tipici del tempio egizio classico. La facciata è infatti concepita come un vero e proprio pilone e gli ambienti retrostanti furono scavati direttamente negli strati di arenaria. Davis descrive il passaggio dall’esterno, inondato di luce abbacinante, alla silenziosa oscurità del pronao come un’esperienza unica, indescrivibile e al tempo stesso, commovente. Il soffitto dell’enorme sala, lunga 18 metri e larga 16, è sorretto da 8 pilastri, alti ciascuno 10 metri e disposti su due file. a cui sono addossate altrettante statue osiriache di Ramses II (Immagine n. 1).
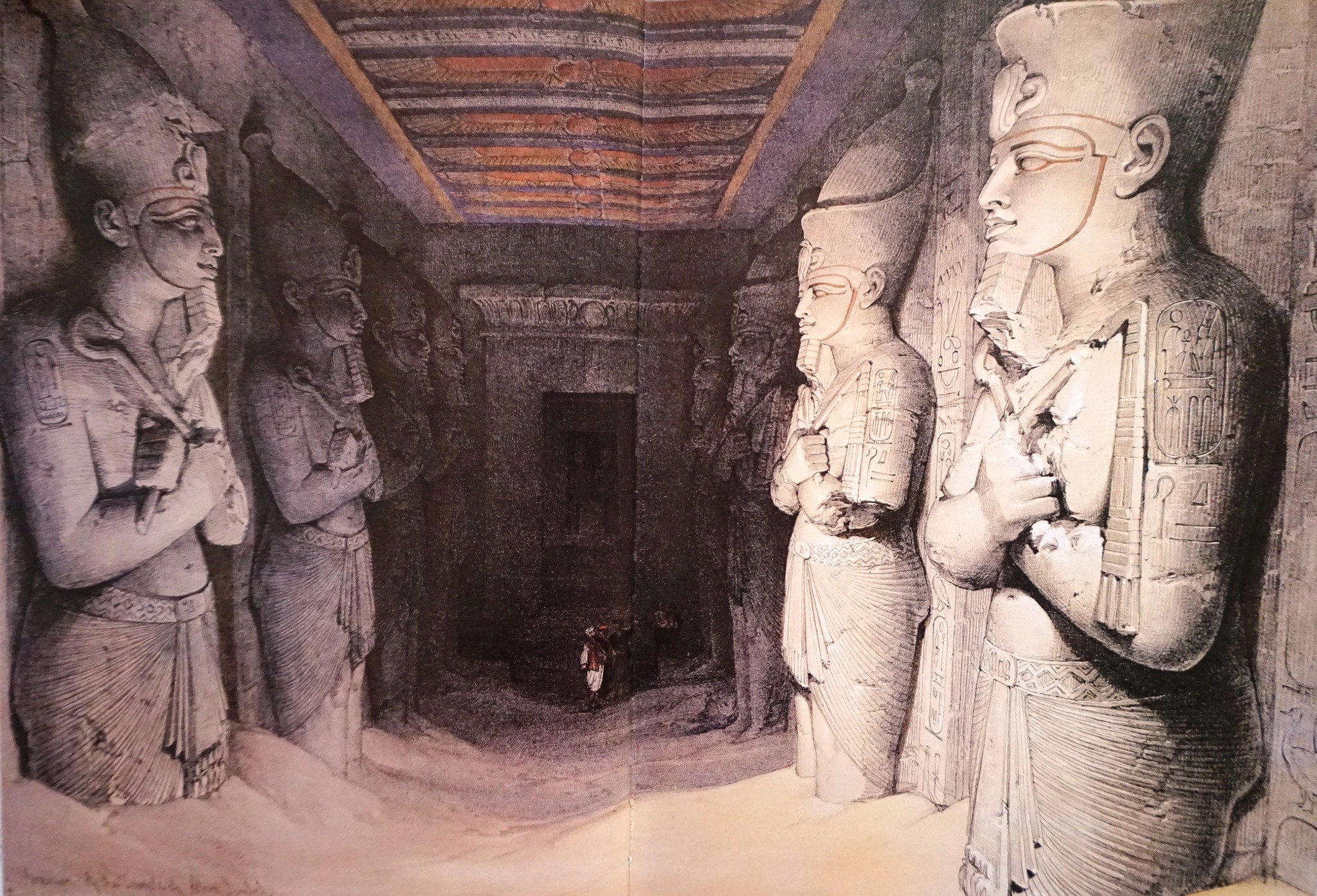
Da notare il grossolano errore nella datazione incisa sulla tavola: giorno e mese sono corretti, non così l’anno che viene indicato come 1836 anziché 1838. (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.70-71)
Il naos
Il sacrario, il luogo più riposto e segreto del tempio si trova a 65 metri dal portale di ingresso, nel cuore della collina. In questo piccolo ambiente largo 4 metri e profondo poco più di 7, furono poste le statue di Harmakhis, Ptah, Amon-Ra e dello stesso Ramses II divinizzato. Già nell’Ottocento ci si rese conto che il complesso fu realizzato seguendo uno schema ben preciso. Due volte all’anno, nel periodo dei solstizi poco prima delle 6 del mattino un raggio di sole penetrava nel corridoio che separa l’ingresso dal naos e andava ad illuminare la spalla sinistra di Amon-Ra; qualche attimo dopo toccava al faraone-dio ed infine era Harmakhis ad inondarsi di luce. Il tutto aveva una durava di una ventina di minuti. Davvero significativo il fatto che Ptah, volutamente, non viene colpito dal raggio luminoso, in quanto considerato nel suo aspetto di signore dell’oscurità.
Quando, a seguito della costruzione della diga di Aswan, si rese necessario smontare i templi, per salvarli dalle acque del lago Nasser, fu posta una particolare attenzione al loro orientamento, affinché non andasse perduto questo fantastico “miracolo del sole”, veroe proprio capolavoro di maestria degli antichi egizi.
Dopo quattro anni di lavori, cominciati nella primavera del 1964 sotto l’egida dell’ UNESCO, il Grande Tempio, tagliato in 807 blocchi e riassemblato su uno scheletro di cemento armato, in posizione sicura, vide ripetersi lo straordinario evento nel febbraio del 1969 (Immagine n. 2).

<< 9 novembre 1838 – All’interno della cella si trovano quattro divinità, intonacate e dipinte; di fronte a loro sono presenti i resti di un altare anch’esso scavato nella viva roccia. Gli spigoli sono integri, ma la parte superiore è danneggiata. E’ l’unica cosa del genere che io abbia visto finora ed è davvero affascinante. Su entrambe le pareti ai lati dell’altare, una sessantina di centimetri prima di esso, vi sono delle scanalature e dei fori, forse lasciati per una specie di cancello che impediva ai fedeli l’accesso alla stanza. (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.72-73
Gli Aghi di Cleopatra, 24-26 settembre 1838
Imbarcatosi da Londra il 31 agosto 1838, alla volta di Parigi, proseguì lungo la Valle del Rodano fino a Marsiglia dove arrivò l’ 11 settembre; da lì un piroscafo lo avrebbe condotto a Civitavecchia. Ebbe così inizio il viaggio verso l’Egitto. Dopo aver fatto scalo a Malta e in Grecia, nelle isole Cicladi, raggiunse Alessandria il 24 settembre (Immagine n. 1).

Dalle lettere di David Roberts, 24 settembre: <<Questa mattina ci siamo svegliati di buon ora: Alessandria era proprio di fronte a noi, con le moschee e i palmizi che le conferivano un’atmosfera diversa da qualsiasi altra io avessi respirato prima… La baia era affollata da un gran numero di vascelli, molti dei quali erano navi da guerra; la nostra imbarcazione è stata ben presto circondata dai più pittoreschi battellieri che io abbia mai visto…>> (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg. 28-29)
Entrato in città rimase quasi stordito dalla grande confusione: ai suoi occhi si presentò un variegato carnaio costituito da signorotti turchi sontuosamente vestiti, schiave nere completamente nude, mercanti greci ed ebrei e gente di ogni nazionalità che si spostava senza una meta apparente. Nonostante l’emozione indotta dall’ambiente così particolare, non poté fare a meno di notare che, a dispetto delle glorioso passato, l’antico splendore di Alessandria era, ormai, irrimediabilmente offuscato. Annotò, infatti che “la città mi è sembrata essere un termitaio abitato da 600.000 anime”.
Il giorno stesso del suo arrivo ebbe inizio la visita dei principali monumenti. Tuttavia, questo primo approccio con le vestigia dell’Antico Egitto, non fu particolarmente esaltante a causa delle rovinose condizioni in cui versavano. Solo due soggetti colpirono la sua ispirazione: la Colonna di Pompeo e gli obelischi di Thutmosis III (Immagine n. 2).
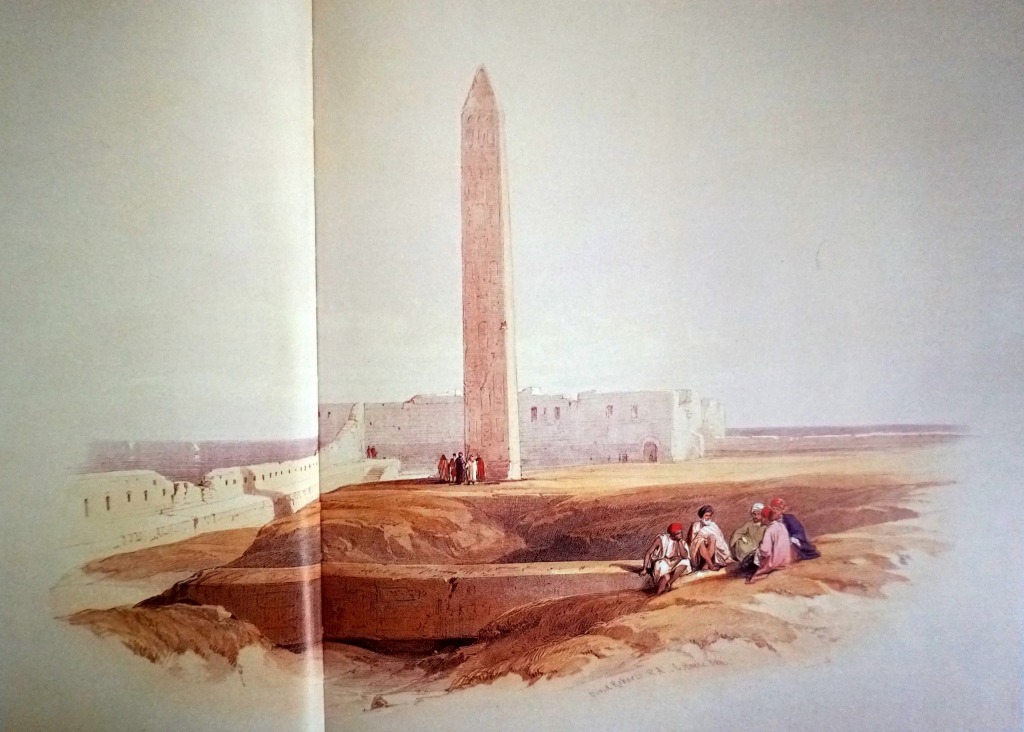
Due giorni più tardi, dopo averli accuratamente misurati, fece di essi alcuni schizzi. Questa pratica era considerata da Roberts di capitale importanza, per poter riprodurre con la massima precisione le proporzioni dei monumenti ed ogni loro dettaglio strutturale e decorativo.
All’epoca, solo uno dei due obelischi, noti come Aghi di Cleopatra, si ergeva ancora sul suo piedistallo. Il nome, per quanto suggestivo, non aveva alcun fondamento storico ed era di origine popolare, dovuto al fatto che tali strutture in arabo erano genericamente denominati messalah, ossia aghi. Inoltre, la celeberrima Cleopatra non ha nulla a che vedere con essi. I due colossali monoliti furono, infatti, fatti erigere da Thutmotis III davanti al tempio di Amon a Heliopolis. Quattordici secoli più tardi furono poi fatti spostare per volere di Augusto affinché adornassero il tempio eretto ad Alessandria in onore di Giulio Cesare.
Dei due obelischi, alti circa 21 metri, oggi non v’è più alcuna traccia. Quello giacente fu portato a Londra ed eretto sul Victoria Embankment il 13 settembre 1878, mentre il secondo fu donato agli Stati Uniti nel 1869 in occasione dell’apertura del Canale di Suez. Il 22 gennaio 1881 fu innalzato a New York, in Central Park.
L’ INGRESSO DI UNA TOMBA DI BENI HASAN, 9-11 ottobre 1838
Roberts partì da Alessandria all’alba del 27 settembre e la mattina successiva raggiunse il villaggio di Asfeh, lungo uno dei bracci del Nilo; da lì, su di un’imbarcazione più grande, ripartì alla volta di Sa-el-Hagar, l’antica Sais. La sosta successiva fu effettuata a Nikleh, il giorno 29. La regione circostante apparve all’artista molto fertile. Lasciatasi alle spalle questa località e compiute alcune tappe ugualmente pittoresche, il giorno 30 giunse in vista delle piramidi e qualche ora più tardi sbarcò al Cairo. I giorni successivi furono impiegati per la visita della città, di cui poté ammirare le sue splendide Moschee. Il 3 ottobre si recò alle piramidi, a dorso d’asino restando particolarmente emozionato dalla Sfinge. Nel frattempo organizzava il suo viaggio che prevedeva di risalire il Nilo dirigendosi verso sud. Dopo alcuni contrattempi tutto era pronto per la partenza fissata per il giorno 6, ma un improvviso vento contrario costrinse l’equipaggio a rinviarla di un giorno.
Durante la notte tra il 7 e l’8 ottobre, Roberts non riuscì a chiudere occhio per le punture delle moleste zanzare locali. Una presenza che sarebbe diventata costante per tutta la durata della sua permanenza in Egitto.
I primi giorni di navigazione furono caratterizzati da un’assoluta mancanza di vento, tanto che l’equipaggio fu impegnato ai remi per la maggior parte del tempo. Il paesaggio circostante era caratterizzato da un susseguirsi di rilievi e campi di mais, interrotto di tanto in tanto da miseri villaggi di fango essiccato al sole e da fitti boschetti di palme. La mattina del 9 ottobre l’imbarcazione approdò a Beni Suef dove era in corso il mercato. Roberts non si lasciò sfuggire l’occasione per vagabondare tra la folla attratto dalla pittoresca cornice formata soprattutto da donne che indossavano abiti color indaco lunghi fino ai piedi e portavano sulla testa cesti colmi di frutta o gabbie contenenti piccioni, mentre gli uomini erano alle prese con greggi di pecore e capre. L’indomani si fece scalo nella località che allora si chiamava Sheikly, l’antica Cynopolis. Da qui, l’artista decise di proseguire a piedi fino alla vicina Onaseh. Durante il percorso rimase colpito dal fatto che i locali non erano soliti seppellire i morti (probabilmente a causa delle piene del Nilo che avrebbero allagato le tombe), ma deponevano le spoglie in piccoli loculi di mattoni crudi. L’azione devastatrice del tempo aveva, però, avuto ragione di quei miseri ricoveri, sicché il panorama era costellato da un macabro biancheggiare di scheletri talora avvolti da ciò che restava dei paramenti funebri. Trascorse la notte a Minieh (l’odierna el-Minya) e il giorno successivo proseguì la navigazione, tra splendidi scenari, fino a Beni Hasan, distante una ventina di chilometri, dove Roberts fece alcuni schizzi delle antiche vestigia. Le tombe rupestri di questo sito, traggono il nome da una tribù araba che occupava villaggi nel territorio limitrofo, attualmente del tutto abbandonati e caduti in rovina.
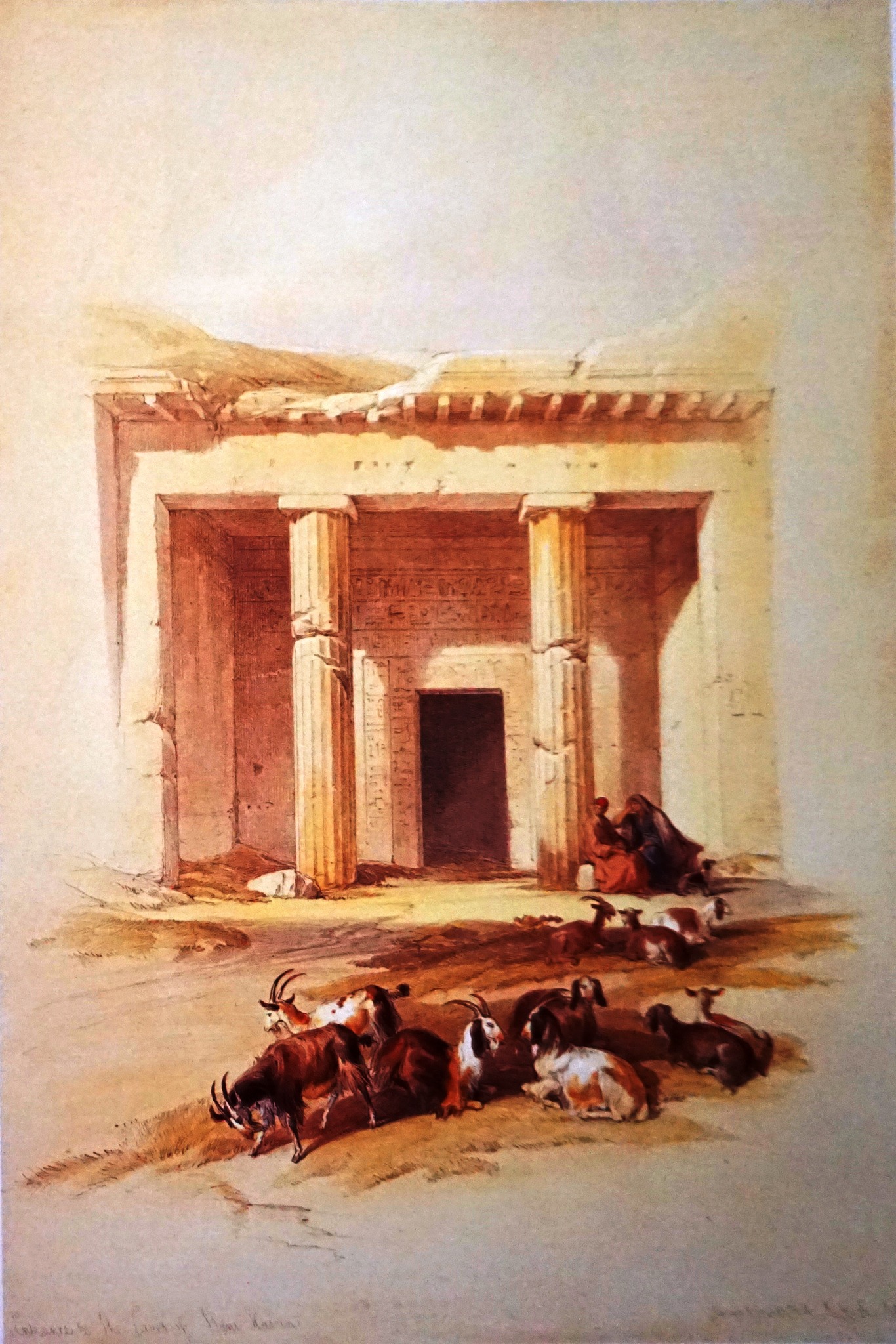
Immagine n. 1 Dal diario di David Roberts, 11 ottobre: << La tomba principale ha due colonne doriche in facciata ed è interamente ricoperta di geroglifici; all’interno, in una nicchia vi sono i resti di una statua di grandi dimensioni e di altre due più piccole, scolpite nella viva roccia. Altre tombe sono scavate nelle pareti rocciose che si innalzano sulla riva sinistra del Nilo; quasi tutte sono allineate alla medesima altezza. Ognuna dispone di un pozzo o di una profonda cavità, perpendicolare al pavimento o molto inclinata>> (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pag. 39)
La necropoli fu scavata durante il Medio Regno ed è considerata di enorme interesse sia per le soluzioni architettoniche adottate, sia e soprattutto per le splendide decorazioni parietali, piene di scene di vita, che adornano le tombe. Il sepolcro illustrato da Roberts è quello del nomarca Ammenemes* che presenta frontalmente due pilastri protodorici (Immagini n. 1 e 2).


* Ciò è quanto recita il testo. Dovrebbe quindi trattarsi di Amenemhat, nomarca e comandante in capo del “nomo” dell’orice sotto il regno di Senwosret (Sesostri) I – 1971-1925 a.C. – XII dinastia. Personalmente, ho qualche dubbio che la tomba ritratta sia quella, in quanto immagini del sito di Beni Hassan, mostrano chiaramente che le colonne della facciata presentano otto spigoli (Immagine n. 3), invece quella illustrata da Roberts ne presenta sedici.
Il Tempio di Luxor: prima tappa, 20-23 ottobre 1838
Lasciata Dendera, Roberts si rimise in viaggio il 20 ottobre. La mattina del giorno successivo, una domenica, i due battelli che componevano la spedizione attraccarono a Goorna, dove prontamente furono affittati alcuni somari che avrebbero consentito l’escursione in direzione delle grandi necropoli tebane poste sulla riva occidentale del fiume. Qui, nella piana dominata dalla “Cima Tebana”, la montagna sacra alla dea Mertseger, (lett. Colei che ama il silenzio) furono scavate le eterne dimore di faraoni e spose reali, principi, principesse, funzionari e cortigiani. L’artista fu particolarmente colpito dal tempio funerario di Ramses II, all’interno del quale giacevano i resti di una colossale statua monolitica del celebre sovrano. Il lunedì mattina avvenne la visita alla Valle dei Re. La presenza di alcune tombe incompiute fornì a Roberts il pretesto per studiarne le tecniche costruttive e i metodi utilizzati dagli antichi decoratori. Dal suo diario apprendiamo che dopo la faticosa giornata, la serata fu allietata dall’esibizione di alcune giovani ballerine “molto eleganti e graziose”. In particolare, lo scozzese fu colpito da un’ altissima fanciulla dalla pelle color ebano, i cui lineamenti gli apparvero come i più espressivi che avesse mai visto.
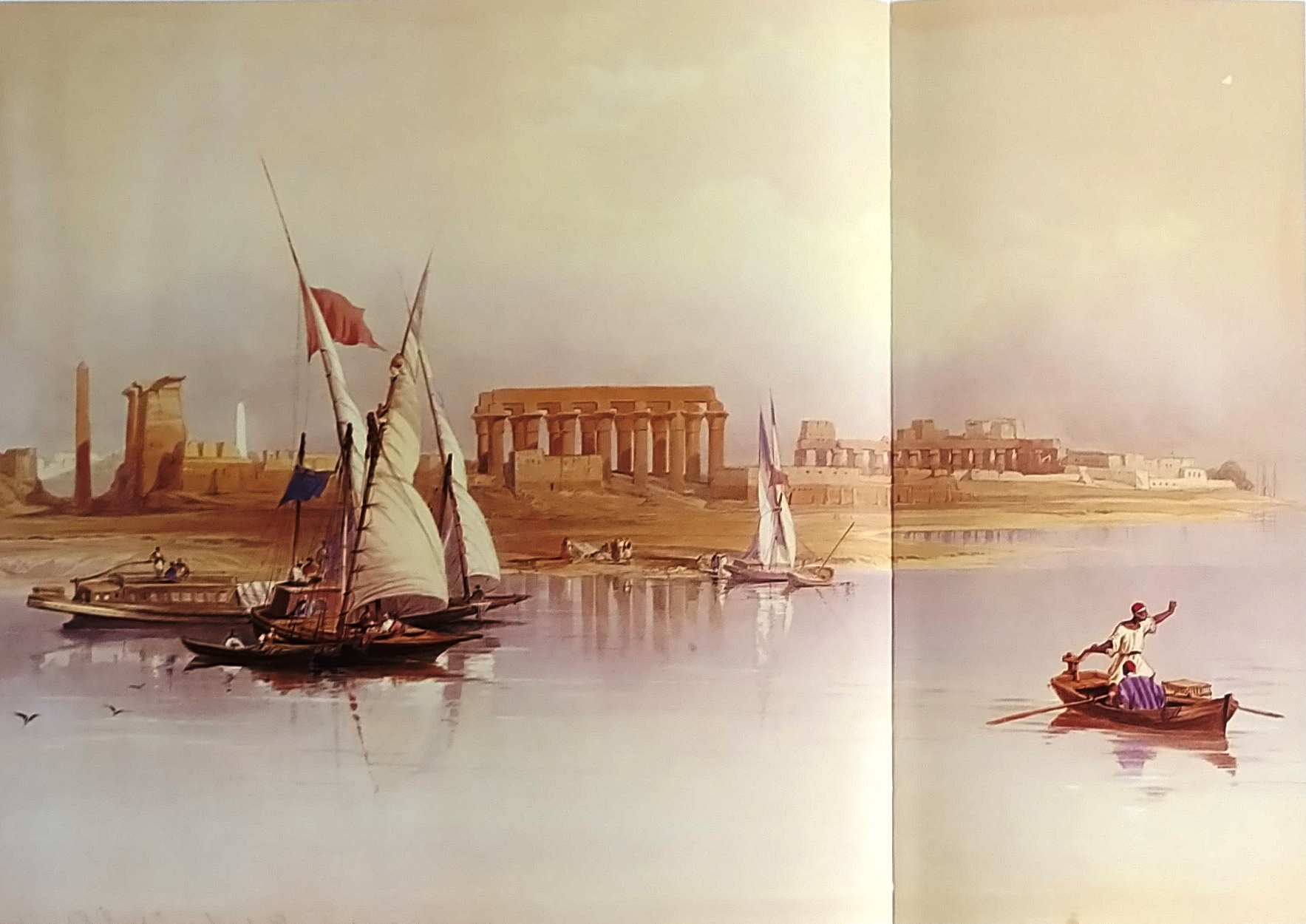
Il giorno 23, finalmente avvenne la visita delle spettacolari rovine di Luxor, che lo avrebbero lasciato letteralmente senza fiato. Dalle note riportate sul suo diario traspare chiaramente come le dimensioni del complesso finirono per ossessionarlo. Trascorse ore a misurare colonne, capitelli, rilievi e mura in un crescendo di stupore e ammirazione (Immagini n. 1 e n. 2). L’attuale città è solo una parte dell’ antica Tebe, che fu capitale dell’Egitto a più riprese durante il Medio ed il Nuovo Regno. Si sviluppò a partire da un primitivo nucleo urbano che, sorto in prossimità dell’odierna Karnak, conobbe una rapida ed enorme espansione. Dell’immensa metropoli era protettore il dio Amon che, associato a Mut e Khonshu a costituire la cosiddetta “Triade Tebana”, fece di Wast (è questo il nome egizio della città), durante tutto il Nuovo Regno (ove si eccettui la breve parentesi “amarniana”) e grazie alla mastodontica organizzazione del suo Tempio, il massimo centro politico e religioso del Paese.

Da Luxor a File, 23 ottobre -1 novembre 1838: Elefantina, File
Il pomeriggio del 23 ottobre la spedizione lascia Karnak, diretta alla volta di Assuan, dove giunge sei giorni più tardi, dopo aver fatto tappa nelle località di maggior interesse storico. Il 24 visitò le rovine di Hermontis e successivamente si trattenne alcune ore a Esna per ammirare il Tempio di Khnum. Il giorno successivo lo dedicò ad un’escursione nella piana attorno alla città di Eilathia ed il 26 volle spingersi fino ad Edfu, il cui tempio lo entusiasmò sia per le dimensioni, sia per la magnifica raffinatezza dei suoi bassorilievi, mentre Il 28 era a Kom Ombo. Come di consueto, Roberts prese appunti e redasse accurate descrizioni di ogni monumento che avrebbe poi riccamente illustrato, durante le soste effettuate nel viaggio di ritorno dalla Nubia. Il giorno 27 lo trascorse a bordo annotando nel suo diario le impressioni relative al paesaggio circostante. Il 29 ottobre giunge ad Assuan, (la Syene dai greci), celebre sin dai tempi più remoti per le sue cave di granito, situata all’altezza della Prima Cataratta del Nilo, laddove il fiume si ramifica e appare costellato da una miriade di scogli. Tutta la zona era già abitata in epoca predinastica e dalla I Dinastia con il nome di Abw o Yebu (Città dell’Elefante), fu capitale della “Terra degli Archi”, il primo nomo dell’Alto Egitto. Più tardi questa definizione passò alla sola isola di Elefantina e alla città che vi era sorta in posizione strategica. Roberts vi si fece traghettare, ma ne riportò una certa delusione nel constatare che delle antiche rovine erano rimaste solo poche misere vestigia (Immagine n. 1).

La mattina del 30 ottobre, Roberts e i suoi compagni d’avventura, si diressero, a dorso d’asino verso sud alla ricerca di qualche barcaiolo che potesse traghettarli sull’isola di File ove sorgevano le superbe rovine del grande santuario dedicato a Iside. L’isola fu descritta dall’artista come un angolo di paradiso nel mezzo di una desolazione sconfinata, ma ad impressionarlo vivamente fu più di ogni altra cosa il magnifico splendore del tempio. Il giorno successivo fervevano già i preparativi per la risalita della Prima Cataratta, impresa che si rivelò alquanto laboriosa e che richiese l’intera giornata del 1° novembre. L’artista decise, perciò di impiegare il suo tempo a File ove ritrasse il cosiddetto “Letto del Faraone” definendolo “tempio ipetrale”, perché sprovvisto di tetto. In realtà questo padiglione fu fatto erigere da Traiano nel 105 d.C. destinandolo a ricovero della barca sacra di Iside durante le processioni ai templi nubiani meridionali. La struttura, di grande eleganza, si presenta come un chiosco quadrilatero munito di 14 colonne chiuse in basso da muri intercolumnari. I capitelli sono di tipo floreale e di forma diversa. Gli inconsueti dadi che li sormontano, probabilmente avrebbero dovuto essere scolpiti con l’effigie della dea Hathor. Nonostante sia rimasto incompiuto questo monumento è diventato il simbolo stesso di File e resta il miglior esempio di gusto e abilità egizia in epoca romana (Immagine n. 2) . L’appellativo “Letto del Faraone” fu coniato a seguito di un’errata ipotesi di antica origine che supponeva che in questo luogo risiedessero i sovrani d’Egitto durante le loro visite al grande santuario.

Anche per quanto riguarda File, questa fu solo la prima e breve sosta di Roberts. L’artista vi si soffermerà più a lungo di ritorno dalla Nubia tra il 17 e il 19 novembre e in tale occasione realizzerà una serie di splendide illustrazioni.
Il tempio di Uadi Debod, 2 novembre 1838
La mattina di venerdì 2 novembre, Roberts e i suoi compagni di avventura approdarono nei pressi di Uadi Debod, circa 25 Km. a sud della Prima Cataratta del Nilo, ove sorgeva un piccolo tempio dalle proporzioni molto eleganti (Immagini n. 1 e 2). Come nel caso di molti altri santuari nubiani, anche questo non fu mai portato a termine, come dimostrano le due colonne esterne in facciata non rifinite. La loro superficie scabra e i capitelli appena sbozzati convinsero l’artista che gli artigiani egizi scolpissero i geroglifici e i particolari più minuti delle decorazioni solo dopo aver assemblato i vari blocchi di pietra nella giusta posizione. La parte più antica del tempio fu eretta tra il 195 e il 185 a.C. dal re Adikhalamani, sovrano di Meroe, nell’odierno Sudan, che lo dedicò al dio Amon. Durante il secolo successivo, venne riconsacrato alla dea Iside e più volte ampliato da Tolomeo VI e Tolomeo VIII. La costruzione dell’ala sinistra e l’aggiunta della facciata scandita dalle quattro grandi colonne si devono, invece agli imperatori romani Augusto e Tiberio che si fecero ritrarre sui muri intercolonnari con gli attributi tipici degli antichi faraoni.

Allo stesso modo dei più famosi templi di Abu Simbel o di File, anche il tempietto di Uadi Debod rischiò di essere sommerso dalle acque del lago Nasser originatosi dalla costruzione della Grande Diga di Assuan, ma fu risparmiato grazie all’impegno dell’UNESCO che smontò la costruzione e ne sistemò provvisoriamente le parti in un deposito. Più tardi il governo egiziano ne fece dono alla Spagna come segno di riconoscimento per l’aiuto prestato durante la campagna di salvataggio. Nel 1968 il monumento venne ricomposto su una collina a breve distanza da Madrid.

Dopo aver preso appunti e disegnato il sito, Roberts si diresse a piedi fino a uadi Kardassy dove si trovava un tempio simile a quello appena visto, ma l’imminenza del tramonto e l’urgenza di raggiungere Abu Simbel gli suggerirono, anche in questo caso, di rimandare al ritorno una visita più accurata.
Sul tempio di Debod sono disponibili ulteriori approfondimenti ai seguenti links del nostro sito:
- https://laciviltaegizia.org/2022/08/21/il-tempio-di-debod/(a cura di Francesco Alba)
- https://laciviltaegizia.org/2022/12/07/il-tempio-di-debod-2/
Il tempio di Dendur, 3-4 novembre 1838
Dopo essersi trattenuto alcune ore a Kalabasha, un villaggio sulla riva occidentale del Nilo nelle cui vicinanze sorgeva uno splendido tempio, Roberts riprese la navigazione durante la notte tra il 3 e il 4 novembre, prendendo terra a giorno ormai inoltrato in prossimità della località di Dendur. Come lui stesso appuntò nel suo diario, il tempietto che ebbe l’occasione di osservare avrebbe potuto apparirgli ben poca cosa in confronto ai grandiosi edifici ammirati sino a quel momento. Tuttavia, il monumento conservava un notevole valore storico esendo stato costruito da Augusto in onore delle divinità locali Peteese e Pihor. L’imperatore romano, fu profondamente attratto dalla cultura egizia e questa sua predilezione, condivisa anche da molti suoi successori, fece nascere a Roma una vera e propria moda che si spirava ai modelli dell’arte faraonica. Infatti, anche dopo la sua morte, una delle caratteristiche salienti del dominio romano in Egitto rimase il profondo rispetto per i canoni costruttivi ed estetici locali.
Nella tavola illustrata dall’artista è curiosa la presenza di alcuni personaggi intenti a misurare la facciata del tempio, tra i quali uno di essi è abbigliato all’occidentale. E’ probabile che Roberts abbia voluto immortalare se stesso assieme al fedele Ismail e ad alcuni altri membri dell’equipaggio (Immagine n. 1).
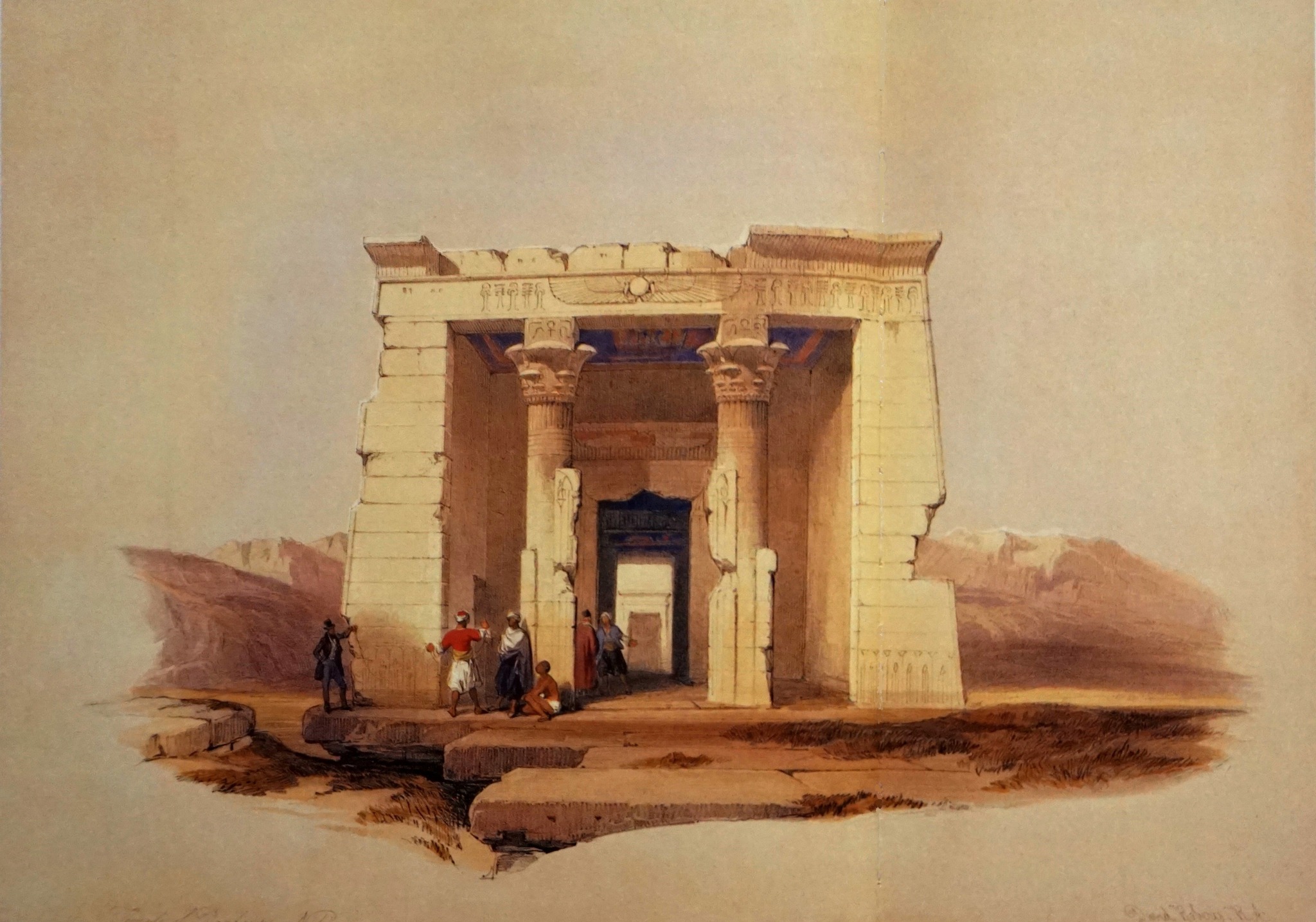
Anche il tempio di Dendur era destinato a essere sommerso dalle acque del Lago Nasser per cui, per iniziativa dell’UNESCO, nel 1963 fu smontato e donato dall’Egitto agli Stati Uniti. Oggi fa bella mostra di sé in un’apposita sala del Metropolitan Museum of Art di New York(Immagine n. 2 e n. 3).

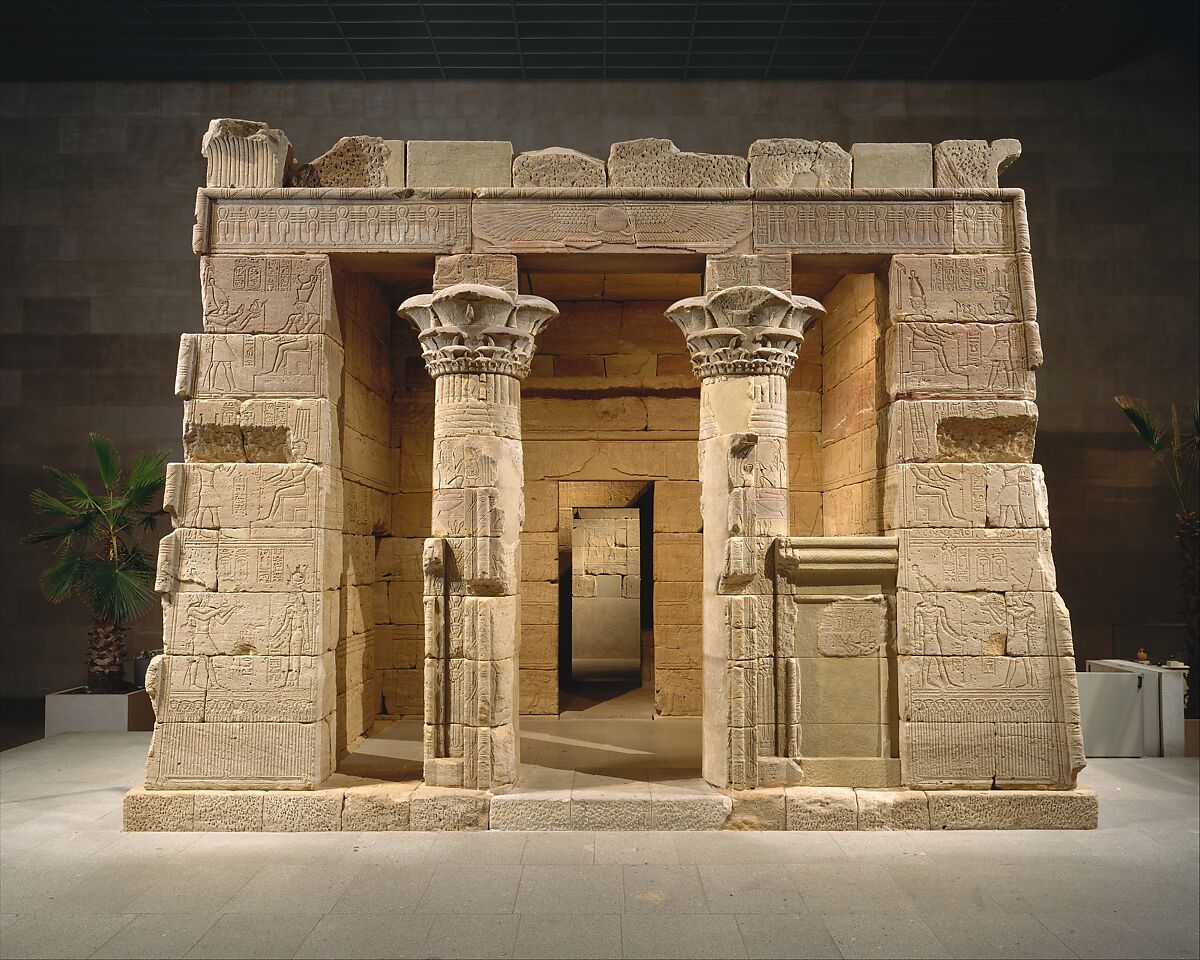
Il tempio di Uadi Sabua, 5-6 novembre 1838
La notte tra il 4 e il 5 novembre fu trascorsa in navigazione. L’imbarcazione passò accanto ai templi di Gyrshe e Dakke e all’alba si approssimò all’isola di Derar, che fu descritta da Roberts come intensamente coltivata. Con l’avanzare del giorno il sole andava ad illuminare distese di sabbia scintillante dalle quali, ad un certo punto, si profilò la sagoma del tempio di Maharraqa. L’artista vi fece sosta per dedicare una breve visita al complesso di epoca romana, dal quale rimase vivamente impressionato. Il giorno successivo fu caratterizzato da un’assoluta bonaccia che rallentò la navigazione al punto che le maestose rovine di Uadi es-Sebua furono raggiunte solo all’alba del 6 novembre.
L’edificio fu eretto da Ramses II e dedicato ad Amon e Ra-Harakhty. Lo stesso faraone vi si fece venerare ed il tempio era conosciuto come “la casa di Ramses-Meryamon nel dominio di Amon”; sfingi e statue, poste dinanzi al pilone, avevano infatti, le sembianze del sovrano divinizzato. Nel suo diario, Roberts annotò che la caratteristica più spettacolare del complesso era il lungo dromos (un viale fiancheggiato da una serie di sfingi, e preceduto da due colossali statue del faraone) che conduceva al tempio. Fu proprio la presenza di queste sfingi a suggerire alle genti del posto il nome moderno del sito che significa appunto “Valle dei Leoni”. Le tavole che ne ricavò Roberts sono di alto valore documentario dal momento che la maggior parte delle sculture, purtroppo, è andata perduta (Immagini n. 1 e n. 2).

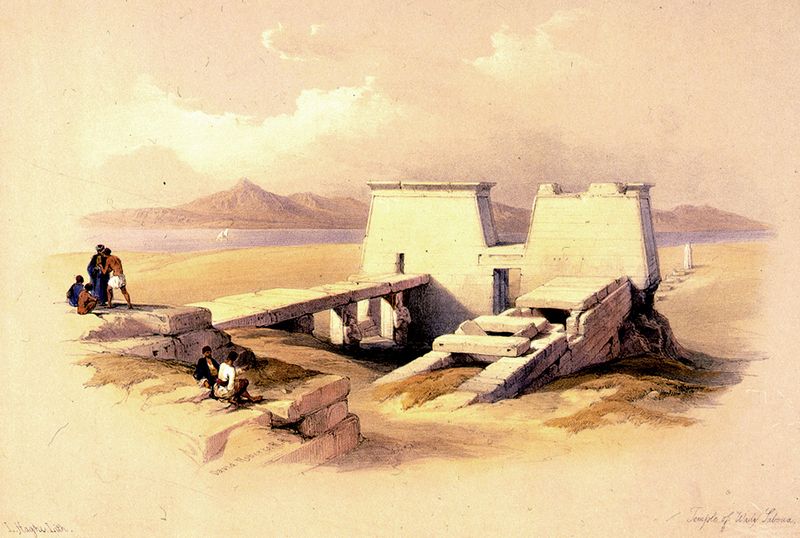
L’ingresso del tempio è costituito da un pilone in arenaria rossastra alto 20 metri preceduto, un tempo, da due colossali statue di Ramses II delle quali solo una oggi è al suo posto. Attraverso il portale centrale, ornato di bassorilievi raffiguranti il sovrano che offre sacrifici agli dei, si accede al cortile delimitato su due lati da portici con cinque pilastri ciascuno, a cui sono addossate altrettante enormi statue del faraone. Le pareti sono decorate con bassorilievi che raffigurano le consuete scene di offerta. Dal cortile, attraverso una scala, si accede ad una stretta terrazza sulla quale si apre l’ingresso alla sala principale, che fu trasformata in chiesa in epoca cristiana e gran parte dei bassorilievi ricoperti da affreschi. A questo grande ambiente, coperto solo in parte da un soffitto sorretto da pilastri, segue una sala, comunicante con diverse stanze, disposta trasversalmente e scavata interamente nella roccia. Anche in questa parte del complesso sono visibili numerosi rilievi raffiguranti Ramses II intento a porgere offerte agli dei e alla sua stessa immagine divinizzata. Dalla parete di fondo si dipartono tre cappelle di cui quella centrale era il “naos” vero e proprio. Tra le immagini presenti sulle pareti, alcune rappresentano il sovrano che reca fiori alla barca solare di Ra-Harakhty, ornata di teste di falcoe a quella di Amon, ornata di teste di ariete. In una nicchia sono presenti statue delle tre divinità venerate nel tempio, che sfortunatamente furono malamente danneggiate dai primi cristiani.
Quando Roberts giunse a Uadi Sabua, la parte ipogea non era accessibile in quanto ostruita da un’enorme massa di sabbia. L’artista notò che il materiale friabile di cui era costituito l’edificio mostrava evidenti segni di erosione e molti blocchi apparivano sconnessi, probabilmente in conseguenza di movimenti tellurici.
Questo maestoso tempio, che tanto impressionò Roberts, ha seguito la stessa sorte di tanti altri monumenti nubiani: fu smontato in grossi blocchi numerati e ricomposto più tardi a circa quattro chilometri dal luogo di origine in una località denominata Nuova Sebua prospiciente le sponde del bacino artificiale (Immagine n. 3).

Due statue colossali di Ramses II nel tempio di Uadi Sabua, 6 novembre 1838
Alla fine del lungo dromos di accesso al tempio, due statue di dimensioni enormi erano poste a guardia del pilone; altre due si trovavano all’inizio del viale e raffiguravano Ramses II con il copricapo e gli emblemi di Osiride. Solo il colosso che Roberts ritrasse in piedi ci è pervenuto: gli altri sono stati trafugati oppure sono andati distrutti. La statua rappresenta il faraone con il simbolo di Amon-Ra, un lungo bastonealla cui sommità è presente una testa di ariete sormontata dal disco solare e dall’ureo, il sacro cobra emblema della luce e della regalità. L’acconciatura è quella tipica della moda nubiana: capelli raccolti in piccole trecce, una fascia sottile attorno al capo e l’ureo sulla fronte (immagini n. 1 e n. 2).

Fra i templi nubiani, quello di Uadi Sabua è l’unico ad aver conservato, sia pure solo parzialmente, il suo dromos. In origine, prima che il monumento venisse ricomposto nella nuova sede, più alta di circa sessanta metri rispetto a quella originaria, questo viale conduceva direttamente dalla sponda del Nilo all’edificio.

Roberts si trattenne a Uadi Sabua per tutta la giornata del 6 novembre 1838, intento a misurare e disegnare in dettaglio le rovine del sito. Il mattino seguente riprese il suo viaggio verso Abu Simbel.
La Fortezza di Ibraim ed Il tempio di Amada ad Hassaya, 11-13 novembre 1838
La mattina del 7 novembre 1838, l’equipaggio approdò nei pressi di Kosocko, una cittadina dall’aspetto ameno, dove fu trascorsa l’intera giornata. Al calar del sole riprese la navigazione e, alle prime luci del giorno successivo, apparvero le suggestive rovine della Fortezza di Ibrim, che Roberts si ripropose di visitare sulla via del ritorno, preso com’era dalla smania di raggiungere Abu Simbel, ormai vicina. All’imbrunire erano in vista dell’agognata meta; l’oscurità incedente, consigliò loro di concedersi qualche ora di sonno. All’alba di venerdì 9 novembre 1838, David Roberts era finalmente al cospetto dei sensazionali templi rupestri*.
L’ 11 novembre 1838, al calar della sera, lasciata Abu Simbel, si cominciò a ridiscendere la corrente del Nilo. Poche ore più tardi avvenne l’approdo nei pressi della Fortezza di Ibrim ove si fece sosta fino al giorno 12. Roberts ne approfittò per visitarla e ritrarla (Immagine n. 1). Le origini della roccaforte risalivano all’epoca della dominazione romana, quando il luogo era conosciuto con il nome di Primis e costituiva una delle postazioni più rilevanti dell’intera Nubia grazie alla sua posizione strategica a guardia dei traffici sul Nilo. Nel XVI secolo ospitò il contingente bosniaco che il sultano Selim I aveva incaricato della conquista della regione. Nel 1812 fu occupata dai Mamelucchi messi in fuga dall’esercito di Ibrahim, che ne riprese il possesso e la distrusse. I maestosi resti della fortezza giacciono oggi sommersi dalle acque del lago Nasser, pertanto il valore documentario dell’opera di Roberts assume un valore straordinario
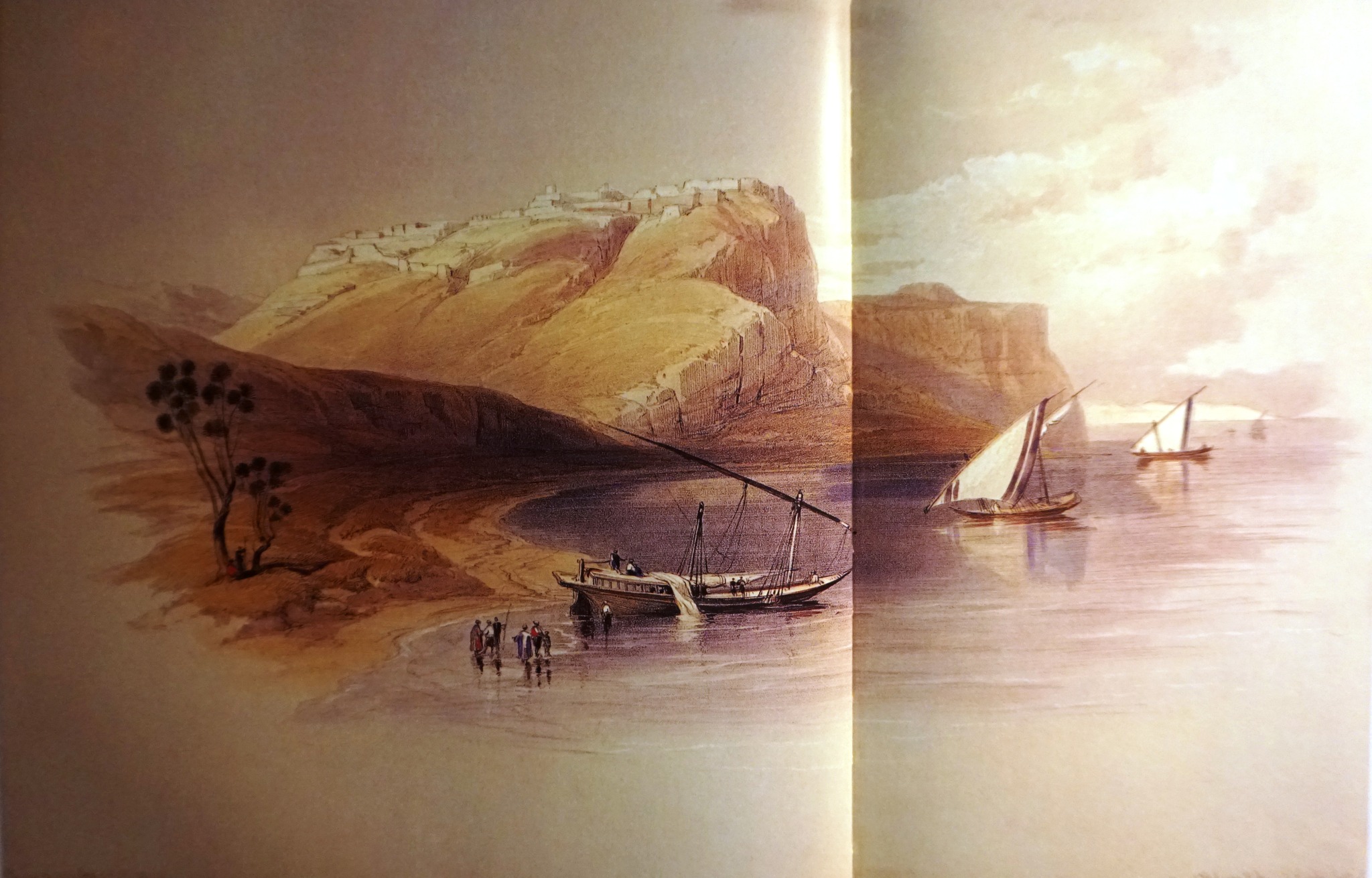
Ripresa la navigazione, nel corso della notte tra il 12 e il 13 novembre il battello giunse a Derr, la capitale della Nubia, che fu descritta da Roberts come una grande città le cui abitazioni erano meglio costruite e più pulite rispetto a quelle del Basso Egitto.
In particolare, l’artista fu colpito dal fatto che gli edifici presentassero dei muri inclinati verso l’interno in modo che assumessero l’aspetto di una piramide tronca e, curiosamente, dalla presenza di un sicomoro di proporzioni gigantesche che troneggiava nel centro del capoluogo. Poco distante sorgeva un piccolo tempio rupestre che trovò il tempo di visitare, ma non ritrasse a causa del suo aspetto assai modesto. Decise allora di recarsi, il giorno successivo, nei pressi di Hassaya, prefiggendosi come meta il santuario di Amada. Si ritrovò di fronte ad un edificio parzialmente sepolto dalla sabbia e circondato da diverse casupole ormai completamente in rovina. Inoltre, il pronao si presentava sovrastato da una goffa cupola di fango e paglia che, quasi sicuramente, fu eretta quando il tempio fu trasformato in una chiesa cristiana. Fondato da Thutmose III, proseguito da Amenhotep II e Thutmose IV, che vi aggiunse una sala ipostila a 12 pilastri, il santuario non vanta dimensioni imponenti, ma colpisce per le proporzioni assai eleganti e per la presenza di rilievi di raffinatissima fattura. In epoca faraonica la località era nota col nome di “Netcer-hwt-Ra-Harakhte” vale a dire “La casa divina di Ra Horakhty”.
Anche questo tempio era destinato ad essere sommerso a causa della costruzione della diga di Aswan, ma durante la campagna di salvataggio dei monumenti nubiani venne interamente racchiuso in un intelaiatura di acciaio e cemento del peso di circa novecento tonnellate e quindi spostato, grazie ad una ferrovia a cremagliera, nel nuovo sito posto a circa tre chilometri di distanza e più alto di 60 metri (Immagini nn. 2-3).
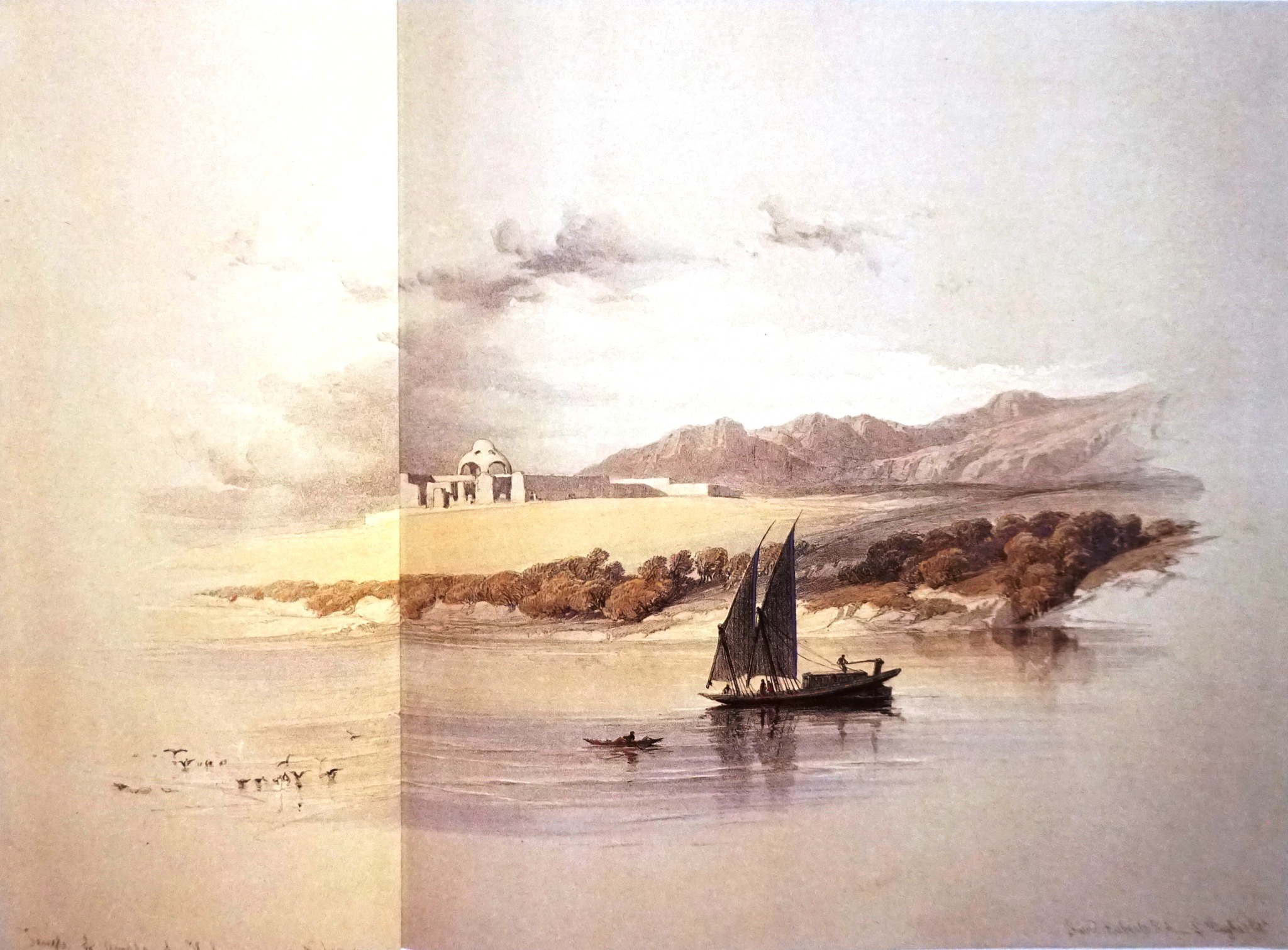
E’ osservabile nella litografia, la brutta e sgraziata cupola di fango e paglia aggiunta presumibilmente in epoca cristiana. (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pag. 81).

Immagine n. 3 Un interno del tempio così come appare oggi dopo lo spostamento che ne ha permesso il salvataggio dalla sommersione. E’ chiaramente leggibile, nel cartiglio il nome di Thutmose III (ḏḥwti-msi(w), Thot è nato). (Fonte, Wikipedia , © ph. Dennis G. Jarvis)
Il tempio di Wadi Maharraka 14 Novembre 1838
Dopo aver trascorso l’intera notte in navigazione, Roberts raggiunse il tempio di Maharraka, presso il quale si era già fermato dieci giorni prima, nelle prime ore del giorno 14. All’epoca l’edificio si presentava in stato di forte degrado, però delle sedici colonne della corte interna quattordici si ergevano ancora nella loro posizione. Siccome i capitelli si presentavano appena sbozzati e le decorazioni erano quasi completamente assenti, l’artista dedusse che l’edificio, era rimasto incompiuto a causa dell’affermarsi del Cristianesimo nella regione; inoltre numerosi affreschi di soggetto biblico, ancora visibili, attestavano inequivocabilmente che il tempio, originariamente dedicato a Iside e Serapide, era stato trasformato in una chiesa. L’edificio sorgeva nell’antica città di Hierasykaminos, la “Città del sicomoro sacro” che segnò il confine più meridionale dell’Impero Romano dal 23 a.C al 297 d.C. La presenza, nell’angolo nord-orientale, di una scala a chiocciola che conduce al tetto del porticato costituisce un unicum nell’architettura egizia. L’unica spiegazione possibile è che il monumento fu progettato quasi sicuramente da un architetto romano.
Anche questo tempio, che era stato già interessato da un restauro nel 1908, fu smontato durante la campagna di salvataggio dei monumenti nubiani e ricostruito (Immagini n.1 e n.2).

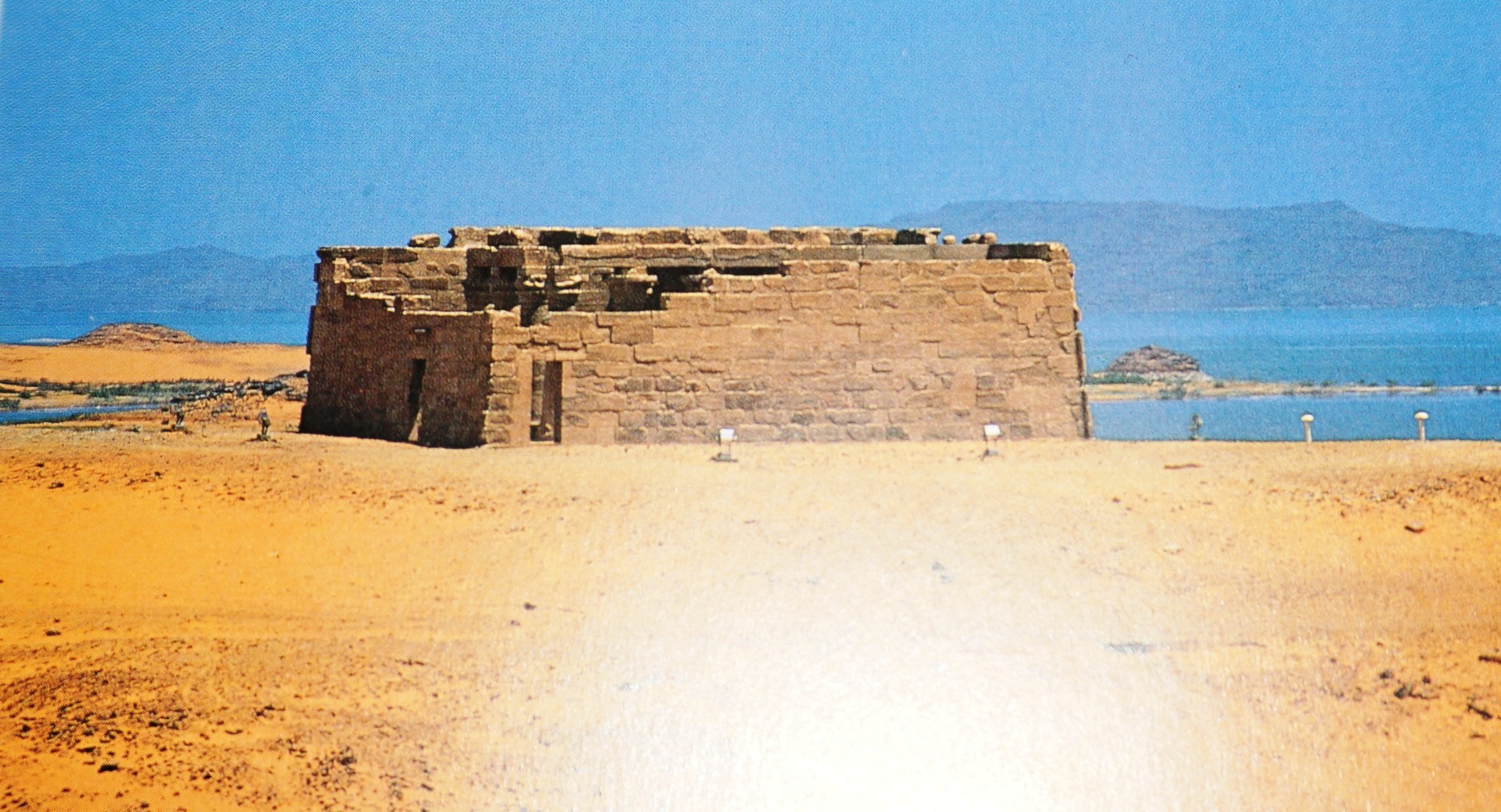
Il tempio di Dakke, 14 Novembre 1838
Il primo pomeriggio del giorno 14 fu trascorso nella vicina località di Korti, ove il battello aveva fatto scalo. Roberts, ne approfittò per ritrarre alcune scene aventi per soggetto ragazze nubiane intente al trasporto dell’acqua e un gruppo di schiavi abissini, per lo più giovani donne che, al riparo di qualche stentata palma, attendevano di essere condotti al mercato del Cairo.
A sole due ore di marcia da Korti giacevano le splendide rovine del tempio di Dakke (Immagini n. 1 e n. 2), un autentico gioiello di architettura e scultura, che Roberts si affrettò a raggiungere prima del tramonto. Di dimensioni piuttosto contenute, ma di grande equilibrio formale era consacrato al dio Thot di Pnubs, una città etiope che i greci chiamarono Paotnuphis. L’edificio, diversamente dagli altri templi nubiani è orientato da nord a sud e fu fondato alla fine del III secolo a.C. per volere del re kushita Arqamon (Arkamani) e del faraone macedone, suo contemporaneo, Tolomeo IV Filopatore. In seguito Tolomeo VII vi aggiunse il pronao e durante il dominio romano fu edificato il grande pilone, inserito nella cerchia muraria esterna (oggi quasi del tutto scomparsa). Sulle facciate anteriori delle due torri sono visibili alcuni rilievi e numerose iscrizioni in greco e in demotico lasciate da antichi visitatori. E’ evidente che la pessima abitudine di lasciare una propria traccia sui monumenti ha radici assai remote!

Il colonnato, che in origine sorgeva tra il pilone e il pronao è andato completamente perduto, mentre la parte posteriore del tempio si è ben conservata.
Anche questo tempio dovette essere smontato in seguito alla costruzione della Diga di Assuan e fu ricostruito a Nuova Sabua. Nel corso dei lavori si scoprirono alcuni blocchi, evidentemente di riutilizzo, che erano appartenuti ad un edificio molto più antico, risalente all’epoca della regina Hatshepsut (circa 1479-1457 a.C., XVIII Dinastia) e dedicato a Horus di Baki. Questa città, dalla quale partivano le piste per le miniere d’oro di Umm Garayat, è oggi sommersa sotto le acque del lago Nasser.

Il tempio rupestre di Gyrshe, 15 Novembre 1838
Partito da Dakke a tarda sera, Roberts giunse a Gyrshe, una località oggi nota col nome di Gerf Hussein, quando ormai era notte inoltrata. Al sorgere del sole si mise in marcia verso un’altura ove sorgeva un tempio rupestre scavato all’epoca di Ramses II. La descrizione del luogo e la relativa litografia, costituiscono un’eccezionale e drammatica testimonianza di questo monumento. Infatti il santuario di “Ramses-Meryamon nel Dominio di Ptah” (è questo il nome con cui era denominato in epoca faraonica) è andato perduto per sempre. Il cattivo stato di conservazione delle strutture portanti, la particolare friabilità della roccia e, non ultima, la mancanza di tempo, resero inattuabile il progetto di salvataggio da parte dell’UNESCO. Così, a metà degli anni ’60 del secolo scorso il monumento scomparve sotto le acque del lago Nasser.
Il tempio era consacrato a Ptah, Hathor, Ptah-Tatjenen e a Ramses II divinizzato e fu costruito da Setau, viceré di Kush, il nome con cui era designata all’epoca l’Alta Nubia, in contrapposizione alla Bassa Nubia che era denominata Wawat. Molto più tardi i greci preferirono indicare l’intera regione come Etiopia.
Il monumento presentava un pronao a colonne che introduceva alla parte ipogea, profonda una trentina di metri. Qui si aprivano una sala ipostila (quella raffigurata dall’artista), una camera trasversale ed una cella che accoglieva statue di divinità. Roberts annotò che gli ambienti, caratterizzati dalla presenza di una moltitudine di pipistrelli, si presentavano fortemente degradati a causa dei fuochi accesi dai pastori che per secoli avevano utilizzato il tempio come riparo. La maggior parte dei rilievi e dei geroglifici erano ormai completamente indecifrabili, mentre la sala ipostila sorretta da sei colossali statue di Ramses II con la corona dell’Alto Egitto, aveva mantenuto ancora intatto il suo fascino.

Nella litografia (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pag. 91) è ritratta la sala ipostila con le sei colossali statue di Ramses II. E’ questa l’unica testimonianza visiva che abbiamo del tempio.
Dal Diario di David Roberts, 15 novembre <<Siamo giunti a Gyrshe la notte scorsa e questa mattina all’alba ero già sulla strada per la collina nella quale il tempio è scavato. A quanto pare, la salita in origine doveva essere una lunga scalinata, sui cui lati erano poste sfingi che ora giacciono tutt’attorno. Delle dodici colonne del portico ne restano in piedi solo due, poste a reggere una trabeazione che si proietta fuori dalla viva roccia. Nel tempio vi sono diverse stanze, statue colossali e decorazioni parietali, ma il tutto è molto danneggiato e le figure sui muri sono riconoscibili a stento.
Il tempio di Kalabsha, 15 Novembre 1838.
Appena terminata la visita al tempio di Gyrshe, Roberts si rimise in viaggio intenzionato a raggiungere Kalabsha prima di sera. In questa località l’artista si era già brevemente soffermato il 3 novembre dopo la visita al tempio di Uadi Debod. Approfittando della luce ancora sufficiente, lo scozzese ebbe tutto il tempo per completare due vedute del santuario delle quali, dodici giorni prima, aveva realizzato dei bozzetti già sufficientemente dettagliati. Il tempio, considerato come il più imponente monumento nubiano, dopo Abu Simbel, fu edificato in epoca tolemaica sulle fondamenta di uno molto più antico risalente all’epoca di Amenhotep II e consacrato al dio locale Mandulis in associazione a Iside ed Osiride. Fu ricostruito in epoca romana durante l’impero di Augusto, ma rimase quasi del tutto privo delle decorazioni. L’edificio, lungo 74 metri era collegato al Nilo da una strada processionale che saliva fino a raggiungere due vaste piattaforme poste su livelli diversi ed entrambe antistanti il pilone, la cui facciata non presenta rilievi. Le imponenti dimensioni si spiegano con l’importanza strategica della località, che all’epoca era nota con nome di Talmis. Trasformato successivamente in chiesa, l’edificio cadde completamente in rovina dopo la conquista araba.
Nella litografia, misere abitazioni di fango sembrano stringersi attorno alla massiccia mole del santuario, mentre altre sono visibili sul tetto del naos, formando una scenografia che era abbastanza frequente riscontrare nei siti archeologici egiziani durante il XIX secolo (Immagine n. 1).

Oltre il pilone, si apre un cortile circondato su tre lati da un portico, le cui colonne, all’epoca della visita di Roberts, erano in gran parte crollate e sepolte dai detriti. La parete di fondo è costituita dalla facciata dell’atrio, al centro della quale vi è un imponente portale. Seguendo i canoni dell’arte egizia d’epoca tolemaica (e successivamente romana), i vuoti tra le colonne sono parzialmente riempiti da transenne ricoperte di bassorilievi che raffigurano, tra gli altri, gli dei Thot e Horus che versano acqua lustrale sul sovrano. Una delle colonne presenta una lunga iscrizione in meroitico (la lingua parlata dai nubiani in epoca tolemaica e romana) che narra della vittoria del re Silko contro i Blemmi, suoi eterni nemici. L’epigrafe la ritroviamo, poi, sommariamente tradotta in greco su uno dei muri intercolumnari. L’interno dell’atrio è caratterizzato dalla presenza di dodici colonne, con capitelli a motivi vegetali, che sorreggevano il soffitto oggi, in gran parte crollato (Immagine n. 2).

Il sito ritratto da Roberts oggi non esiste più, sommerso come tanti altri dalle acque del lago Nasser.
Il tempio, invece, venne smontato tra il 1961 e il 1963 e ricostruito 40 chilometri più a sud in corrispondenza dell’estremità occidentale della Grande Diga, in una località che ha preso il nome di Nuova Kalabsha (Immagini nn. 3-4).

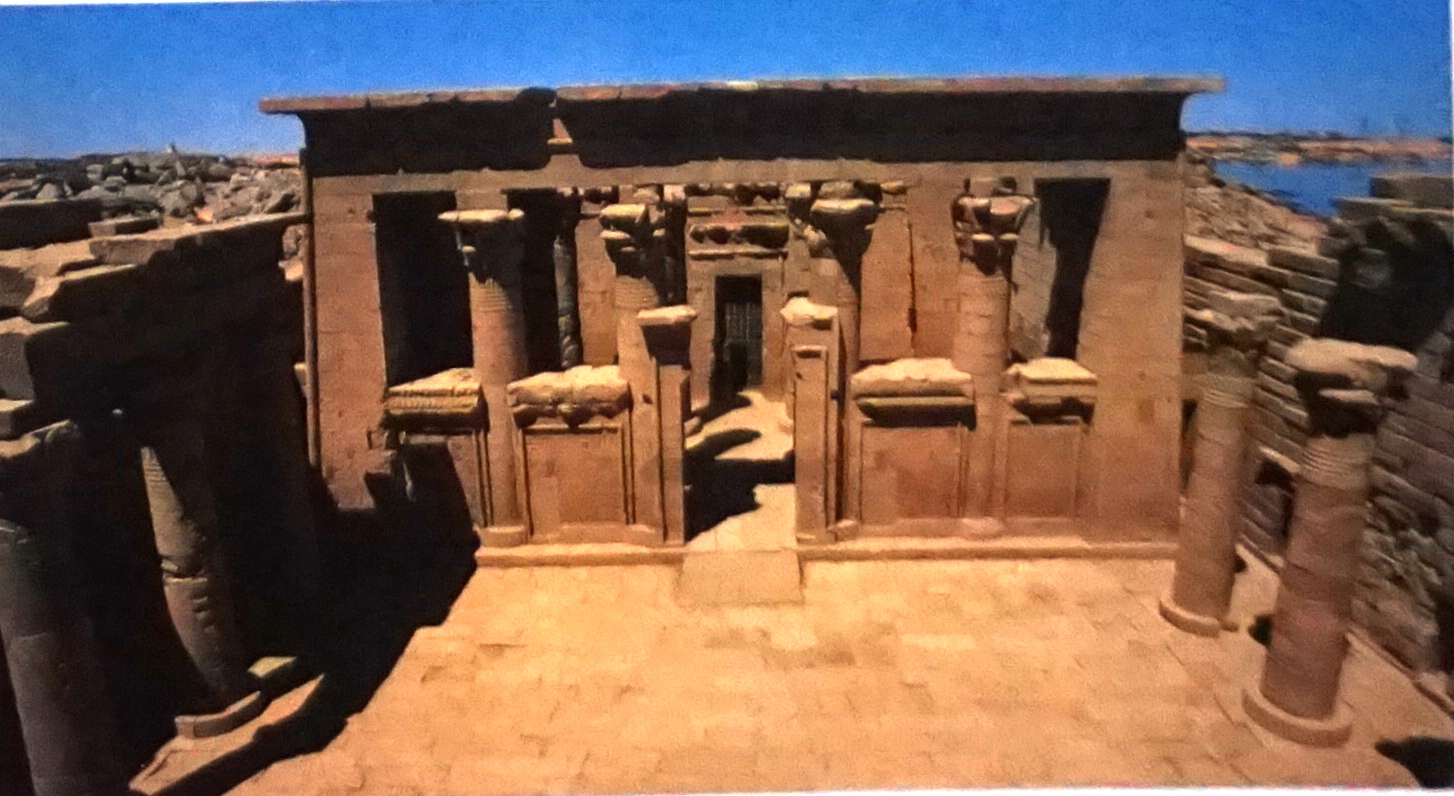
Il tempio di Tafa, 16 Novembre 1838.
Lasciata Kalabsha, Roberts si diresse verso Tafa (Taffeh) dove giunse la mattina del 16 novembre. In questa località, nei pressi di Uadi Kardassy, sorgevano due tempietti simili a tanti altri che aveva già ammirato nella regione. Per una fortunata circostanza l’artista scelse di ritrarre il tempio più danneggiato (Immagine n. 1). Infatti, mentre il piccolo tempio settentrionale (pressoché integro), fu offerto in dono ai Paesi Bassi, ed oggi è possibile ammirarlo all’interno del Museo Nazionale di Leiden (Immagine n. 2), quello meridionale fu completamente smantellato nel 1870 e utilizzato come cava di materiale di reimpiego.

Il santuario che costituiva, unitamente al suo vicino, il centro cultuale dell’insediamento romano di Taphis fu fondato in epoca tardo tolemaica ed ampiamente rimaneggiato durante l’occupazione romana della Bassa Nubia.

Il tempietto di Uadi Kardassy, 16 Novembre 1838.
Poco distante da Tafa era ubicata la località di Uadi Kardassy (Qertassi), che l’artista scozzese decise di raggiungere a piedi approfittando della giornata non particolarmente calda. Nel primo pomeriggio raggiunse il plateau roccioso sul quale sorgeva un piccolo chiosco molto simile nell’impianto a quello presente a File. L’edificio, posto in posizione dominante rispetto al corso del Nilo, costituiva uno degli scenari più suggestivi di tutta la Bassa Nubia (Immagine n. 1).

Il chiosco di Kardassy è un piccolo edificio, a pianta quadrata, di appena otto metri di lato. Fu fondato in epoca tolemaica e completato durante la dominazione romana. In origine presentava dieci colonne, delle quali solo sei sono rimaste in piedi, collegate da bassi muri intercolumnari. Quelle che inquadrano il portale sono sormontate da eleganti capitelli con il volto della dea Hathor che sostengono, a loro volta, altari stilizzati contenenti un aspide (Immagine n. 2), mentre le altre presentano capitelli con motivi floreali.
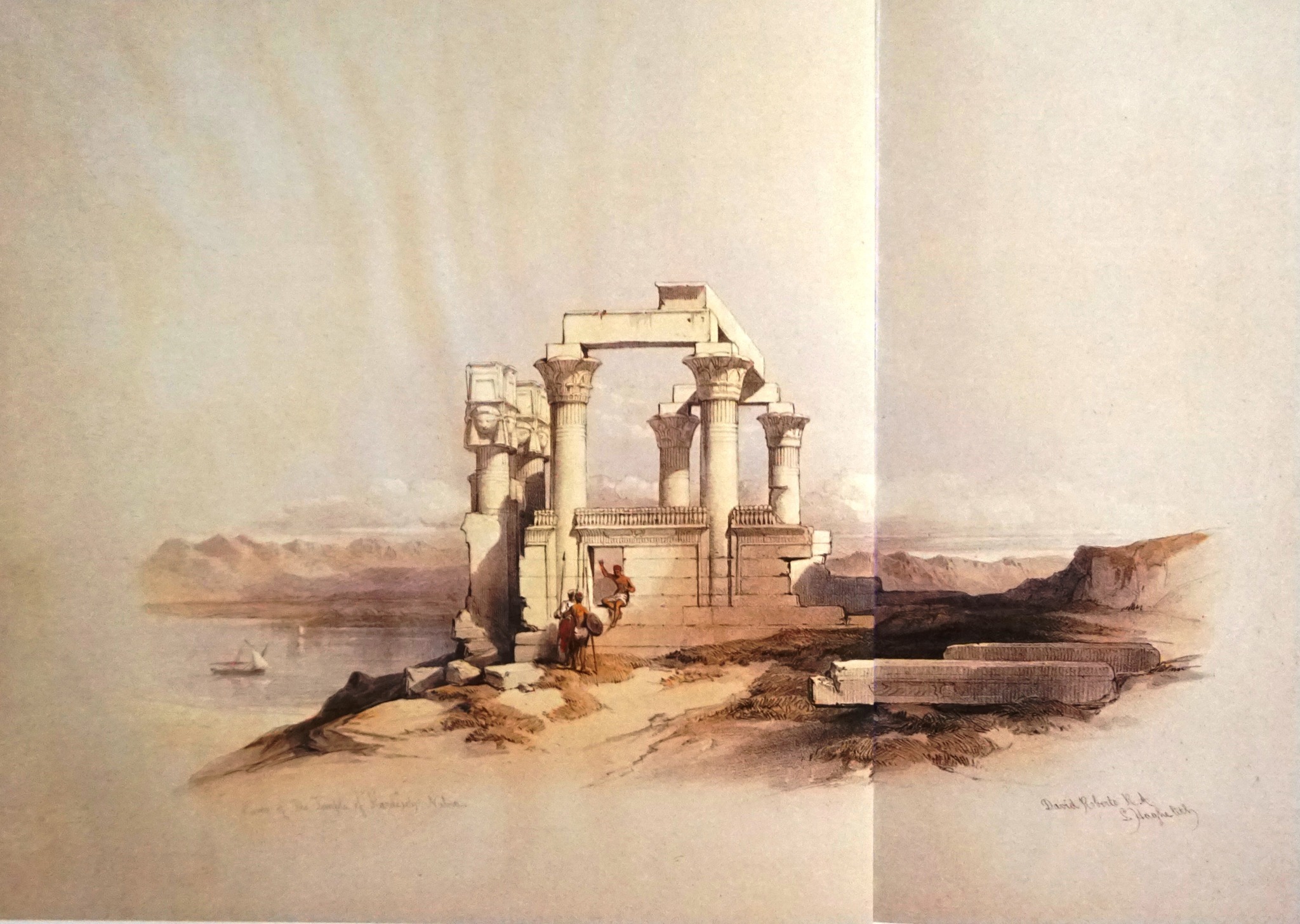
Come risulta evidente dalle litografie, a differenza di quello di File, rimasto incompiuto, questo edificio era coperto da possenti lastre monolitiche andate tutte distrutte. I muri tra le colonne sono spogli, ad eccezione della lunga sequela di urei che corona la fascia superiore e dei dischi solari alati sottostanti. Come attestano alcune croci scalpellate all’interno, il chiosco fu utilizzato come chiesa fino all’avvento dell’Islam.
Nei pressi, i legionari romani avevano costruito una fortezza a guardia dei traffici sul Nilo e delle vicine cave di pietra.
A seguito della costruzione della Diga Alta di Aswan, l’edificio fu smontato e ricomposto vicino al tempio di Kalabsha (anch’esso ricostruito) ad una quarantina di chilometri dal luogo d’origine. Purtroppo, la nuova ubicazione è assai meno spettacolare di quella antica (Immagine n. 3).

File, 17-19 novembre 1838
Sul far della sera, Roberts raggiunse nuovamente l’isola di File ove si fermò per due giorni per eseguire una serie di raffigurazioni dei templi che tanto lo avevano ammaliato meno di tre settimane prima. Le prime due tavole, qui descritte, ritraggono rispettivamente una magnifica veduta dell’intero complesso colto dall’alto della vicina isola di Bigeh e le rovine del tempio qui ubicato. Le tavole realizzate dall’artista costituiscono una preziosa testimonianza di quello che era l’aspetto dell’isola di File (o Philae, secondo la denominazione greco-romana), prima che la maggior parte delle strutture venisse trasferita sulla vicina isola di Agilka, distante circa 550 metri.
Il tempio che vediamo ritratto nella veduta generale (Immagini n. 1-2) era consacrato alla dea Iside e a suo figlio Harpocrate, una forma locale di Horus. Sorge sul luogo di un santuario precedente, il cui edificio più antico, del quale restano solo poche fondamenta, va fatto risalire al faraone nubiano Taharqa ( ? – 664 a.C. XXV Dinastia). Il primo sovrano, a cui sono attribuibili vestigia datate, è invece Nectanebo I (380-362 a.C. XXX Dinastia). Il complesso è costituito da elementi eterogenei e di epoche diverse, sebbene la maggior parte delle strutture risalga al periodo tolemaico-romano.

Immagine n. 1 All’estrema destra della litografia sono presenti il chiosco di Nectanebo ed il vicino obelisco, entrambi datati al IV secolo a.C. Di fronte ad essi si allungano le due ali del colonnato fatto erigere da Augusto. Attiguo al primo pilone è visibile il portale di Tolomeo II, evidente resto di un edificio precedente, mentre in secondo piano è raffigurato il chiosco di Traiano. Tra i due piloni si apre un ampio cortile il cui lato prospiciente il fiume è chiuso da un “mammisi” del quale si scorge la facciata posteriore. Sulla banchina, affacciato sul Nilo vi è il grande portale di Adriano.Oltre il secondo pilone, si sviluppa il tempio vero e proprio costituito da un atrio e dal “naos”, circondato da diversi ambienti secondari. In primo piano l’isola di Bigeh, con le rovine del suo tempio (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.106-107).

Nell’antichità nessuno, a parte i sacerdoti della vicina File, poteva calcare il suolo dell’isola di Bigeh (Immagine n. 3), sacra ad Hathor. In questo luogo, infatti si trovava il celebre Abaton in cui era stata sepolta una parte di Osiride, dopo che il suo corpo fu smembrato dal fratello Seth. Il tumulo, il cui nome deriva dal greco e significa grosso modo “luogo inaccessibile”, dimorava al centro di un boschetto e attorno ad esso erano disposti 365 altari sui quali ogni giorno, a rotazione, doveva essere versato del latte come offerta libatoria. In tal modo lo spirito vitale del dio, sotto forma di uccello, poteva nutrirsene *.

Ogni dieci giorni, dal vicino tempio di File, il simulacro di Iside veniva trasportato sull’isola a bordo di una barca affinché potesse far visita al consorte. Inoltre, una volta all’anno e nell’ambito di una festa solenne, la dea veniva affiancata nel suo pellegrinaggio dal figlio Harendotes (“Horus che difende il padre”).
* A tal proposito, a chi volesse saperne di più, consiglio caldamente la visione dell’interessantissima conferenza realizzata da Andrea Vitussi su YouTube e raggiungibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=NcY9wwRk1-U
File, 17-19 novembre 1838. I templi visti da sud.
Roberts fu completamente rapito dalla stupefacente suggestione determinata dalla scenografia che offriva il complesso di File, da qualsiasi angolazione lo si osservasse; si può ben immaginare quale fascino doveva suscitare nei pellegrini dell’epoca richiamati dall’esoterica devozione che nutrivano per la dea Iside. Questa divinità, figlia di Ra e sposa e sorella di Osiride, godeva di estrema popolarità e di una posizione privilegiata nel pantheon egizio in quanto, tra le altre sue caratteristiche, era a conoscenza di potenti sortilegi. Le sue arti magiche, infatti, le permisero di resuscitare il divino consorte dopo che il fratello Seth ne aveva fatto a pezzi il corpo. Inoltre, veniva rappresentata come dea-madre creatrice nella regione delle cataratte. Quando nel VII secolo a.C. una dinastia nubiana si insediò a Tebe, il suo culto si diffuse e si accrebbe così tanto da superare i confini dell’Egitto. In epoca tolemaica, e successivamente romana, la devozione nei confronti di questa divinità ricevette un ulteriore grande impulso e il tempio di File raggiunse l’apice del suo splendore: storpi ed ammalati vi giungevano da ogni parte del paese e dalle diverse province dell’Impero confidando nei favori della dea. In epoca cristiana la feroce repressione fu proporzionale alla celebrità di cui godeva Iside e i seguaci della nuova fede si accanirono con cieco furore contro i rilievi che adornavano il tempio che fu poi trasformato in chiesa. (Immagini n. 1 -2).

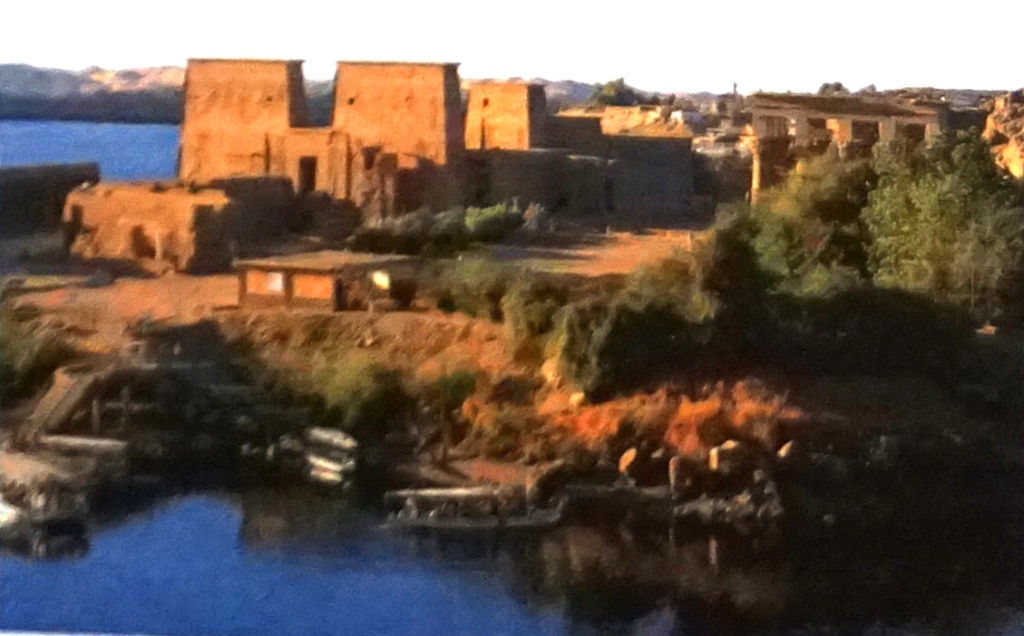
Il grande colonnato davanti al tempio di Iside.
I fedeli che si recavano in pellegrinaggio ai templi, approdavano sull’estremità meridionale dell’isola. Una volta sbarcati venivano accolti non da Iside, ma da un’altra divinità femminile: la benevola Hator dalle orecchie bovine. Si trovavano, infatti, al cospetto del cosiddetto “Chiosco di Nectanebo” i cui capitelli, erano scolpiti con l’effigie di questa dea della bellezza, dell’amore e del divertimento. L’edificio fu restaurato da Tolomeo II Filadelfo che lo spostò dalla sua posizione originaria (tuttora ignota). Oltre questo padiglione si sviluppa, con eccezionale impatto scenografico, “il grande colonnato” il cui versante occidentale, orientato lungo la linea costiera, si estende per circa cento metri. Trentadue colonne sorreggono altrettanti capitelli dalle forme molto elaborate e ispirate al mondo vegetale. Sul soffitto che rappresenta la volta celeste, sono raffigurati astri e avvoltoi, mentre sulla parete di fondo compaiono rilievi che ritraggono Ottaviano e Nerone le cui sembianze stilizzate mettono in risalto l’origine divina dei nuovi sovrani dell’Egitto. Sulle colonne, l’imperatore Traiano si fece ritrarre mente reca offerte alle divinità del luogo.
Sul lato opposto, il portico orientale non fu mai portato a termine: delle diciassette colonne presenti alcune sono prive di decorazioni e undici sono sovrastate da capitelli incompleti. A circa un terzo della spianata, nei pressi del lato lungo, per mezzo di una scala sotterranea, si accedeva al nilometro. Simili pozzi, sulle cui pareti veniva valutato il livello delle acque del fiume, erano elementi comuni a moltissimi templi egizi. Quantificare ritmi e volumi delle piene era infatti indispensabile sia da un punto di vista economico, sia sociale in quanto permetteva di presumere l’entità del raccolto e, di conseguenza, le relative tassazioni. Era ai sacerdoti che spettava l’ esclusivo privilegio di rendere noti i responsi del nilometro.
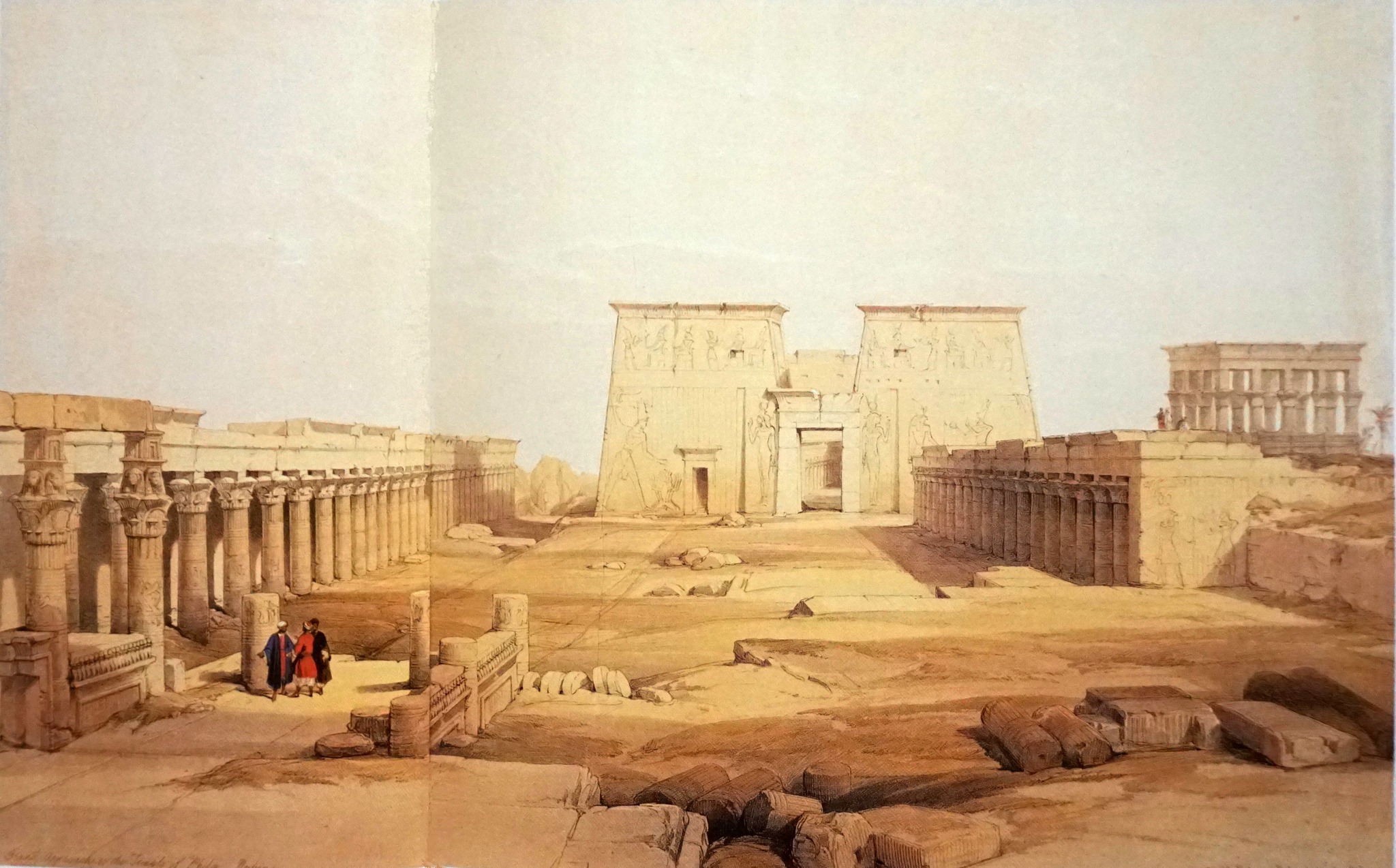

(© ph. muromaestro.wordpress.com/2019/03/09)
L’elaborato impianto prospettico (Immagini n. 3-4), si chiude sul fondo con lo spettacolare grande pilone del tempio di Iside. Fu iniziato da Tolomeo II e completato dal successore Tolomeo III, mentre la decorazione continuò anche nelle epoche successive. Sulle due torri è raffigurato Tolomeo XII che offre a Iside la sottomissione dei suoi prigionieri e nei registri superiori il sovrano lo ritroviamo al cospetto della dea, accompagnata dal figlio Horus e dalla sorella Nefti. Il portale è sormontato dal disco solare alato.
File, 17-19 novembre 1838. Parte terza: l’interno del tempio di Iside
Già nella precedente visita Roberts era rimasto particolarmente colpito dalle meravigliose proporzioni del tempio e dagli splendidi bassorilievi che ne adornavano gli ambienti interni. L’artista aveva notato che lo stato di conservazione era eccellente e nel suo diario, il 30 ottobre aveva annotato: “Sono rimasto rapito dalla splendida composizione dei suoi colori; si direbbero appena stesi e, perfino nei punti in cui sono più esposti all’implacabile luce del sole, hanno conservato la loro smagliante freschezza”

Le illustrazioni di Roberts (Immagini n. 1-2), raffigurano la sala ipostila del tempio propriamente detto, ripresa da due diverse angolazioni, posta immediatamente dopo il secondo pilone che è di dimensioni minori rispetto al primo. L’ambiente, che presenta un soffitto sostenuto da otto colonne, è preceduto da un cortile scoperto sui cui lati più corti si sviluppano due brevi porticati, retti ognuno da una colonna centrale, che li fanno apparire come dei prolungamenti della sala ipostila. Seguono alcuni vestiboli ed infine il naos, circondatoda stanze minori. Le pareti e le colonne sono ricchissime di iscrizioni e rilievi raffiguranti sovrani della dinastia tolemaica e gli imperatori romani Augusto, Tiberio e Antonino Pio ritratti in scene di offerta ad Iside o nell’atto di compiere uffici religiosi. Probabilmente il cortile doveva avere un sistema di copertura costituito da un velario manovrato per mezzo di funi, i cui fori di scorrimento sono ancora visibili sulla modanatura rivola verso il pilone.

Immagine n. 2 Questa tavola è una tra le più suggestive dell’intera opera di Roberts sia per l’inquadratura di grande effetto, sia la cura quasi maniacale con la quale sono stati riprodotti i dettagli decorativi. Faraoni e divinità ripetono all’infinito i loro gesti ieratici, mentre le immense colonne sembrano sbocciare nel lussureggiante tripudio di forme e colori dei capitelli. Esse sostengono senza alcuno sforzo apparente le possenti trabeazioni lungo le quali navigano le barche sacre. Sui soffitti spiccano le lunghe teorie di avvoltoi dalle ali spiegate. Sono visibili anche alcune croci copte, scolpite sui fusti delle colonne, e i resti di un altare che attestano la trasformazione del tempio in chiesa cristiana. Un’iscrizione recita: “questo buon lavoro fu compiuto sotto il vescovo Teodoro all’epoca dell’imperatore Giustiniano e della regina Teodora nel VI secolo. Un’altra epigrafe, ancor oggi visibile commemora la “spedizione archeologica” qui inviata da papa Gregorio XVI nel 1841. Queste manomissioni arrecarono notevoli danni al santuario, il cui fascino è però rimasto intatto come ai tempi del massimo splendore di Iside (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pag. 116).
Il fatto che l’artista avesse deciso di fermarsi una seconda volta a File impegnando l’intera giornata del 30 novembre nel ritrarre gli interni del tempio, è stata per noi una vera e propria fortuna. Nel 1902, infatti fu realizzata la vecchia diga di Aswan (poi rialzata per due volte tra il 1907 e il 1912 e tra il 1929 e il 1933) che provocò la parziale scomparsa dell’isola di File ed il conseguente allagamento dei templi, che restavano all’asciutto soltanto tra luglio e ottobre nel periodo di apertura delle chiuse (Immagine n. 3).
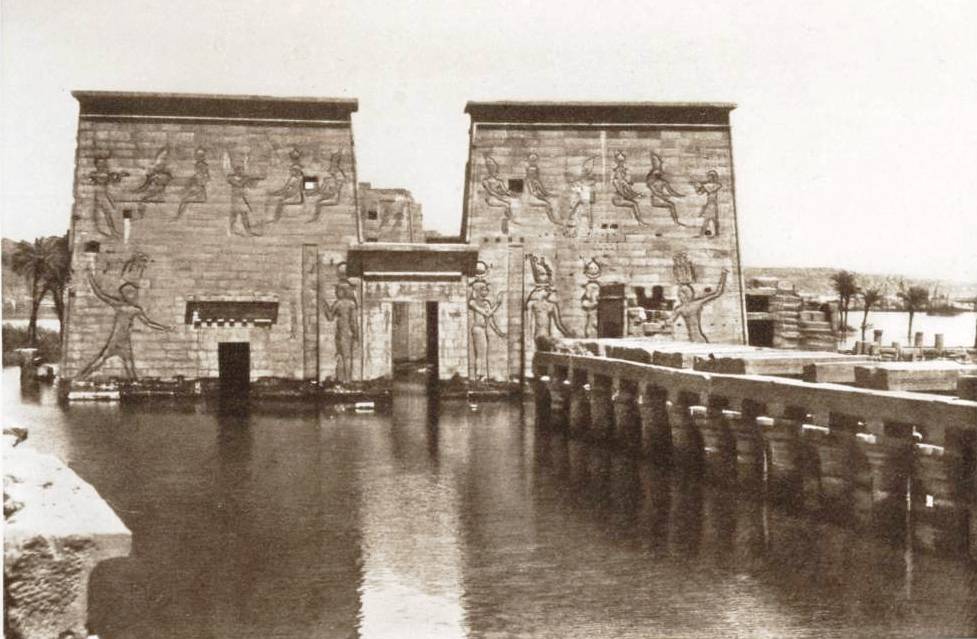
File, 17-19 novembre 1838. Quarta e ultima parte. Il salvataggio dei monumenti.
Le tavole realizzate da Roberts costituiscono un’impagabile documentazione dell’aspetto originario del sito. Quest’ ultima litografia ci offre una visone del complesso dell’isola di File ripresa al tramonto (Immagine n. 1).
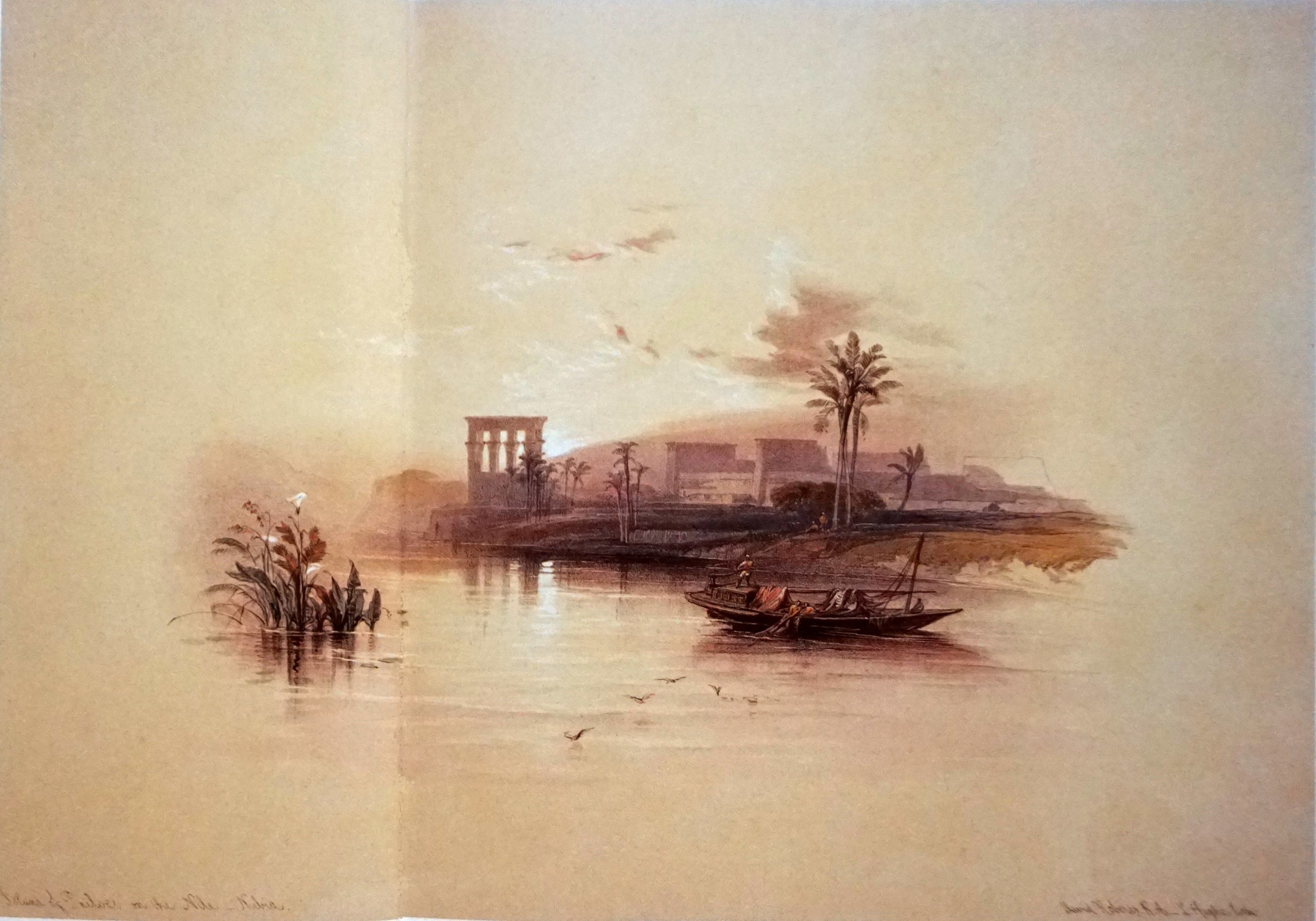
Il luogo era rimasto pressoché immutato nel tempo, finché, come già accennato in precedenza, a seguito della costruzione della Prima Diga di Aswan nel 1902, ebbe inizio il calvario per i suoi monumenti. La loro condizione subì un altro duro colpo, a partire dal 1934, allorché lo sbarramento fu innalzato di diversi metri causando la quasi totale sommersione del complesso (Immagine n. 2).
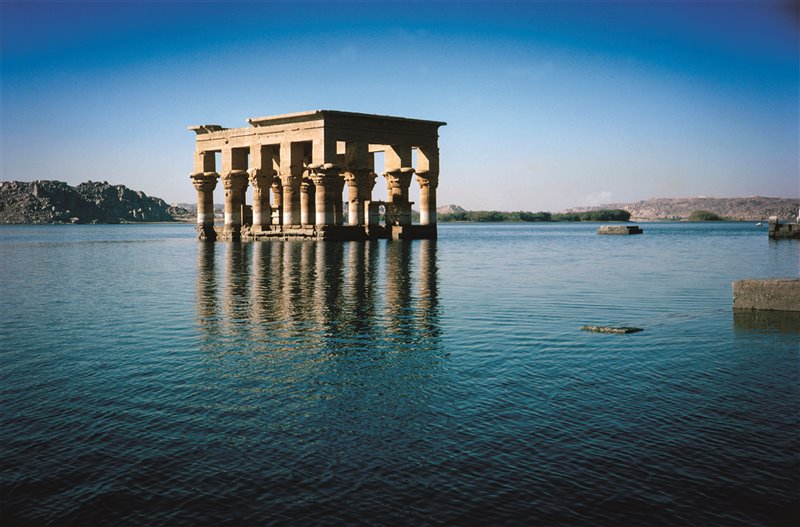
Infine, quando nel 1960 si diede inizio ai colossali lavori per la costruzione della Diga Alta, il destino di File sembrava segnato per sempre. I monumenti che avevano in qualche modo resistito, grazie ad un preventivo consolidamento delle fondamenta, non avrebbero più potuto sostenere l’ulteriore innalzamento del livello delle acque. Si decise perciò, nell’ambito della campagna di salvataggio dei monumenti nubiani, promossa dalle Nazioni Unite, di spostare anche il santuario di questo sito. La scelta cadde sulla vicina e più elevata isola di Agilka che avrebbe però dovuta essere preventivamente sottoposta ad una ingente operazione di ampliamento per permettere il corretto orientamento dei monumenti. A tal fine, nel 1969, fu bandita una gara di appalto internazionale per il salvataggio di tutte le strutture architettoniche che fu vinta da una società italiana.
I lavori presero il via nel 1972. Grazie all’utilizzo di barche battipalo si cominciarono a piantare nel fondo del bacino artificiale i 3000 pali di acciaio che avrebbero formato la base di una robusta diga anulare. L’acqua venne poi aspirata dall’interno con l’impiego di pompe idrovore e il fango rimosso da centinaia di operai. In tal modo i monumenti di File ritornarono all’asciutto. Nel frattempo, ad Agilka si provvedeva a livellare il terreno e si estendeva la linea costiera. Il 9 settembre 1975 si diede inizio allo smontaggio dei 37.363 blocchi che costituivano il complesso e il 29 maggio 1977 cominciò il riassemblaggio sull’isola vicina.
Circa tre anni dopo, il 10 marzo 1980, veniva inaugurata la Nuova File (Immagine n. 3). I lunghi decenni di sommersione sono testimoniati dal colore grigiastro delle strutture nelle parti basse.

Il Tempio di Kom Ombo, 20-21 novembre 1838.
Lasciata File, all’alba del 20 novembre cominciarono le manovre per affrontare la pericolosa discesa della Prima Cataratta che, già nel viaggio di andata, aveva mostrato la sua pericolosità. Sul far della sera le rapide furono infine superate, ma l’equipaggio ne uscì considerevolmente provato. In effetti, prima che fosse eretta la prima diga tra il 1898 e il 1912 (con la relativa realizzazione di un canale che permetteva il transito di chiatte di notevoli dimensioni), per avere ragione delle vorticose acque del Nilo bisognava imbragare le imbarcazioni e trainarle. Ovviamente, il tutto richiedeva un enorme fatica e gli incidenti erano piuttosto frequenti. Trascorsa la notte ad Aswan, il giorno seguente Roberts e la sua squadra raggiunsero Kom Ombo dove si accamparono.
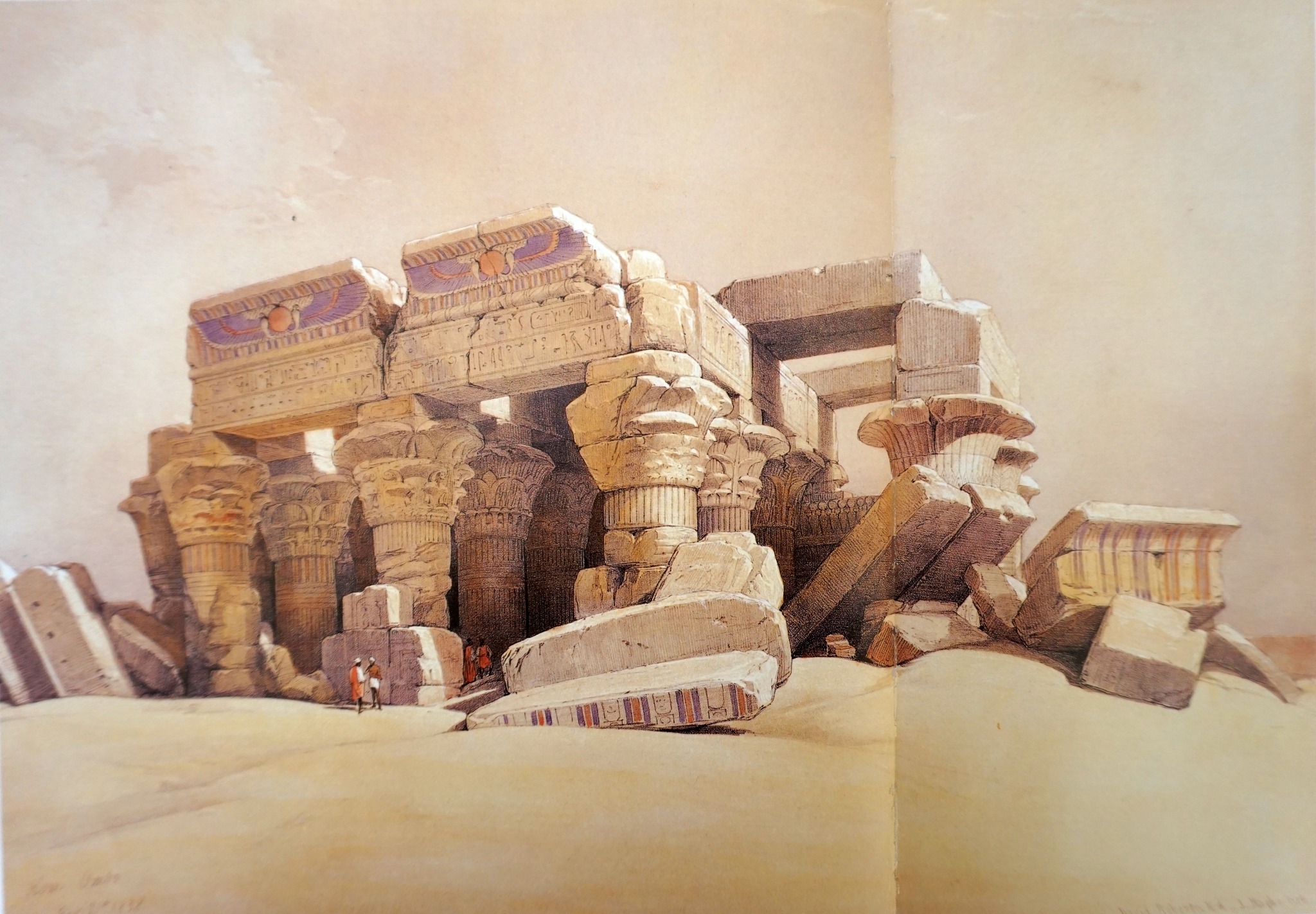
Prima del IV secolo a.C., il sito costituiva una possente roccaforte a difesa del corso inferiore del Nilo e, sebbene i resti architettonici più antichi risalgano alla XVIII dinastia, è noto che già nel Medio Regno ospitava un santuario di notevole rilevanza, in seguito ampliato da Ramses II (XIX Dinastia). La località assurse, poi, alla massima importanza politica e religiosa in epoca Tolemaica allorché divenne capitale di un nomo e si diede inizio alla costruzione di un secondo tempio. I lavori furono avviati sotto il regno di Tolomeo V intorno al 204 a.C. e continuarono per almeno novanta anni, anche se l’assetto definitivo delle strutture murarie fu terminato solo all’epoca di Tolomeo XIII, a distanza di circa un secolo e mezzo dalla posa della prima pietra. Successivamente, l’imperatore romano Tiberio portò a termine il cortile porticato e altre aggiunte e decorazioni furono volute da Domiziano verso la fine del I secolo d.C. Iscrizioni, ancora più tarde, riportano i nomi degli imperatori Geta, Caracalla e Macrino. In particolare, i bassorilievi riferiti a quest’ultimo sono da annoverare tra le più recenti raffigurazioni che ci abbia lasciato in eredità l’Egitto pre-cristiano.

Il tempio, cosa più unica che rara nella regione, sorge su una specie di acropoli leggermente elevata che domina un’ansa del fiume: del resto il termine arabo Kom significa, per l’appunto, “collina”. La particolare posizione del sito, soggetta alla continua azione erosiva del Nilo, è stata causa della rovina di gran parte del complesso monumentale che, oggi, è protetto da un possente argine.
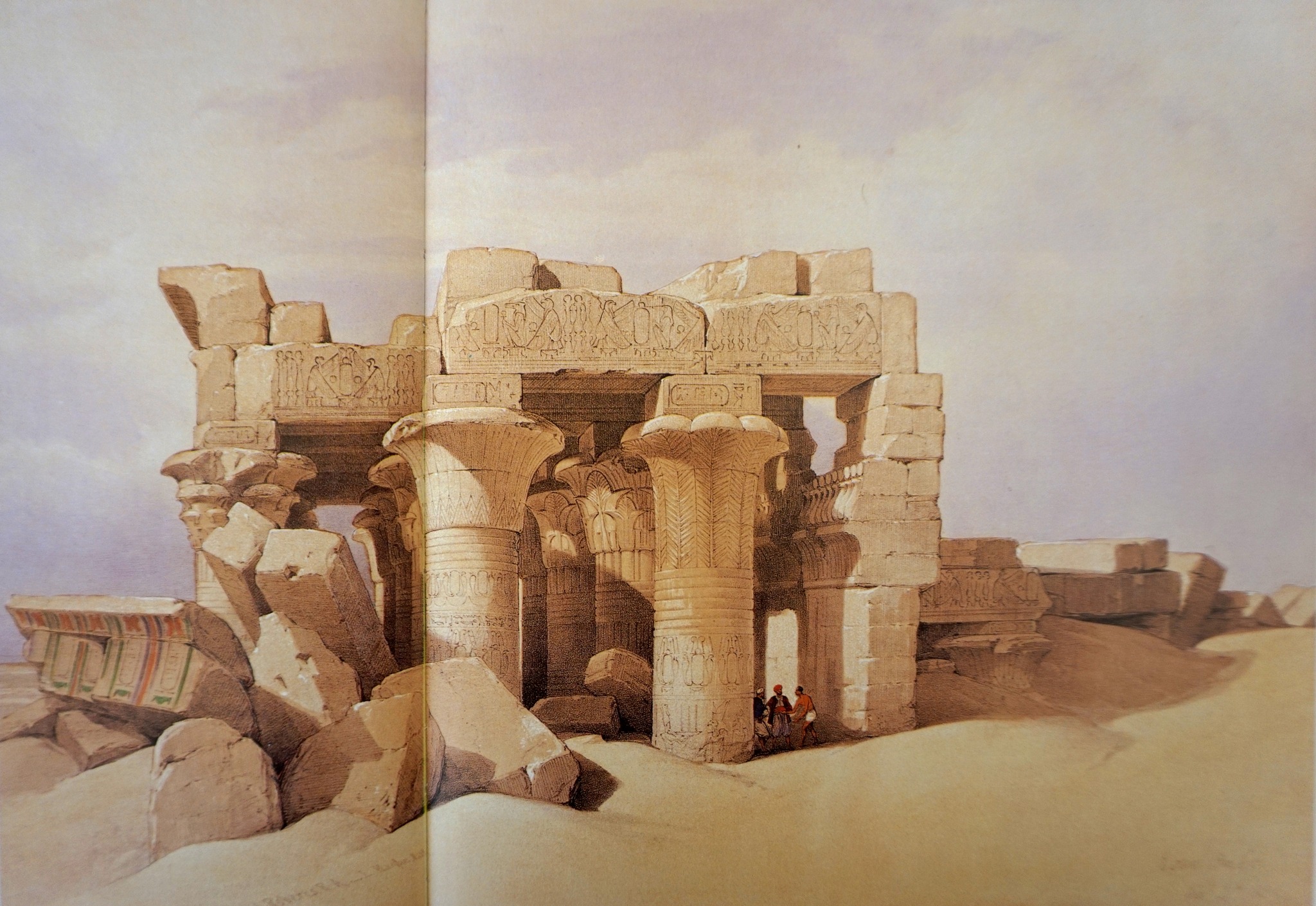
Quando Roberts visitò Kom Ombo, gran parte del santuario giaceva sotto la sabbia (Immagini n. 1÷4): infatti, solo nel 1893 si diede inizio ai lavori di scavo che avrebbero messo in luce la singolare caratteristica dell’edificio che consiste nell’ essere costituito da un tempio doppio. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, i templi egizi erano consacrati a più di una divinità (ad esempio, a Karnak era venerata la “Triade tebana” costituita da Amon, dalla sua sposa Mut e dal figlio Konsu), ma generalmente il naos centrale ospitava la divinità principale mentre nelle cappelle laterali venivano posti i simulacri degli altri dei.

Soltanto a Kom Ombo si è osservato che l’edificio risulta suddiviso in due parti separate da una ideale linea longitudinale: quella di destra consacrata a Sobek associato a Hathor e Khonsu, quella di sinistra dedicata a Haroeris associato a Setnofret e Panebtaui. Di conseguenza, la struttura era costituita da due settori affiancati e perfettamente speculari, ma del tutto indipendenti, ognuno dei quali rispondente alle proprie necessità cultuali. Nel pilone, quindi, si aprivano due ingressi e così pure nel pronao, nella sala ipostila e nelle camere che precedevano le due celle. D’altro canto, l’edificio non dava affatto l’impressione di essere formato da due templi distinti e contigui: non vi erano infatti, ad eccezione dei naos, delimitazioni di sorta e la particolare dualità di Kom Ombo non assunse mai l’aspetto di un gemellaggio, né, tantomeno, di una rivalità, tra le due divinità. Piuttosto, la singolare disposizione del santuario fu conseguenza della politica dei faraoni tolemaici che, nell’intento di ribadire la loro sovranità sia sull’ Alto, sia sul Basso Egitto, si facevano incoronare prima ad Alessandria e poi ripetevano il cerimoniale a Kom Ombo.
Il Tempio di Edfu, 22-24 novembre 1838. Parte prima.
La sera del 21 novembre 1838, Roberts e i suoi uomini lasciarono le maestose rovine di Kom Ombo e trascorsero tutta la notte navigando verso settentrione. All’alba giunsero nei pressi di Gebel el Silsila, un’aspra dorsale il cui nome significa letteralmente “Monte della Catena”. Qui, il Nilo scorre in una gola le cui acque generano rapide e vortici così impegnativi che nell’antichità la località fu chiamata “Khenu” (ossia, “il luogo in cui occorre vogare”). Sulla sponda orientale sono ancora visibili le antiche cave di arenaria che furono sfruttate per la costruzione del Ramasseum, mentre, nei dintorni, sorgono i resti della città di Kheni e del villaggio ove risiedevano i cavatori e le loro famiglie, oltre a diverse iscrizioni commemorative riferite ad Amenhotep IV e Seti I. Monumenti di ancora maggiore importanza si trovano sulla riva occidentale, in particolare la grande cappella rupestre di Horemheb. Nonostante la presenza di queste importanti vestigia, Roberts decise di non fermarsi limitandosi a concludere un disegno che aveva iniziato all’andata (Immagine n. 1).

All’approssimarsi della sera del 22 giunse ad Edfu il cui tempio gli apparve straordinariamente bello: il sole al tramonto inondava il santuario di una luce particolarmente calda e l’artista trovò il tempo per disegnarne una veduta complessiva (Immagini n. 2-3).
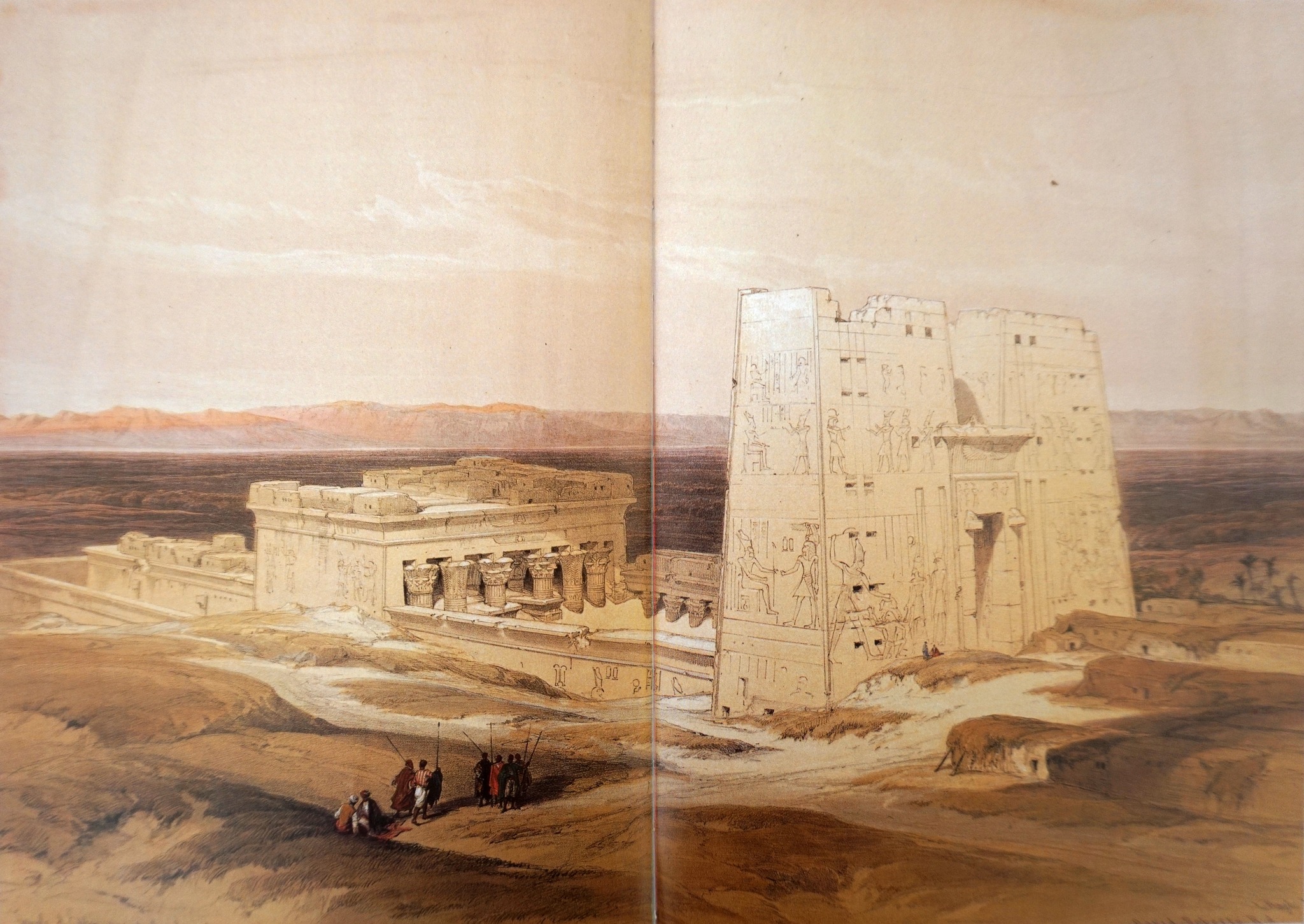
Durante il viaggio di andata Roberts aveva avuto l’impressione che, per quanto imponente, l’edificio non fosse eccessivamente grande sebbene apparisse ben proporzionato da ogni punto di vista. Il pilone, in particolare, lo considerò come un vero e proprio capolavoro di eleganza ed equilibrio architettonico.
Questo tempio, nel 1860, fu scavato e restaurato dall’archeologo francese Auguste Mariette e, a dispetto delle considerazioni di Roberts, si rivelò essere, con i suoi 137 metri di lunghezza, 79 di larghezza e 36 di altezza massima, il complesso religioso di maggiori dimensioni dopo il grande tempio di Amon a Karnak. Per di più, è quello che è giunto a noi nelle migliori condizioni ed il suo eccellente stato di conservazione ha permesso di comprendere meglio l’organizzazione architettonica degli altri templi egizi, molto spesso in rovina o gravemente danneggiati.
Edfu, (Behedet, in antico egizio) capitale del II nomo dell’Alto Egitto si trova circa a 80 km a sud di Luxor ed il suo dio cittadino era Horo di Behedet. A conferma della sua antichità, un’iscrizione rupestre riporta il nome di Den (I Dinastia, ca. 2950 a.C.) e nella zona desertica, a oriente della città, è presente una necropoli di epoca protodinastica.
Il tempio che vediamo oggi fu iniziato da Tolomeo III nel 237 a.C. e completato da Tolomeo XIII nel 57 a.C. Tuttavia, l’edificio ingloba un santuario risalente al Nuovo Regno (1543-1069 a.C.), orientato da est a ovest rispetto a quello più recente orientato da sud a nord (ciò che resta del pilone del tempio più antico è visibile a destra del pilone di ingresso).
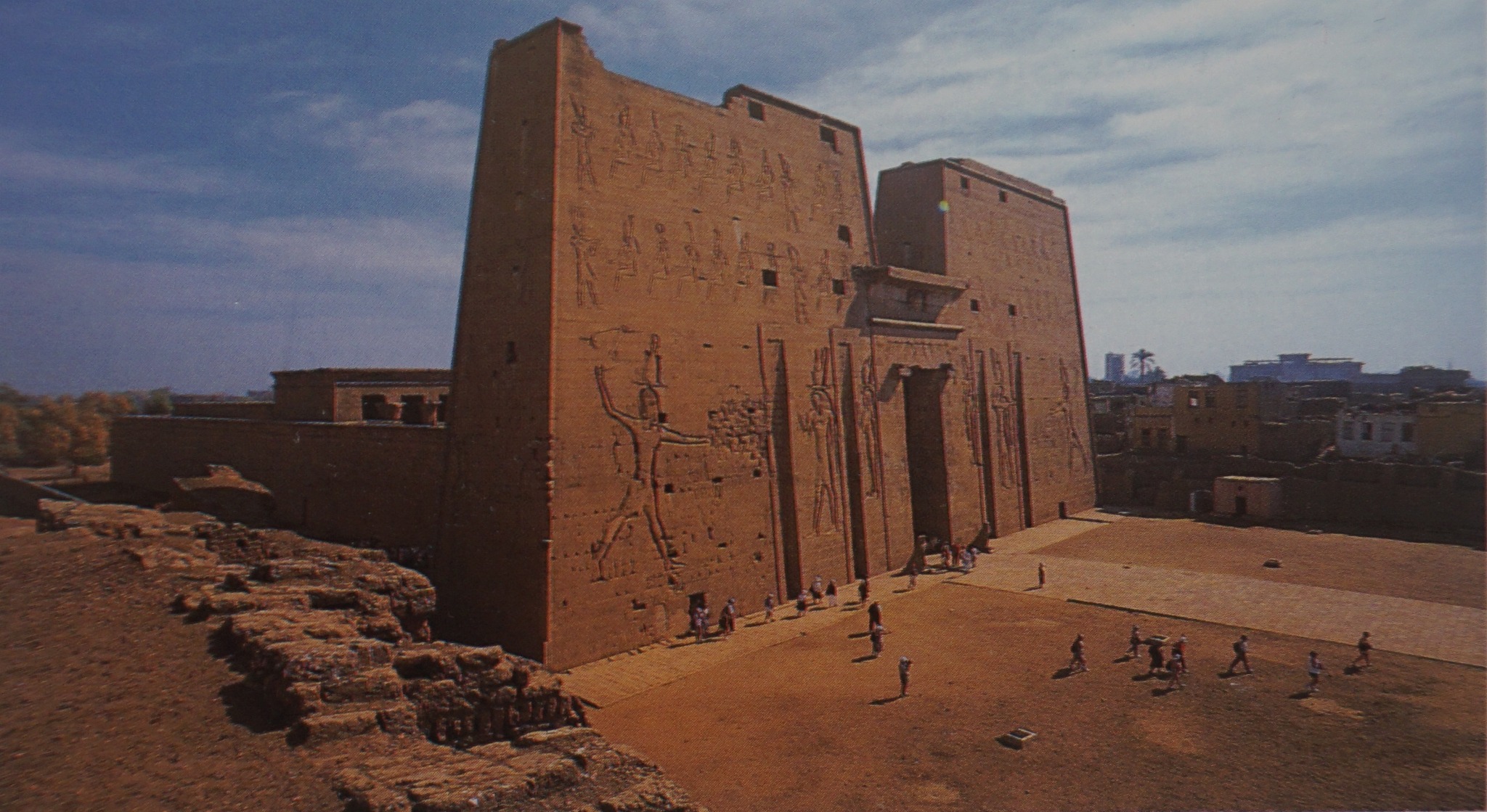
L’accesso al santuario avviene attraverso il grande portale che, affiancato da due massicce torri trapezoidali, forma il pilone. A questo segue il grande cortile porticato, cinto da ben 32 colonne, su quale si affaccia il pronao ipostilo. Da questo vasto ambiente si accede ad un secondo pronao, la cosiddetta “sala delle feste”, il cui soffitto è anch’esso sorretto da colonne. Due vestiboli successivi conducono, infine al “naos” attorno al quale sono distribuite dieci cappelle dedicate a divinità minori.
Il Tempio di Edfu, 22-24 novembre 1838. Parte seconda.
Roberts fu così conquistato dalla perfetta armonia architettonica del tempio e dagli splendidi bassorilievi policromi che il giorno successivo, sfidando una calura opprimente, decise di ritrarre due vedute del cortile colonnato.

In effetti, al cospetto di questo straordinario santuario, si ha come l’impressione che l’Egitto, al tramonto della sua gloriosa storia, abbia voluto consegnare un ultimo testamento delle sue straordinarie acquisizioni artistiche. Dopo soli 27 anni dalla conclusione dei lavori, nel 30 a.C., Augusto spazzò via il potere tolemaico portando il Paese delle Due Terre sotto il dominio romano e, pur tuttavia, anche i Cesari rimasero così affascinati dallo splendore del monumento che si adoperarono affinché non cadesse in rovina.
Il pronao, sostenuto da sei colonne, che si affaccia sul grande cortile, è sicuramente l’elemento più spettacolare. E’ caratterizzato dall’ ampio utilizzo, tipico del gusto tolemaico, di capitelli strutturati in maniera molto complessa: i due più vicini al portale hanno la forma di un fiore di loto, quelli nel mezzo sono ornati di foglie di palma da dattero e quelli più esterni riproducono la chioma della Hyphaene Thebaica”, una palma tipica della regione. Internamente, il soffitto è sorretto da altre dodici colonne, disposte a due a due e, anche in questo caso, i capitelli presentano le forme più disparate (Immagini n. 1 e 2).
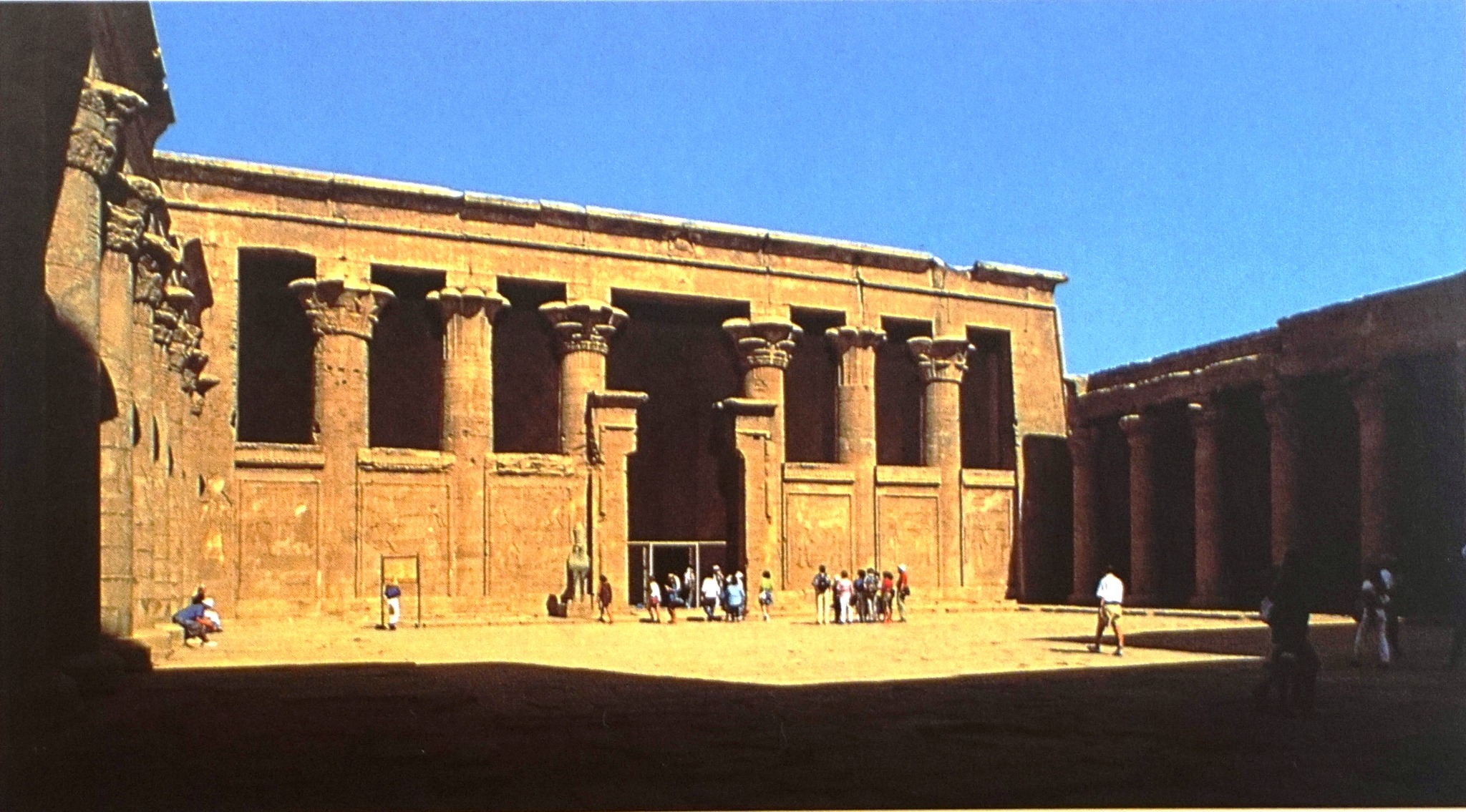
Nella seconda delle vedute realizzate da Roberts il 23 novembre 1838, sono riprodotti il pilone del tempio e il grande cortile colonnato ripresi, stavolta, dal pronao. Dal punto di vista della composizione, questa è sicuramente una delle tavole meglio riuscite dell’intera raccolta. La scelta di ritrarre in primo piano l’architrave permette di dilatare al massimo lo spazio esterno e, grazie ad un sapiente gioco di chiaroscuri, riesce a suggerire magistralmente il contrasto tra l’arsura della sabbia inondata dal sole ed il refrigerio offerto dall’ombra.
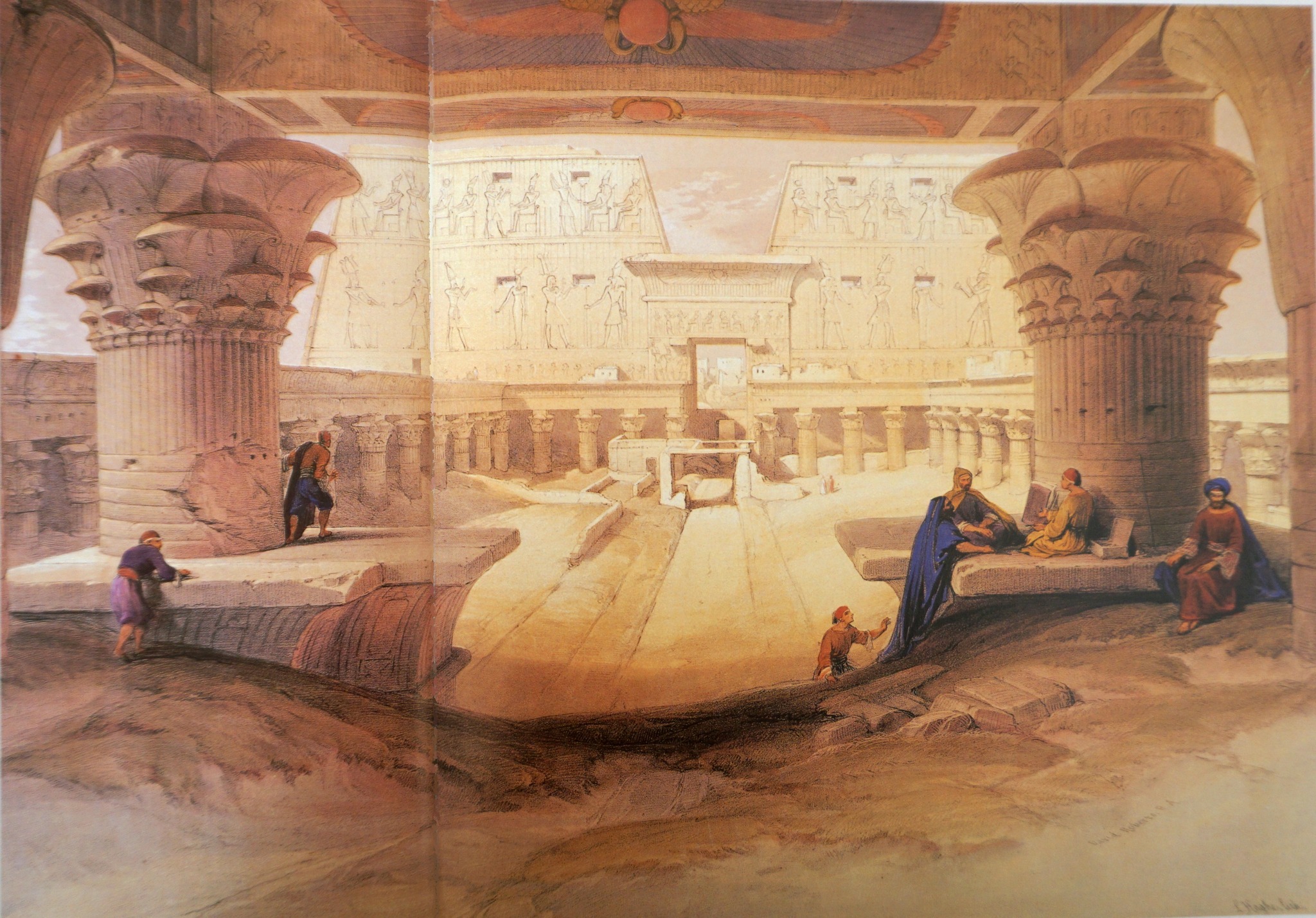
I grandi bassorilievi che adornano le pareti interne del maestoso pilone, dettagliati da Roberts con cura quasi maniacale, ci mostrano Tolomeo XIII Neo Dioniso, che offre alle divinità locali: Horus, Hathor e il loro figlio, Ihy. Sullo stipite è ben visibile il disco solare alato, simbolo del dio patrono di Edfu (Horus di Behdet) che è presente, ma in questo caso in policromia, anche sull’architrave del pronao. Il grande cortile, nel quale accorrevano i fedeli nei giorni di festa, è circondato da un portico colonnato i cui capitelli presentano elaborati motivi di ispirazione floreale (Immagini n. 3 e 4).

Il Tempio di Edfu, 22-24 novembre 1838. Terza e ultima parte.
Già durante la sua prima visita, Roberts aveva definito il tempio di Edfu come il più bello d’Egitto soprattutto in virtù delle sue armoniche proporzioni. Con il gusto derivante dalla cultura romantica che caratterizzava la sua epoca, aggiunse, inoltre, che la sabbia che lo ricopriva in gran parte lo rendeva ancor più affascinante; tanto da avergli ricordato le vedute dei Fori Romani disegnate da Giovanni Battista Piranesi*.

Il 24 novembre, l’artista ritrasse la facciata del pronao, questa volta visto da sud-est, focalizzando l’attenzione sui giganteschi capitelli che sormontano le colonne e sugli articolati geroglifici che ricoprono gran parte delle superfici disponibili. Quello che Roberts non poté vedere, a causa della sabbia che nascondeva gran parte dell’edificio, fu il muro, tipico elemento dell’architettura tolemaica, che occupa fino a metà altezza gli spazi tra le colonne laterali e che si interrompe solo al centro in corrispondenza del portale di ingresso. Come nelle tre illustrazioni precedenti, sopra la grande trabeazione del pronao sono visibili alcune delle miserrime stamberghe di fango e legno che erano sorte un po’ dovunque sull’intero edificio deturpandone le elegantissime proporzioni. Questi poveri tuguri, furono poi fatti demolire da Auguste Mariette quando si decise di liberare il complesso dai detriti e il tempio riacquistò il suo antico splendore (Immagini n. 1 e n. 2).

* Giovanni Battista Piranesi (Mogliano, Mestre 1720 – Roma 1778), fu architetto e soprattutto incisore raffinatissimo. Tra le sue realizzazioni più significative ed emozionanti si ricordano le “Varie vedute di Roma Antica e Moderna”, le “Antichità Romane”, le “Differenti vedute di Paestum”, le “Carceri di Invenzione”
Il Tempio di Esna, 25 novembre 1838.
Lasciata la località di Edfu in serata, i vogatori trascorsero l’intera notte ai remi incitati costantemente da Hassan Amoris. Sul far del giorno, circa trenta miglia più a nord, l’imbarcazione era in vista di Esna e del suo tempio dedicato a Knhum. Nonostante i suoi resti non reggessero il confronto con le dimensioni del santuario visitato nei giorni precedenti, Roberts decise di fermarsi per immortalare questo edificio le cui decorazioni erano comunque straordinarie per qualità e ricchezza di dettagli (Immagine n. 1) .

Dal diario di David Roberts, 25 novembre 1838 <<Mentre stavo lavorando, sono stato attorniato da un gruppo di cristiani copti, assai gentili, che sembravano considerarmi uno di loro. Ne ho ritratti alcuni nel mio disegno, cosa della quale si sono dimostrati entusiasti. Esna è l’ultima città cristiana sul Nilo prima dell’Abissinia. Quando sono tornato a bordo ho trovato Hassan Amoris in preda a dolori atroci e, pensando si trattasse di colera, gli ho somministrato trenta gocce di laudano. Con mio intenso sollievo, dopo alcune ore si è ripreso>>. (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg. 134-135).
Sul luogo era già stato edificato, dai sovrani della XVIII dinastia, un primo tempio dedicato al dio dalla testa di ariete, venerato come colui che modellava sul suo tornio di vasaio l’uovo generatore di ogni forma di vita. Molto più tardi, in epoca saitica, il monumento venne parzialmente ristrutturato, ma soltanto a partire dal 181 a. C., Tolomeo VI Filometore, ne avviò la completa ricostruzione che proseguì con ulteriori ampliamenti durante la dominazione romana.
Il santuario, in origine probabilmente racchiuso da una cinta muraria, era formato dal pronao (sala ipostila), due vestiboli e da due anticamere collegate da corridoi. Di questi ambienti, la sala ipostila è la sola struttura ad essersi conservata pressoché intatta attraverso i secoli. La facciata è caratterizzata dalla presenza di sei colonne occupate fino a mezza altezza da muri divisori (Immagine n. 2). Sebbene questo modello costruttivo ricalchi appieno i canoni dell’architettura di epoca tolemaica, il monumento fu portato a termine nella seconda metà del I secolo d.C. sotto gli imperatori Tiberio, Claudio e Vespasiano. Quest’ultimo, in particolare, è definito in un’iscrizione dedicatoria come “ il signore di Roma capitale”.

Il tempio possiede la caratteristica di essere completamente ricoperto di rilievi: muri e colonne sono istoriati con testi religiosi che presentano un’inedita varietà di soggetti che comprendono la narrazione dell’origine del mondo, della vita e della sua trasmissione, della creazione dell’uomo e dei fondamenti teologici del potere regale. I testi più importanti furono incisi durante i regni di Traianoe Adriano (II secolo d.C.), mentre i più recenti rimontano, presumibilmente, a Decio (ca. 250 d.C.).
Il soffitto della sala ipostila, sorretto da 18 colonne con capitelli finemente scolpiti con motivi naturalistici, è adornato da splendide scene astronomiche.
Quando Roberts lo ritrasse,il tempioera completamente attorniato da detriti e il suo interno era accessibile solo grazie ad una scala a scendere. La sala, all’epoca, era adibita a polveriera e più tardi fu convertita in deposito di grano e cotone. Negli anni cinquanta del secolo scorso l’egittologo francese Serge Sauneron (1927-1976), resosi conto della ricchezza delle decorazioni, diede inizio alla pulitura della parete esterna sud, parzialmente sepolta, e curò la meticolosa pubblicazione di tutte le sue iscrizioni. Dopo la sua morte prematura, i lavori di restauro si fermarono per molto tempo, finché, a partire dal 2018, il Ministero del Turismo e delle Antichità e l’ Istituto Egittologico dell’Università di Tubinga hanno avviato un progetto di recupero e conservazione della splendida decorazione policroma (Immagini n. 3-4).


Chi fosse interessato ai dettagli di questa operazione e agli straordinari risultati conseguiti, può consultare il seguente link: https://laciviltaegizia.org/2022/12/13/il-restauro-del-tempio-di-esna/
Le rovine del tempio di Hermonthis, 26 novembre 1838
Roberts, ritornato a bordo dopo la visita al tempio di Esna, aveva trovato Hassan Amoris in preda alla febbre e a forti dolori, creando non poca apprensione anche negli uomini dell’equipaggio. Fortunatamente, nel giro di qualche ora, il tutto rientrò e l’imbarcazione poté salpare, raggiungendo Armant nel corso della notte. Di primo mattino, l’artista scese a terra trascorrendo alcune ore a ritrarre le rovine del tempio di Montu che, già all’andata gli era sembrato molto pittoresco. La città, distante una ventina di chilometri da Luxor, dall’inizio del Medio Regno divenne un importante religioso, ma resti più antichi mostrano che fosse abitata sin dal predinastico. Nota come Iuni era detta anche Per-Montu (Dominio di Montu), perché qui era venerato il dio della guerra dalla testa di falco a cui i sovrani dell’XI Dinastia eressero l’importante santuario. Mutato il suo nome in Hermonthis, in epoca greca, divenne capitale di un nomo abbastanza fiorente sotto la dominazione romana. Il tempio che vi sorgeva fu ricostruito una prima volta per volere di Nectanebo II e successivamente da due sovrani della dinastia dei Tolomei: Cleopatra VII e Tolomeo XV Cesarione.
Quello che rimaneva del tempio (Immagini n. 1 e 2) fu raso al suolo pochi anni dopo la visita di Roberts per utilizzarne le pietre nella costruzione di un grande zuccherificio e di alcuni moli sul Nilo. Durante le campagne di scavo condotte a più riprese nel secolo scorso, furono riportate alla luce, qualche chilometro più a nord, le necropoli dove venivano inumati i tori sacri a Montu e le vacche che li avevano partoriti.

Nella stessa mattinata del 26 novembre, dopo aver realizzato il disegno dei ruderi del santuario, Roberts, con il suo equipaggio lasciò Armant diretto alla volta della vicina Tebe dove si sarebbe intrattenuto una decina di giorni per ritrarne le numerosissime e straordinarie vestigia.

Tebe. Parte prima: I templi di Karnak visti da sud, 27 novembre 1838

Lasciata Armant verso le 11 del mattino, circa due ore più tardi, Roberts fu in vista di Luxor, la città sorta sulle rovine dell’antica Tebe. Dopo solo pochi minuti, attraccò nei pressi del colossale tempio di Karnak ed il giorno successivo diede inizio al suo febbrile lavoro per ritrarre quelle rovine che già qualche settimana prima lo avevano così fortemente impressionato. Nonostante l’artista, dopo aver visto il tempio di Edfu, l’isola di File e i colossi di Ramses II ad Abu Simbel, fosse ormai avvezzo alle emozioni che i monumenti egizi erano in grado di provocargli, il sito dell’antica capitale continuava ad esercitare su di lui un fascino ineguagliabile. Sul suo diario, il 23 ottobre 1838 aveva annotato:
“Karnak è ancora più stupefacente di Luxor. La sua grandiosità è inimmaginabile. Tentare di descrivere ciò che ho visto sarebbe ridicolo. Il tempio è così lontano da qualsiasi mia precedente esperienza che non ho modo di fare paragoni. Come per altri templi egiziani, di primo acchito si rimane persino un po’ delusi, poiché il santuario giace in una piana sconfinata che ne falsa le dimensioni; solo avvicinandosi si rimane sconvolti, addirittura sopraffatti dallo stupore. Bisogna stare nella loro ombra e guardare in su e camminare in mezzo a queste strutture ciclopiche per capire: ciò mi spaventa e mi trema la mano al pensiero che i miei disegni difficilmente potranno dare un’idea di ciò che intendo. La circonferenza delle colonne supera i dieci metri, di modo che un uomo al loro confronto pare un pigmeo. I blocchi che giacciono sparpagliati tutt’attorno sono così enormi che, pur senza considerare come furono tagliati, non si capisce come siano stati trasportati sul posto”.

Tebe. Parte seconda: vedute della grande sala ipostila nel tempio di Karnak, 27-29 novembre 1838
I templi di Karnak e Luxor sorgono là dove nell’antichità era ubicata la gloriosa Tebe, la grandiosa città capitale dell’ impero egizio a più riprese, che fu celebrata per le sue immense ricchezze. Nel nono canto dell’Illiade, Omero la definì “la Città dalle cento porte” in riferimento alle innumerevoli carovane che vi facevano tappa ogni giorno accrescendone enormemente la sua rilevanza economica e politica. Sorta come modesto villaggio, conobbe un clamoroso sviluppo a partire dalla seconda riunificazione dell’Egitto a seguito della vittoriosa guerra di liberazione dagli Hyksos. Duranteil suo periodo di maggior splendore, tra il 1580 al 1085 a.C. dominò un territorio, che all’apice della sua espansione, si estendeva dalla Nubia alle rive del Mediterraneo, dalla Libia alla Palestina. La sconfinata metropoli era dominata dalla superba mole del tempio dedicato alla triade tebana (Amon – Mut – Khonsu) che veniva ampliato ed abbellito dai faraoni che si succedevano sul trono d’Egitto. Dopo il regno di Ramses III, ultimo grande sovrano della XX Dinastia, cominciò la lenta decadenza della città: il potere divenne sempre più prerogativa dei grandi sacerdoti di Amon-Ra e, nello stesso tempo, un fattore squisitamente geografico contribuì al progressivo declino politico. Situata troppo lontana da quel Mediterraneo che diventava sempre più il centro del mondo e dalla zona del Delta dove i sovrani ramessidi avevano dovuto erigere nuove postazioni militari per difendersi dai continui tentativi di invasione, Tebe perse la sua supremazia; Sais, Tanis e infine Bubasti presero il suo posto come residenza imperiale. Il colpo di grazia fu inflitto dagli Assiri, allorché Assubanipal, nel 663 a.C. sottopose la città ad un disastroso saccheggio. Da quel momento la città non riacquistò più la sua rilevanza politica anche se continuò ad essere un centro religioso molto importante. La decadenza continuò inarrestabile anche sotto il dominio dei Tolomei, tanto che, quando i romani conquistarono l’Egitto, la trovarono già in buona parte caduta in rovina. Infine, durante il periodo cristiano, molti suoi monumenti furono trasformati in chiese e monasteri e tante mirabili opere d’arte vennero distrutte o disperse perché considerate come efferati simboli del paganesimo. La gloriosa Tebe, il cui nome egizio era Uaset (la “Potente”), fu divisa in due da un canale: a sud nacque la cittadina di Luxor, mentre a nord si sviluppò Karnak.
Le litografie di cui ci occupiamo raffigurano scorci della sala ipostila del tempio di Amon che Roberts ritrasse da diverse angolazioni.
Edificata da Seti I e Ramses II, questa incredibile struttura può essere annoverata con pieno diritto tra le meraviglie del mondo antico. Si sviluppa su una superficie complessiva di 5.000 metri quadrati ed è sorretta da ben 134 colonne di arenaria allineate in sedici file. Non a caso questo ambiente, il più vasto al mondo tra quelli con copertura in pietra, fu definito, già dai primi archeologi come “una foresta di colonne”. Il notevole divario d’altezza tra le colonne centrali e quelle delle navate laterali permise agli antichi costruttori l’apertura di numerose finestre tra gli architravi ed il soffitto garantendo così una ottimale illuminazione della sala, che in origine era chiusa da alte pareti su tutti i lati. Ogni superficie è riccamente decorata con bassorilievi ed iscrizioni che illustrano i complessi rituali sacri e le interazioni tra sovrani e dei: purtroppo i vivaci colori, ancora visibili quando Roberts visitò il sito, oggi sono molto sbiaditi o, in molti punti, del tutto scomparsi (Immagini n.1 e n. 2).


Roberts si trattenne a Karnak per ben quattro giorni lavorando febbrilmente e quasi ossessionato dall’idea di non riuscire a riprodurre la magnificenza delle testimonianze architettoniche del luogo che era stato la dimora di Amon, il signore degli dei: in particolare manifestò un’evidente predilezione per la sala ipostila, dal momento che all’epoca della sua visita, il resto del complesso templare si presentava come un insieme di strutture parzialmente sepolte dalla sabbia e così danneggiate da essere, nel loro insieme, assai poco decifrabili. In effetti, i faraoni che si succedevano provvedevano di volta in volta ad ingrandire il santuario talora distruggendo e/o riutilizzando strutture precedenti. Pertanto, nonostante gli intensi lavori di restauro, tuttora in corso, l’architettura dell’edificio appare oltremodo complessa.
Le due litografie successiveci illustrano altri due sorci della sala ipostila: la prima (Immagine n. 3) presenta una veduta dall’esterno, mentre la successiva (Immagine n. 4) mette in evidenza le mastodontiche proporzioni delle colonne, il grave stato di devastazione in cui versava l’edificio, ma anche lo splendore dell’apparato decorativo, caratterizzato da una brillante policromia.
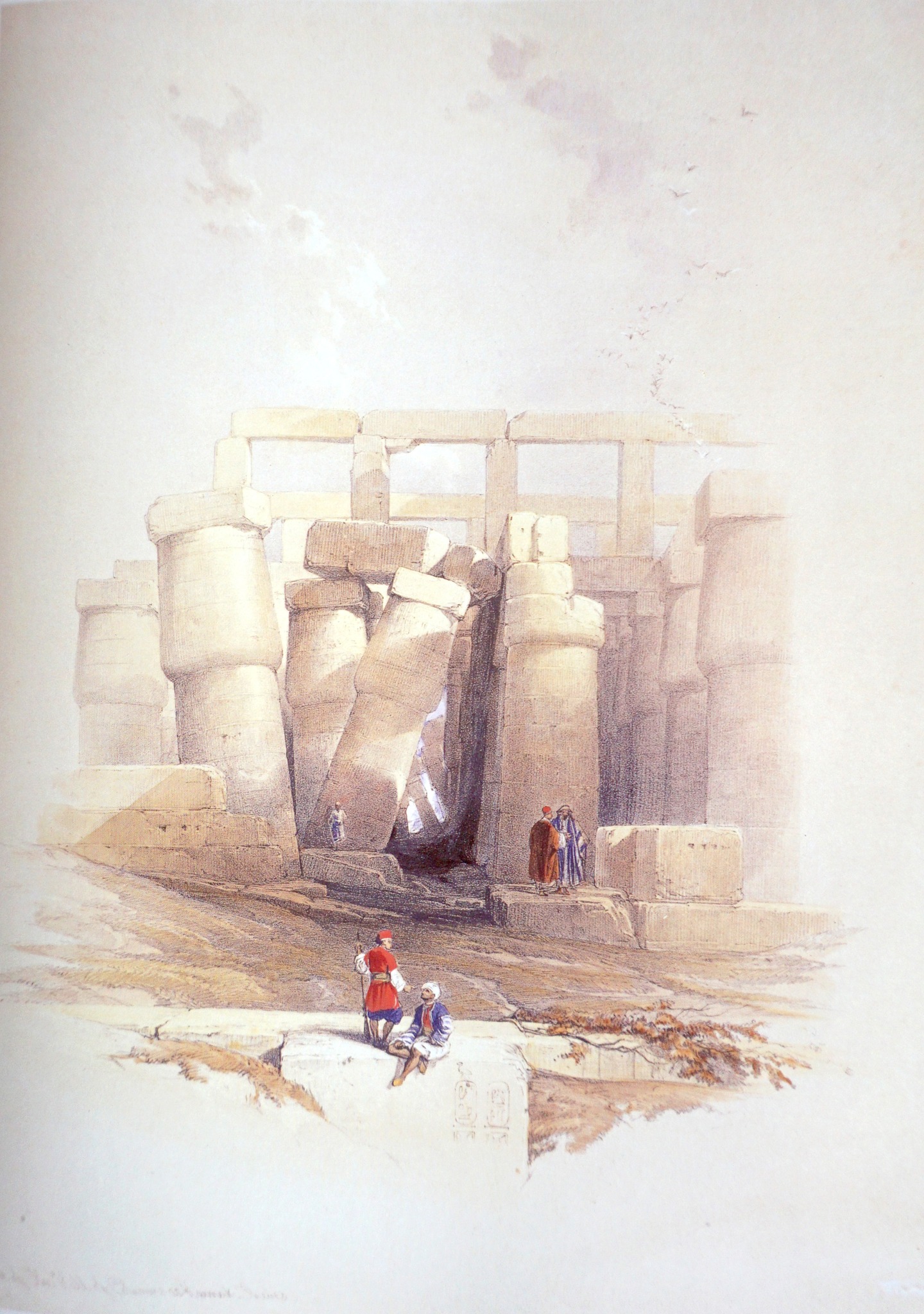
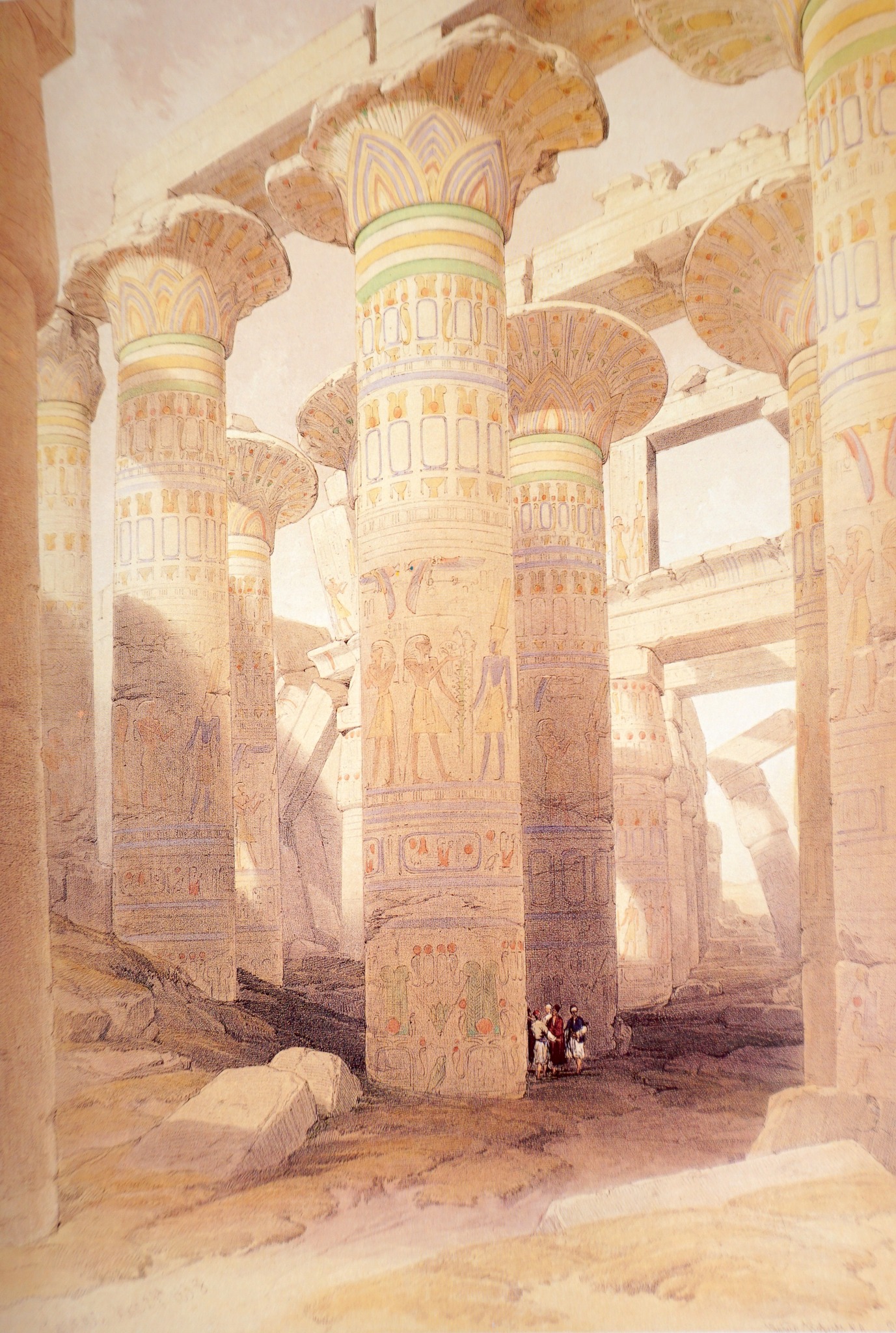
Le immagini n. 5-6-7-8 sono fotografie realizzate sul finire del secolo scorso e riproducono grosso modo gli stessi soggetti delle litografie trattate in questo paragrafo. L’intero complesso è stato oggetto di continui e assidui lavori di restauro; purtroppo i vivaci colori, così ben evidenziati da Roberts, sono quasi del tutto svaniti. (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts)
P.S. Desidero dedicare queste litografie alla cara Franca Loi che oggi non è più fisicamente con noi, ma è presente più che mai nel pensiero e nel ricordo. E chissà, magari continuerà a percepire il nostro affetto nella sua vita lassù “tra le stelle che non tramontano mai”. Poco meno di un anno fa ci aveva regalato uno splendido post sulla grande sala ipostila di Karnak. Lo trovate qui: https://laciviltaegizia.org/2023/05/13/la-grande-sala-ipostila/
Tebe. Parte terza: altre vedute del tempio di Karnak, 29 novembre 1838
All’alba del 29 novembre, Roberts realizzò uno dei disegni più suggestivi della sua raccolta, sia dal punto di vista della composizione, sia per l’impatto emotivo che è in grado di trasmettere. Si tratta di una veduta complessiva delle rovine del tempio di Karnak accarezzate dalla soffusa luce del primo sorgere del sole; un gruppo di locali, ritratto in primo piano aggiunge alla scena un tocco di romanticismo.
E’ concepita con il chiaro intento di far risaltare la straordinaria vastità del santuario che, con i suoi trenta ettari di superficie, è il più grande tempio a colonne esistente al mondo (Immagini n. 1 e n. 2).


Iniziato durante la XII dinastia, il colossale edificio fu teatro di continui lavori di miglioramenti e accrescimenti architettonici che si protrassero per oltre sedici secoli. Ciò che si presenta oggi ai nostri occhi, pertanto, può essere considerato una sorta di compendio dell’arte egizia.
Karnak era il maggior centro di culto del dio Amon ed ogni faraone, impiegando grandi risorse, vi apportava migliorie. Così l’incessante opera di ampliamento, sviluppatasi per un lunghissimo arco temporale, portò, inevitabilmente, ad erigere edifici sempre più giganteschi: il risultato di tanta devozione fu questa sterminata struttura, con molte ripetizioni e un vago senso di confusione architettonica, ma innegabilmente irripetibile per fascino e grandiosità. Il tempio di Amon è senza alcun dubbio il monumento che più di ogni altro rappresenta la magnificenza dell’edilizia celebrativa voluta dai sovrani egizi sia per motivi religiosi, sia per ragioni di prestigio politico.
Il complesso sacro di Karnak è costituito da tre aree separate tra loro da muri di cinta costruiti con mattoni crudi. Il recinto principale ospita il grande tempio di Amon che comprende quello più piccolo dedicato a suo figlio, il dio lunare Khonsu; sulla destrasorge il santuario di Montu, il dio della guerra e dalla parte opposta è ubicato il santuario della dea Mut. In origine, si poteva accedere al tempio di Amon grazie alla presenza di due percorsi alternativi, a seconda che vi si giungesse dal Nilo oppure via terra; in entrambi i casi l’ingresso era preannunciato da una fila di alti piloni, strutture formate da due grandi torri trapezoidali, incornicianti un portale d’accesso centrale, la cui morfologia trae ispirazione, molto probabilmente, dall’architettura militare.
I fedeli che provenivano da sud percorrevano un lungo viale fiancheggiato da sfingi, quindi attraversavano i porticati meridionali che conducevano al cortile incluso tra il terzo ed il quarto pilone sul quale si apriva il tempio vero e proprio.
Il cammino per coloro che arrivavano dal fiume seguiva, invece, un andamento perpendicolare alla cella; superato il primo pilone si aveva accesso al grande cortile, il più esteso di tutto l’Egitto. Costruito durante la XXII dinastia (circa 945-720 a.C.). è fiancheggiato da 18 colonne a destra e 9 a sinistra, tutte aventi forma di papiri chiusi. Al centro di questa vasta area si erge una colonna alta ben 21 metri, che aveva particolarmente attirato l’attenzione di Roberts (Immagini n. 3 e n. 4) ed è ciò che resta di un chiosco fatto erigere dal faraone etiope Taharqa intorno al 680 a.C.


Al cortile segue la grande sala ipostila, quindi, superati il terzo e quarto pilone si giunge in un ambiente detto “piccolo vestibolo”; altri due piloni precedono il sacrario propriamente detto al quale succede infine il “salone delle feste”
Tebe. Parte quarta: le rovine del tempio di Medamud nei pressi di Karnak, 30 novembre 1838

Questa tavola ha posto grossi problemi di datazione dal momento che Roberts, nel suo diario, non fa alcun riferimento esplicito al tempio di Medamud, né durante il viaggio di andata, né durante quello di ritorno. Egli scrive che dal 27 al 29 novembre è stato impegnato a ritrarre il tempio di Karnak, il 1° dicembre, un sabato, di “aver iniziato e finito a Luxor” e la domenica, in osservanza alle prescrizioni religiose, di non aver lavorato, limitandosi a visitare Medinet Habu. Da quel momento, e fino alla partenza per Dendera avvenuta la sera del 6 dicembre 1838, l’artista si intrattenne sulla sponda sinistra del Nilo laddove sorgono i templi funerari, i Colossi di Memnone e la Valle dei Re. Resta, quindi, soltanto la giornata del 30 novembre, a proposito della quale si limita a riportare di aver stilato alcuni schizzi e di aver realizzato due studi a olio. Pertanto, in considerazione dei dati disponibili, la data indicata è da considerarsi come molto probabile, ma non certa.
Il tempio di Medamud è ubicato circa sei chilometri a nord di Karnak, sulla medesima sponda del fiume. All’epoca della visita, la zona non era ancora ingombra da edifici moderni, perciò i resti erano facilmente visibili e, naturalmente, attirarono l’attenzione dell’infaticabile artista. Le rovine presenti risalgono all’epoca tolemaica e romana, ma le origini del santuario, dedicato a Montu, sono molto più remote. Nell’antica Madu (è questo il nome originario della località), il culto di questo dio della guerra si instaurò, infatti, già dall’Antico Regno, quando fu eretto un primo tempio, poi ampliato da Sesostri III e successivamente dai sovrani del Nuovo Regno.

Nel corso dei tre secoli di dominio tolemaico, in Egitto si moltiplicarono i cantieri approntati per il restauro o la nuova costruzione di grandi santuari consacrati alle antiche divinità ed in tale contesto anche il tempio di Medamud fu rinnovato. Dell’edificio rimangono solo le cinque colonne ritratte da Roberts: le due che inquadrano il grande portale sono sormontate da ricchi capitelli a motivi floreali, le altre sono del tipo papiri forme fascicolato a capitello chiuso. (Immagini n. 1 e n. 2).
Tebe. Parte quinta: Luxor, la facciata del grande tempio di Amon e l’obelisco di Ramses II, 1° dicembre 1838.
Dal diario di Roberts apprendiamo che l’artista soggiornò a Luxor per un solo giorno, il primo dicembre. Ciò lascia supporre, considerando le numerose tavole prodotte, che avesse eseguito i bozzetti già durante il viaggio di andata per poi completarli durante la seconda permanenza.
Il grande santuario dedicato ad Amon (Immagini n. 1-2), all’epoca era semisepolto dai detriti e letteralmente invaso da una miriade di casupole con i tetti occupati da centinaia di vasi di terracotta adibiti a colombaie, chiaramente visibili nella litografia. Inoltre, nel primo cortile si scorge una costruzione sormontata da una cupola e, alle spalle della torre di sinistra, svetta la sommità del minareto della moschea di Abu el-Haggag, edificata nel XIII secolo d.C. e ancor oggi presente nell’area archeologica, all’interno del grande cortile di Ramses II. Il tempio fu dissotterrato solo nel 1885 ad opera di Gaston Maspéro, che diede avvio alla grandiosa campagna di scavo che è tuttora in atto.

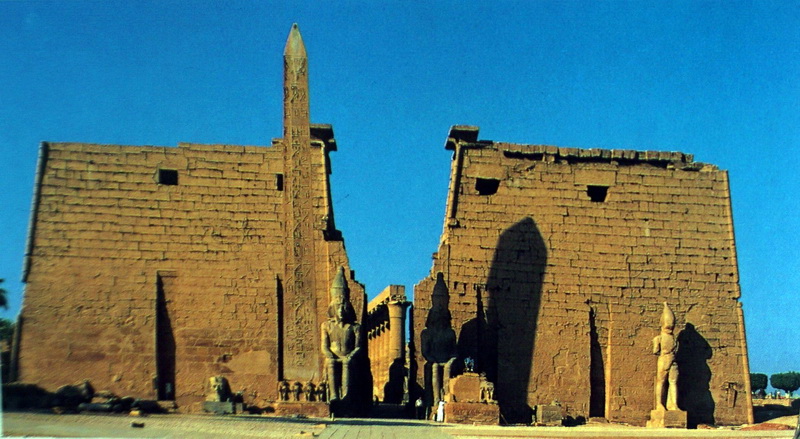
Il tempio di Luxor era il più importante satellite del colossale complesso cultuale di Karnak al quale fu collegato mediante un maestoso viale di sfingi, lungo 2,7 Km., il cui assetto odierno è il risultato dell’ultimo restauro da attribuire a Nectanebo I (380-362 a.C.), fondatore della XXX dinastia*.
Come dimostra il reimpiego dei materiali più antichi, già dal Medio Regno esisteva un sito monumentale che fu poi ampliato nel corso dei secoli. Tuttavia, lo stile architettonico di Luxor appare molto più unitario rispetto a quello di Karnak dal momento che l’edificio è sostanzialmente opera di tre soli faraoni: Amenhotep III, Tutankamon e Ramses II. Il primo, nel XIV secolo a.C., ne affidò la progettazione ad Amenhotep, figlio di Hapu (famoso per la sua saggezza e venerato al pari di un dio dopo la morte), che lo orientò eccezionalmente da nord a sud al fine di metterlo in collegamento diretto con la dimora di Amon a Karnak, mentre i due successori provvidero ai consueti lavori di ampliamento ripetendo i medesimi elementi strutturali.
In origine, il complesso era costituito dal naos preceduto dalla sala ipostila a cui, in un secondo momento, Amenhotep III aggiunse il cortile porticato ed il grande colonnato. Alla sua morte, il figlio Amenhotep IV (Akhenaton) abbandonò ben presto il progetto di ampliamento per fondare il culto dell’ Aton e la nuova città imperiale di Akhetaton (l’odierna Tell el-Amarna), per cui toccò a Tutankamon, dopo aver riportato la corte a Tebe e ripristinato la religione degli avi,proseguire nei lavori a Luxor realizzando numerosi abbellimenti. Durante la XIX dinastia, infine, Ramses II fece edificare il grande cortile porticato con l’asse spostato verso est, preceduto dal grande pilone frontale decorato con i rilievi che narrano la sua “vittoria” contro gli Hittiti nella battaglia di Qadesh. Davanti ad esso fece erigere due obelischi completamente ricoperti di iscrizioni e scene di offerta ad Amon. Quando Roberts ritrasse questo particolare del tempio di Luxor (Immagini n. 3-4), uno dei duemonoliti, alto 22 metri e pesante 220 tonnellate era già stato trasferito a Parigi e fatto innalzare, in Place de la Concorde, dall’ingegnere Jean Baptiste Lebas, il 25 ottobre 1836.

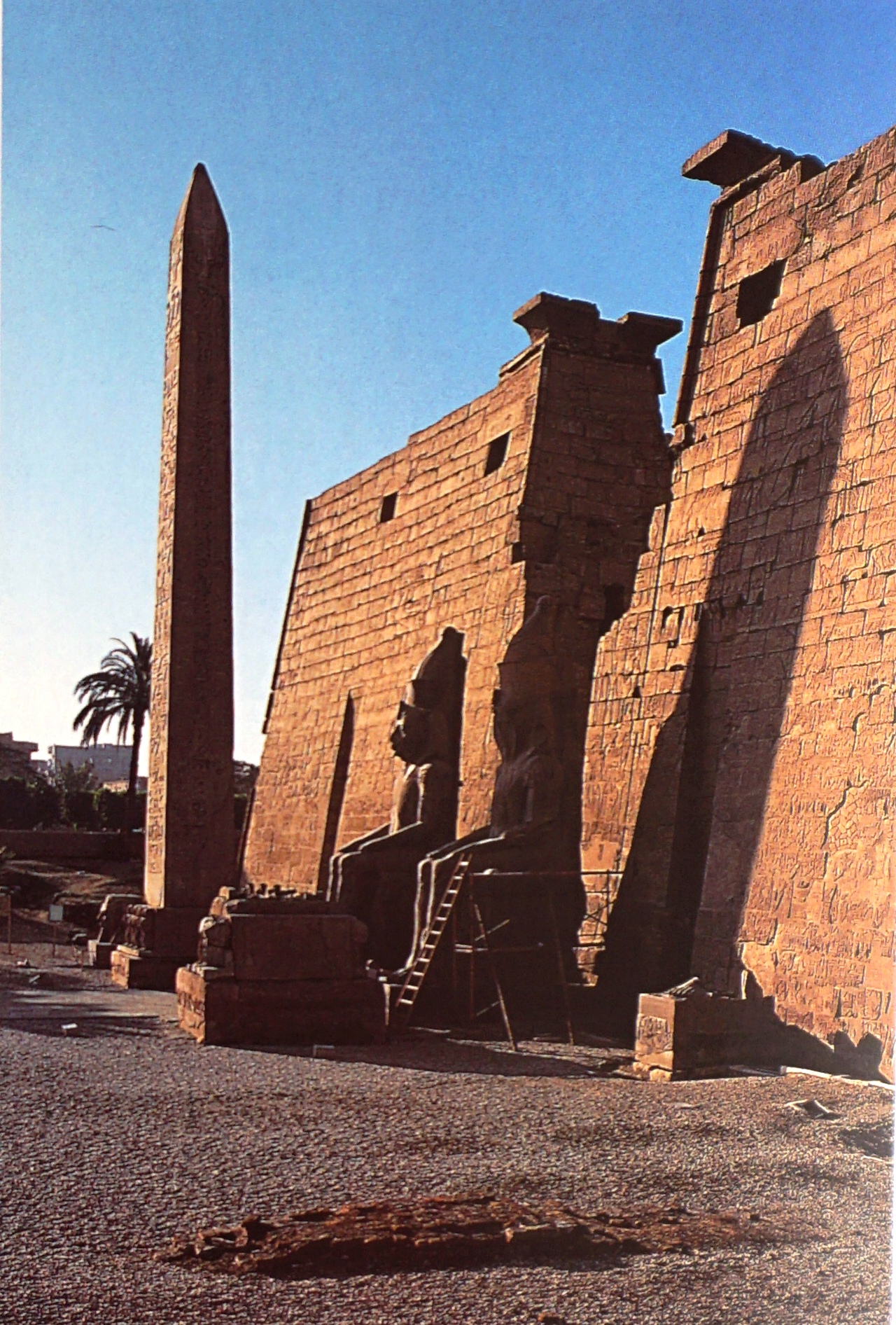
* Il Viale delle Sfingi (wi.nṯr, “il percorso del dio” in egiziano antico) fu realizzato contemporaneamente al tempio di Luxor (‘Ipt rsyt, “l’ harem meridionale”) edificato per volontà di Amenhotep III sui resti di un santuario risalente al Medio Regno. Tuttavia, dalle raffigurazioni presenti nella Cappella Rossa, a Karnak (‘Ipt swt, “il più venerato dei luoghi”) apprendiamo che fu la regina Hatshepsut , che regnò all’incirca dal 1506 al 1493 a.C., la prima a realizzare questa via processionale con sfingi a sua somiglianza e un pilone a Karnak. Inoltre, lungo il percorso che partiva dall’ VIII pilone, la sovrana aveva fatto erigere sei cappelle dedicate ad Amon-Ra, ciascuna con una ben precisa funzione e i cui resti sono stati ritrovati durante i lavori di scavo e ricostruzione. Pertanto, è verosimile che Amenhotep III si limitò ad un rimaneggiamento di questo Viale. Dopo di lui, la sacra via processionale fu oggetto di diversi interventi: Amenhotep IV (Akhenaton) fece modificare le sfingi alternando immagini sue e di Nefertiti; in seguito Tutankhamon, ripristinando gli antichi culti, le rielaborò facendo scolpire teste a forma di ariete in onore ad Amon. Successivamente altri faraoni apportarono il loro contributo costruendo edicole per la sosta delle imbarcazioni sacre. Infine, Ramses II aggiunse un estensione al tempio di Luxor distorcendone l’asse, ma allineandolo in maniera perfetta al Viale delle Sfingi.
Ma certamente, l’intervento di restyling più massiccio fu quello operato da Nectanebo I, sul trono d’ Egitto dal 380 al 362 a.C e fondatore della XXX dinastia, che lasciò la versione che ancor oggi vediamo. Davanti al pilone di Ramses II, Nectanebo fece edificare una corte (detta anche dromos) e, lungo il Viale sostituì le sfingi criocefale con altre a propria immagine. In effetti, quelle che si presentano ai nostri occhi sono tipiche del periodo tardo; scolpite in un unico blocco di arenaria e poste su un piedistallo dello stesso minerale, mostrano tratti che richiamano i lineamenti del faraone ed elementi caratteristici della XXX dinastia: il peculiare sorriso, il copricapo nemes sormontato dal cobra e la barba posticcia. Sulle basi di appoggio, lungo tutti i lati, è incisa una linea di iscrizioni geroglifiche contenente il cartiglio e vari testi dedicati al sovrano. (Fonte: Tiziana Giuliani, Mediterraneo Antico, 4 novembre 2021)
Tebe. Parte sesta: Luxor, uno dei colossi di Ramses II e il colonnato di Amenhotep III, 1° dicembre 1838.
In origine il pilone di Ramses II era fronteggiato oltre che dai due obelischi, anche da sei enormi statue del sovrano, ma Roberts, durante la sua visita, poté ammirare soltanto il monolito superstite (l’altro come abbiamo visto aveva già preso la via di Parigi) e i busti di due colossi di granito scuro che emergevano dalla sabbia. Una terza, gigantesca scultura, oggi posta davanti alla torre destra, giaceva sommersa dai detriti; era realizzata in granito rosa e anch’essa raffigurava il faraone, ma in posizione eretta. Sulla spalla desta del colosso oggetto di questa litografia (Immagini n. 1-2) è visibile il cartiglio contenente i geroglifici.


La seconda litografia presentata (Immagini n. 3-4) ci offre uno scorcio del cortile colonnato voluto da Amenhotep III. Si tratta di un grande spazio aperto, di 52 metri di larghezza per 46 di profondità, attorniato su tre lati da due file di colonne fascicolate a capitello chiuso. Anche questa struttura si presentò a Roberts semisommersa dai detriti e gran parte delle colonne, rovinate al suolo, erano ormai completamente sepolte.
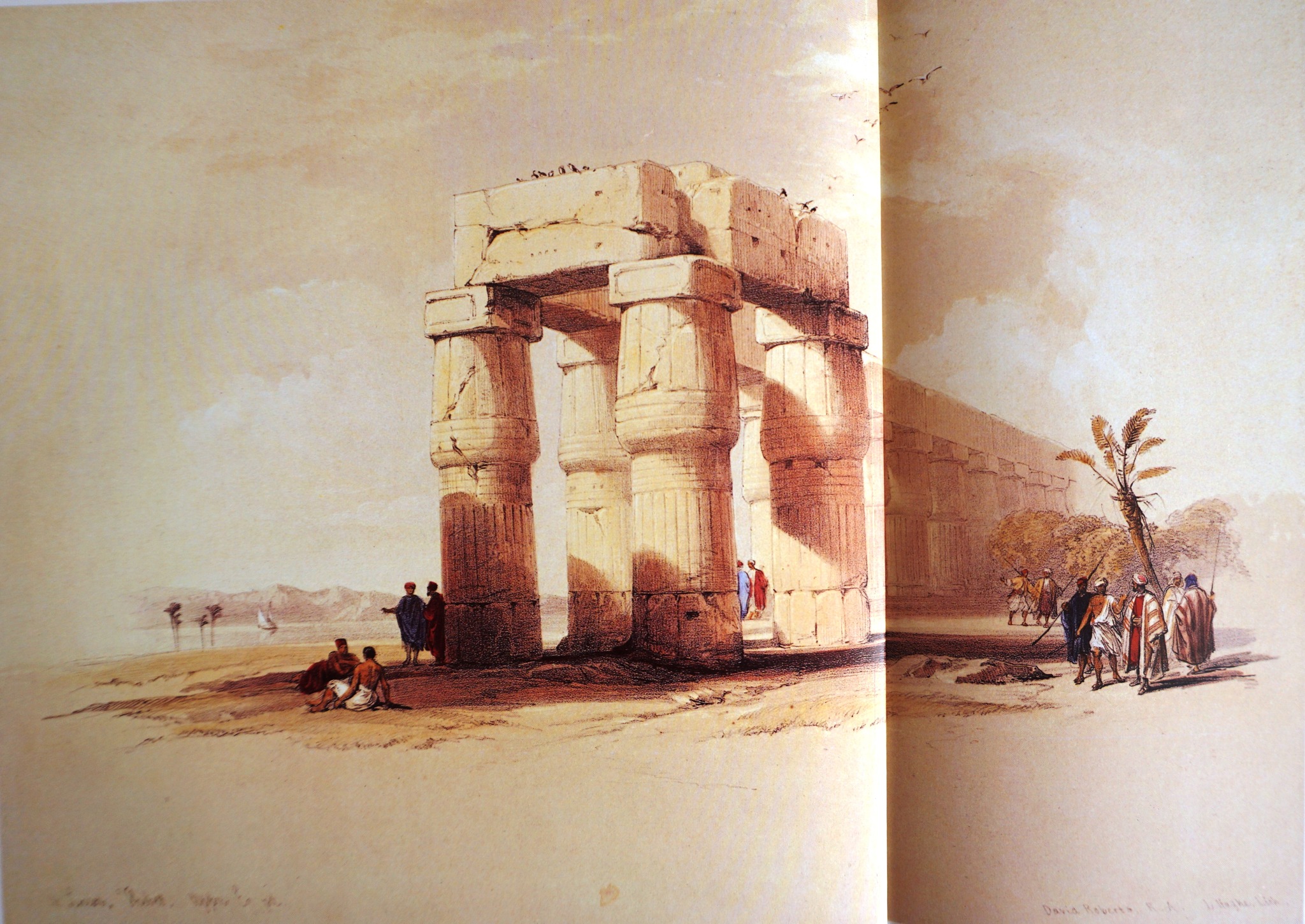
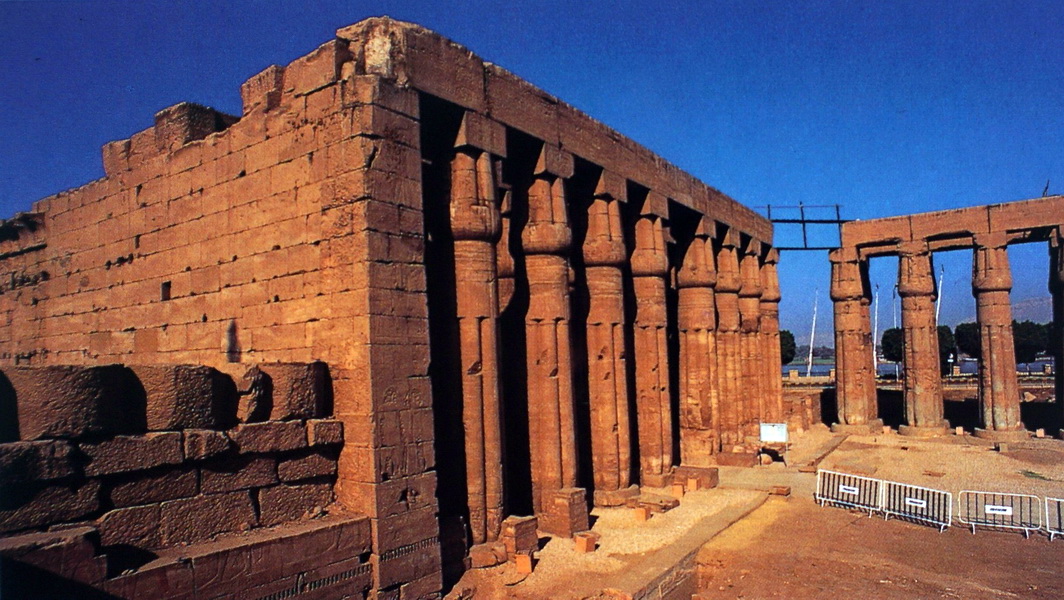
Il tempio di Luxor svolgeva una funzione molto complessa. Ogni anno, nel secondo o terzo mese della stagione dell’inondazione (“Akhet”), si celebrava la festa di Opet (“ḥeb Ipet”) durante la quale il simulacro del dio Amon, veniva rimosso dal grande tempio di Karnak e posto sulla barca sacra. Obbedendo ad un magnifico cerimoniale, il battello era seguito da altre tre imbarcazioni sacre: la prima con a bordo la statua di Mut, consorte di Amon, la seconda con quella del loro figlio Khonsu ed infine, la terza con il faraone in persona. La processione risaliva lentamente il corso del Nilo fino a giungere all’altezza del tempio di Luxor che si ergeva in posizione sufficientemente elevata rispetto al piano dei terreni di coltura, da non rischiare di rimanere allagato durante le piene più abbondanti. A questo punto le statue venivano prelevate e sistemate su barche simboliche portate a spalla di sacerdoti; una volta superato il pilone di ingresso, avanzavano tra le colonne del santuario fino a giungere al naos nel quale venivano collocate, ciascuna in una diversa cella, dove rimanevano per dieci giorni. Durante questo periodo Amon, rinnovava la sua simbolica unione mistica e carnale con la dea Mut, provvedendo a fecondare l’ Egitto ancora una volta.
Analogamente, il faraone, nella semioscurità delle stanze più segrete del tempio, incontrava la Grande Sposa Reale.
Per tutta la durata della festa il popolo, accorso in gran numero, manifestava la sua gioia ed elargiva offerte votive tanto più copiose quanto più abbondante fosse stato il raccolto. Inoltre, le donne desiderose di rimanere incinte, si recavano in pellegrinaggio per invocare l’intercessione di Amon che, sotto le sembianze del dio itifallico Min, prometteva fecondità.
Dopo dieci giorni di festa e cerimoniali le statue venivano sistemate nuovamente sulle barche sacre per far ritorno a Karnak. Il faraone, che dalla lunga e fastosa cerimonia ne usciva rigenerato e riconfermato nel suo ruolo regale, poteva allora assicurare un altro anno di prosperità al suo popolo certo che la benedizione di Amon avrebbe garantito raccolti ancora una volta abbondanti.
Tebe. Parte settima: la sponda occidentale del Nilo vista da Luxor, 1° dicembre 1838.

Prima di lasciare Luxor, Roberts trovò il tempo di realizzare quest’ultima tavola che illustra una veduta d’assieme delle rovine che si estendono lungo la sponda occidentale del Nilo. Per raggiungere la posizione migliore l’artista si arrampicò su uno degli architravi del colonnato che circonda il cortile di Ramses II, nel tempio di Luxor (Immagini n. 1 e n. 2). Da quel punto di osservazione, infatti, la vista poteva spaziare liberamente sulla piana dove i faraoni del Nuovo Regno avevano edificato i propri templi funerari.
Osservando la litografia, da sinistra verso destra, possiamo riconoscere il tempio di Ramses III a Medinet Habu, poi, del tutto isolate, le gigantesche statue dei cosiddetti Colossi di Memnone, il Ramasseum ed infine, all’estremità destra, il tempio di Seti I, nelle cui vicinanze sorgeva il villaggio di Goorna, oggi noto come Qurnah. Alle spalle di quest’ultimo ha inizio la celeberrima Valle dei Re, che per circa cinquecento anni (dal 1550 a.C. al 1069 a.C. circa) fu utilizzata come estrema dimora per le spoglie dei sovrani dalla XVIII alla XX dinastia.
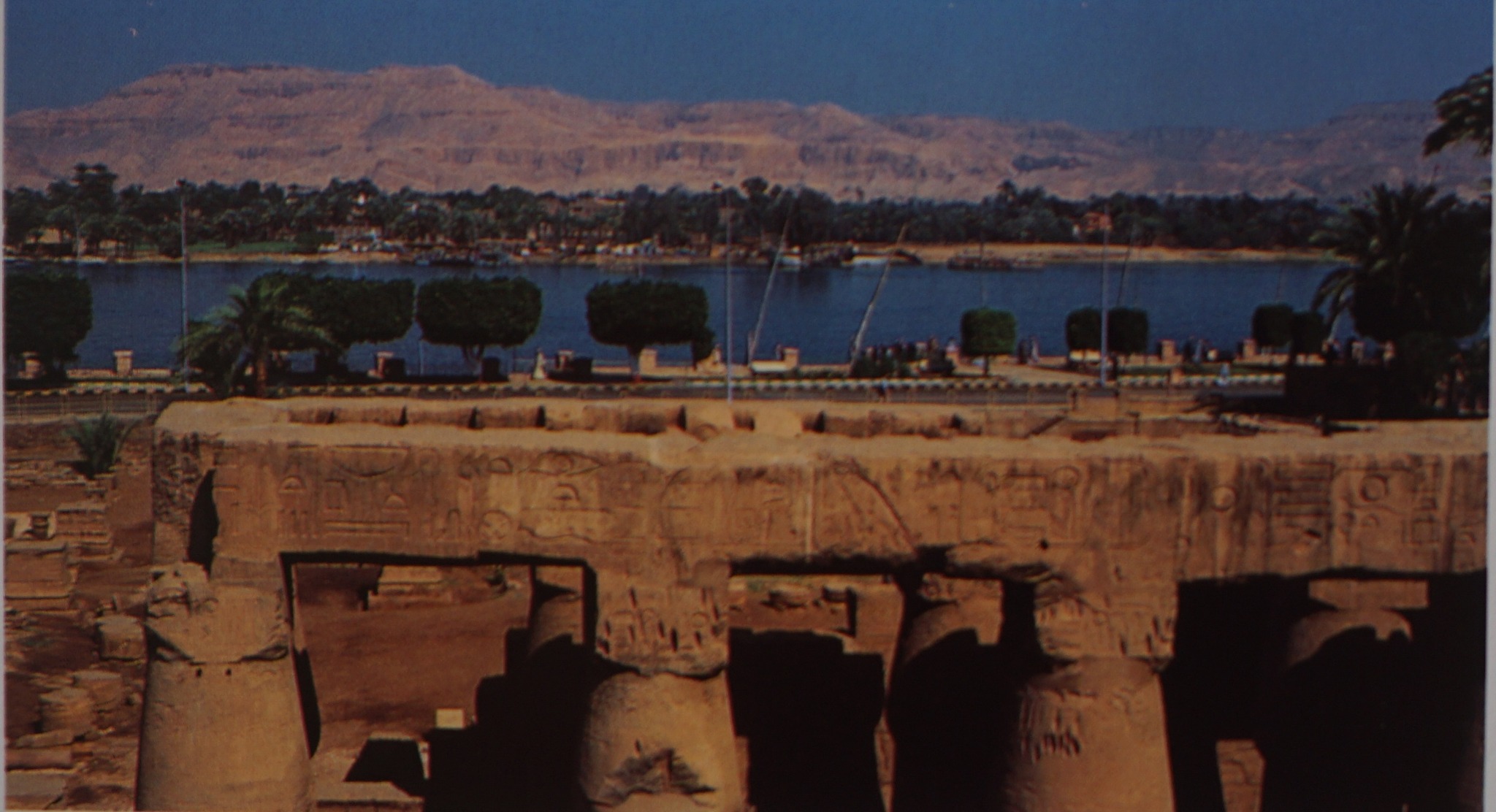
Durante l’Antico Regno, i potenti re dell’epoca avevano rivoluzionato l’architettura egizia erigendo piramidi come dimora per l’eternità. Con Thutmose (Ḏḥwty ms) I, primo faraone della XVIII dinastia, si avvia l’ altrettanto innovativa consuetudine di separare il tempio funerario dal luogo di sepoltura per il quale la scelta ricadde su un’area, a circa tre chilometri dalla sponda occidentale del Nilo, in un grande wadi incuneato nella montagna occidentale tebana cui gli egizi diedero il nome di Ta-sekhet-aat (IlGrande Campo) o, più semplicemente Ta Int (La Valle). Il sito è oggi noto come Valle dei Re o con il nome arabo wādī Bībān al-Mulūk (La valle delle porte dei re). Da allora, questa soluzione fu adottata continuativamente dai successori fiduciosi che le loro dimore per l’eternità, scavate nella roccia, rimanessero inviolate (speranza andata delusa dal momento che furono tutte depredate, già nell’antichità, ad eccezione di quella di Tutankhamonche è l’unica pervenutaci quasi intatta).
All’imboccatura della Valle, sorsero i templi in onore di Amenhotep I, II e III, Thutmose II, III e IV, Seti I, Ramses I, II, III e IV, Merenptah, Merenptah-Siptah.Di tutti questi edifici, che i faraoni lungo l’arco di tre dinastie dedicarono alla triade tebana (Amon, Mut e Khonsu)e al proprio culto, ci sono pervenuti solo quelli costruiti in pietra, mentre tutti gli altri, edificati in mattoni crudi, sono praticamente scomparsi.
Tebe. Parte ottava: Il tempio di Seti I a Tebe, 2-3 dicembre 1838.
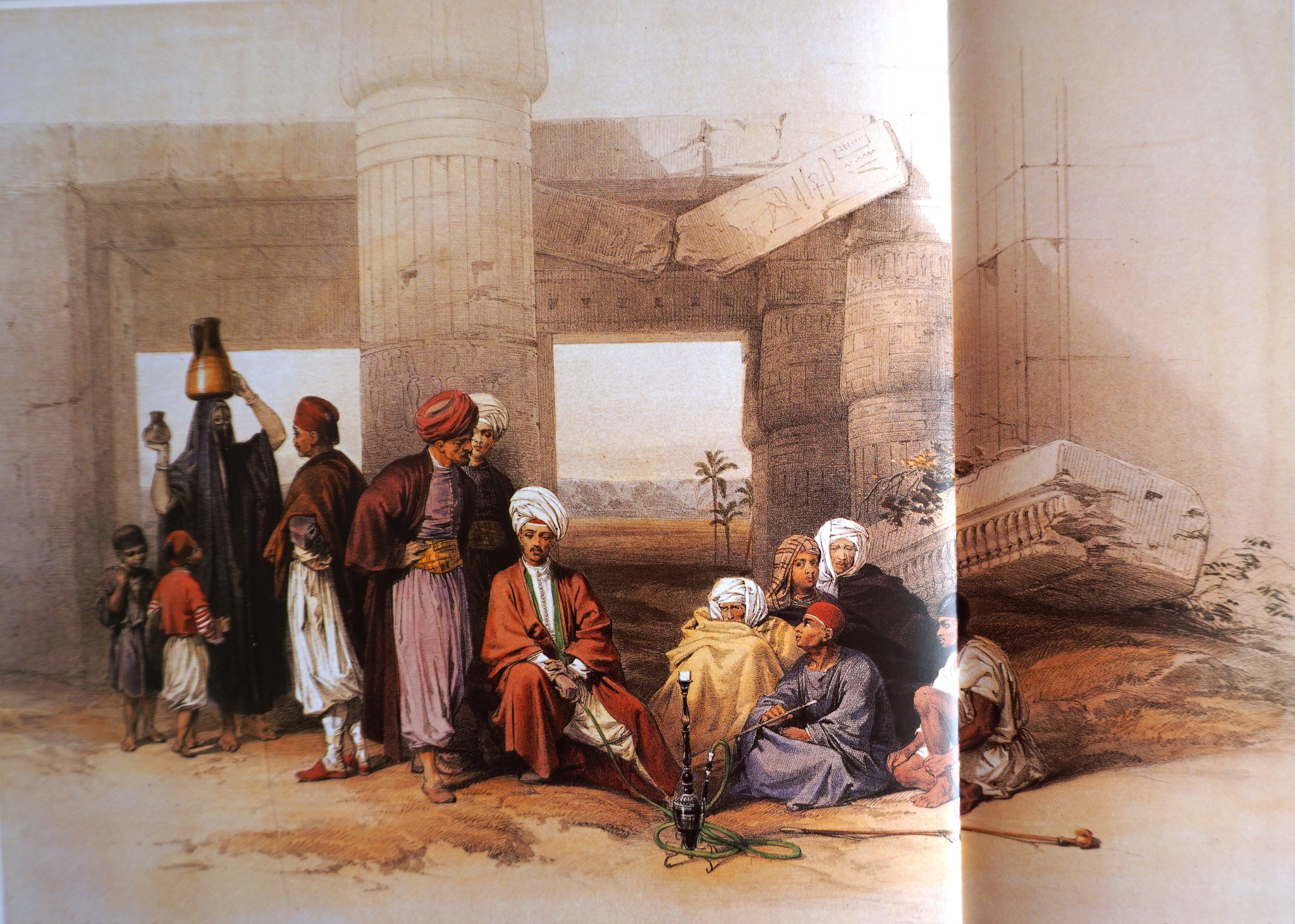
La prima domenica di dicembre Roberts, astenendosi dal lavoro nel rispetto dei precetti cristiani, la trascorse visitando i dintorni di Qurnah. Il lunedì successivo, alle prime luci dell’alba, si rimise subito in marcia, deciso com’era a raggiungere la Valle dei Re. Durante il tragitto si concesse una sosta presso il tempio funerario di Seti I le cui rovine giacciono nella piana di Tebe a ridosso della zona coltivata.
Edificata sulle fondamenta di un edificio preesistente, l’imponente struttura dedicata al dio Amon, fu voluta dal faraone per perpetuare la propria memoria e quella del padre Ramses I. Purtroppo non visse abbastanza a lungo da vedere completata la sua opera che fu completata dal figlio Ramses II. Attualmente il complesso appare molto deteriorato. Rimangono resti del primo e del secondo pilone, come pure dei due vasti cortili; della lunga via processionale che conduceva al tempio ci sono pervenute soltanto due sfingi. Il portico che concludeva ad est il secondo cortile, a ridosso del pilone minore, ha invece conservato nove delle dieci colonne fascicolate originarie. Seguendo uno schema piuttosto insolito, il tempio presenta tre portali che mettono in comunicazione con i settori dedicati ai tre faraoni. Una sala ipostila centrale, circondata da diversi ambienti adibiti a depositi per le barche e gli arredi sacri, si apre sul naos il cui soffitto era sorretto da quattro pilastri. Purtroppo, le cappelle di Ramses I e di Ramses II, così come le sale accessorie hanno subito gravissime devastazioni.
La scena ritratta da Roberts in questa litografia ha come sfondo una sezione del portico alla cui ombra trovano refrigerio diversi personaggi abbigliati in modo pittoresco. (Immagini n. 1÷3).
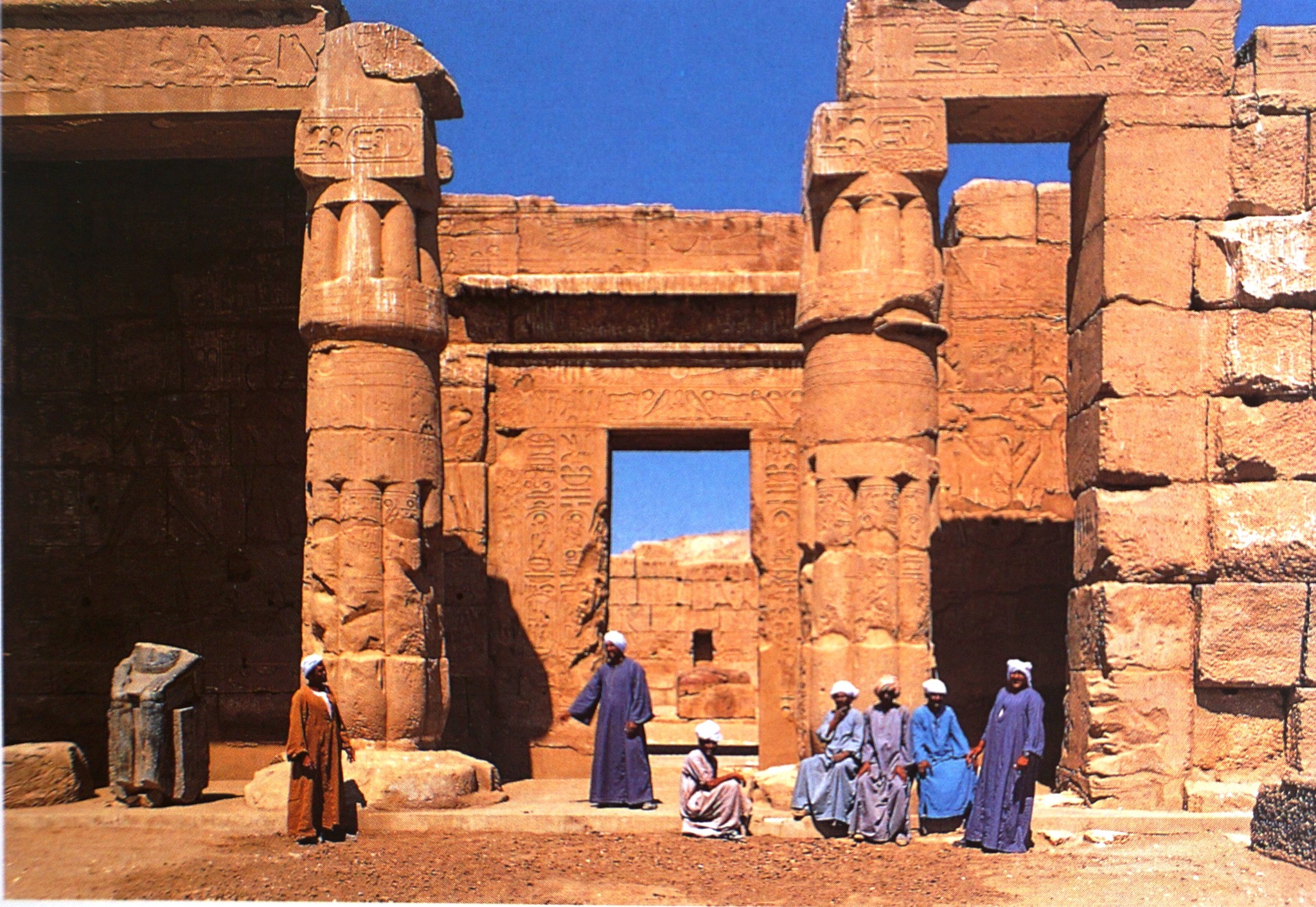

Tebe. Parte nona: la Valle dei Re, 3 dicembre 1838.
Lasciato il tempio,Roberts si diresse verso la Valle dei Re dove già si era soffermato il 22 ottobre limitandosi, senza eseguire alcun disegno, a prendere appunti sulle tombe che più lo avevano colpito, come quella di Seti I che, solo ventuno anni prima, era stata scoperta da Giovanni Battista Belzoni. La Valle, circondata da rocce a strapiombo, si sviluppa con andamento sinuoso ai piedi del monte el-Qurn, noto anche col nome di Cima Tebana, che presenta una caratteristica ed evocativa forma piramidale (Immagini n. 1-2).

Il suo nome arabo, Biban el-Moluk, ossia “Le porte dei Re”, allude agli ingressi dei sepolcri, scavati nella roccia calcarea, che ospitarono le spoglie mortali dei sovrani della XVIII, XIX e XX dinastia durante un arco temporale durato circa cinquecento anni (all’incirca dal 1543 al 1069 a.C.). Questo sito, destinato a divenire uno dei più celebri al mondo, deve la sua esistenza, con ogni probabilità, a Thutmose I, che rompendo una tradizione antichissima, decise che la sua dimora eterna fosse separata dal tempio funerario e occultata in un luogo ben protetto. L’architetto Ineni, progettò, allora una tomba a pozzo, scavata nella impervia parete rocciosa della Valle, sul cui fondo fu ricavata una camera sepolcrale per accogliere il sarcofago e il corredo del defunto. Da quel momento, fu inaugurato uno schema di tomba reale adottato dai sovrani del Nuovo Regno e ulteriormente sviluppato con l’aggiunta di corridoi, camere secondarie e sale ipostile. Una volta, conclusi i riti funebri, l’ ingresso veniva sigillato per sempre ed il culto reale veniva praticato nei relativi templi funerari eretti nella pianura al confine con le aree coltivate. Diversamente da quanto sarebbe logico aspettarsi, gli ingressi delle tombe non erano affatto segreti. Nella Valle, infatti, era perennemente attivo un servizio di controllo esercitato da appositi guardiani incaricati di controllare periodicamente che i sigilli fossero intatti. Ciò nonostante, tali accorgimenti, si rivelarono del tutto insufficienti a proteggere i sontuosi corredi funerari dalle razzie dei profanatori dell’epoca che, evidentemente, si avvalevano di complicità tra gli stessi addetti al controllo. Siamo ben al corrente, infatti, grazie a due papiri e ad altre testimonianze pervenuteci, che già durante la XX Dinastia si erano verificate violazioni di tombe; la pratica divenne poi sempre più frequente tanto che, nel tempo, quasi tutte le sepolture vennero depredate costringendo i sacerdoti tebani della XXI dinastia ad occultare le spoglie violate di un gran numero di faraoni in un nascondiglio segreto, scoperto (o meglio riscoperto, in quanto già dal 1860 la famiglia Abd el-Rasul ne prelevava reperti) nel 1881 da Émil Brugsch. Si tratta della famosa “cachette” di Deir el-Bahari, più precisamente tomba TT320 (che in precedenza era stata indicata come DB320).

L’unica sepoltura che rimase quasi intatta fu quella di Tutankhamon (la tomba KV62),riportata alla luce, assieme al suo celeberrimo e incomparabile tesoro, da Howard Carter e Lord Carnarvon il 4 novembre 1922.
Tebe. Parte decima: Il tempio di Tolomeo IV a Deir el-Medinah 3 dicembre 1838.
Attualmente, la Valle di Re è percorsa da una strada che ricalca il tragitto utilizzato nell’antichità per trasportare i sarcofagi reali da Tebe alla loro dimora per l’eternità. Diversamente, gli operai addetti alla costruzione delle tombe, e che per generazioni vissero nel villaggio di Deir el Medinah, utilizzavano, per giungere al lavoro, una via molto più breve (e tuttora percorribile) che scavalca il crinale posto tra le due vallate parallele. Dopo aver visitato le tombe, Roberts scelse proprio questo sentiero per far rientro a Qurnah ed in breve tempo si ritrovò tra le rovine del villaggio che per circa cinque secoli ospitò gli addetti alla necropoli reale. Molto ben conservato, nelle immediate vicinanze, sorgeva un tempietto fatto erigere da Tolomeo IV Filopatore (III sec. a.C.) in onore di Hathor e Ma’at, le divinità protettrici dei sepolcri tebani. Inoltre, il piccolo santuario era dedicato a Imhotep*, il celeberrimo genio dell’antichità che circa 2.600 anni prima aveva progettato per Djoser la piramide a gradoni di Saqqara, e ad Amenhotep figlio di Hapu, che, sotto il regno di Amenhotep III, progettò il tempio di Luxor; entrambi, in tarda epoca, questi due grandi personaggi furono divinizzati.
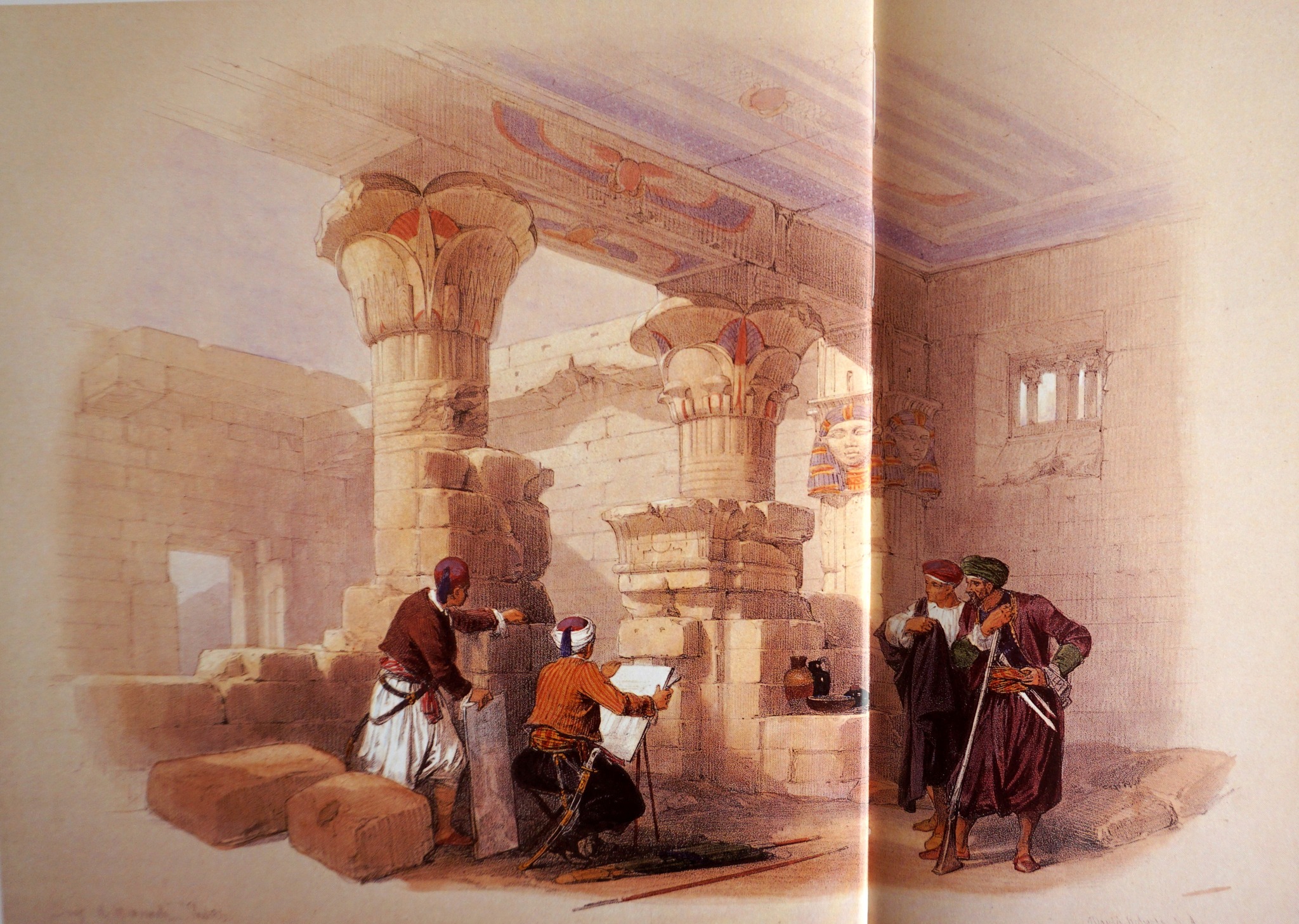
L’edificio, la cui costruzione continuò sotto Tolomeo VI Filometore e fu completato da Tolomeo Evergete nel II sec. a.C., presenta una pianta canonica: all’atrio ipostilo, ormai senza il soffitto, segue un piccolo vestibolo lungo il quale si aprono le porte di tre cappelle affiancate. L’architrave del vestibolo è sorretto da due colonne con capitelli decorati con ricchi motivi floreali e da due graziosi pilastri hathorici. La finestrella visibile nella tavola dava luce ad una scala che conduceva sul tetto a terrazza (Immagini n. 1-2).

* Per approfondimenti su Imhotep, consiglio la pagina situata a questo link: https://laciviltaegizia.org/2022/10/29/imhotep/
* Per approfondimenti su Amenhotep, figlio di Hapu: https://laciviltaegizia.org/…/29/amenhotep-figlio-di-hapu/
Tebe. Parte undicesima: I colossi di Memnone, 4 dicembre 1838.
L’intera giornata del 4 dicembre vide Roberts impegnato a ritrarre, da tre diverse angolazioni, i colossi di Memnone. Queste monumentali statue gemelle, già celebrate nell’antichità, sono tutto ciò che rimane del tempio funerario di Amenhotep III, progettato dall’architetto Amenhotep, figlio di Hapu. L’edificio, il maggiore di Tebe Ovest, fu costruito essenzialmente con mattoni crudi che, a causa della vicinanza col Nilo, subirono l’azione delle sue esondazioni; ridotto praticamente in rovina, fu successivamente utilizzato come cava di materiali da costruzione. Analoga sorte toccò alla magnifica reggia del sovrano che sorgeva a Malqatta, pochi chilometri a nord-est del tempio. Questo grandioso palazzo reale, circondato da una possente cinta muraria al cui interno erano presenti anche magazzini per lo stoccaggio e la conservazione di derrate alimentari, era fronteggiato da un enorme bacino artificiale, il Birket Abu, collegato al fiume per mezzo di un canale navigabile.
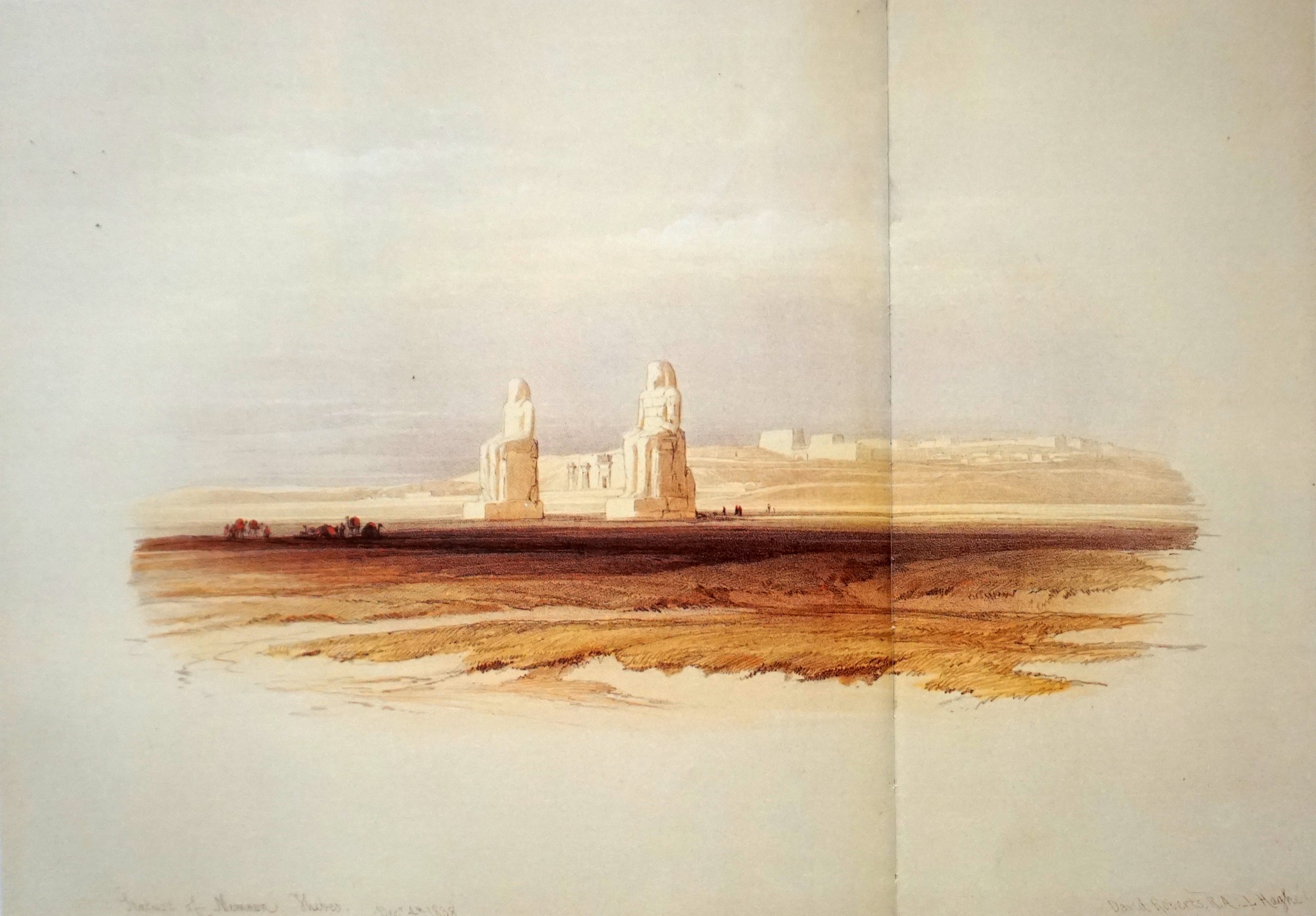
Nella prima delle litografie presentate (Immagini n. 1-2), Roberts ci offre una visione d’assieme dei colossi che si stagliano imponenti nella pianura tebana. Le due statue, alte circa 18 metri, devono il loro nome ai greci che, probabilmente per un errore di trascrizione del nome egizio, le associarono all’eroe mitologico Memnone. Nel 27 a.C. furono fortemente danneggiate da un sisma, che verosimilmente, inflisse il colpo di grazia anche a ciò che rimaneva del tempio retrostante. A seguito di questo evento, il colosso più settentrionale, cominciò ad emettere un caratteristico e lamentoso suono quando veniva riscaldato dai raggi del sole nascente. Questo evento rinsaldò ancora di più la leggenda, nata in epoca tolemaica, che riconosceva nelle due statue l’eroe omerico Memnon, ucciso da Achillesotto le mura di Troia, il cui simulacro ogni mattina accoglieva con un dolce lamento le carezze della madre Eos (Aurora).

Nella seconda litografia, Roberts ritrasse i colossi da sud-ovest (Immagini n. 3-4) evidenziando accuratamente i bassorilievi visibili sui fianchi dei troni dove le divinità del Nilo intrecciano un loto ed un papiro, le piante araldiche dell’Alto e del Basso Egitto, a simboleggiare l’unione delle Due Terre (Immagini n. 3-4).

Nei primi secoli dell’era volgare i viaggiatori greci e romani che si recavano a Tebe erano irresistibilmente attratti dai colossi. Il fenomeno della statua “parlante”, già documentato dallo storico e filosofo greco Strabone, fu confermato, nel II secolo d.C. dal geografo Pausania e dal poeta e retore Giovenale. Le numerose iscrizioni in greco e latino, ancora presenti sulla parte inferiore della statua settentrionale, provano che fosse solo quest’ultima a produrre il caratteristico lamento. Tra le tante dediche vi figurano quella della poetessa Giulia Balbilla, che nel 130 d.C. accompagnò nel loro viaggio in Egitto l’imperatore Adriano e sua moglie Sabina, e quella del poeta greco Asklepiodotos. Per volere di Settimio Severo, nel 199 d.C. si provvide al restauro del monumento. Da lì in avanti cessano le notizie riguardo ai suoni emessi dalla statua.

L’ultima litografia dedicata da Roberts ai Colossi di Memnone (Immagine n. 5) ce li presenta inondati dalla luce del sole nascente che suggestivamente si riflette nella piana allagata.

Tebe. Parte dodicesima: Il Ramesseum, 5 dicembre 1838.
Il 5 dicembre, si verificò un evento raro ed inatteso: un violento temporale si scatenò sulla pianura tebana avvolgendola in una cupa oscurità, mentre bagliori di fulmini illuminavano le antiche rovine dando vita ad uno spettacolo di ancestrale bellezza. Naturalmente, Roberts non si lasciò sfuggire un’occasione pressoché irripetibile di ritrarre uno scenario pienamente rispondente alle suggestioni romantiche del tempo e il soggetto prescelto fu il tempio funerario di Ramses II (Immagine n. 1). Nonostante le ingiurie del tempo, il grande complesso, che Champollion aveva battezzato con il nome di Rhamesséion, rappresentava uno degli esempi più eleganti e compiuti di questo genere di architettura. Ancora in epoca classica, il tempio godeva di fama altissima, tanto che venne descritto con ammirazione dallo storico Diodoro Siculo ed anche dal geografo Strabone.
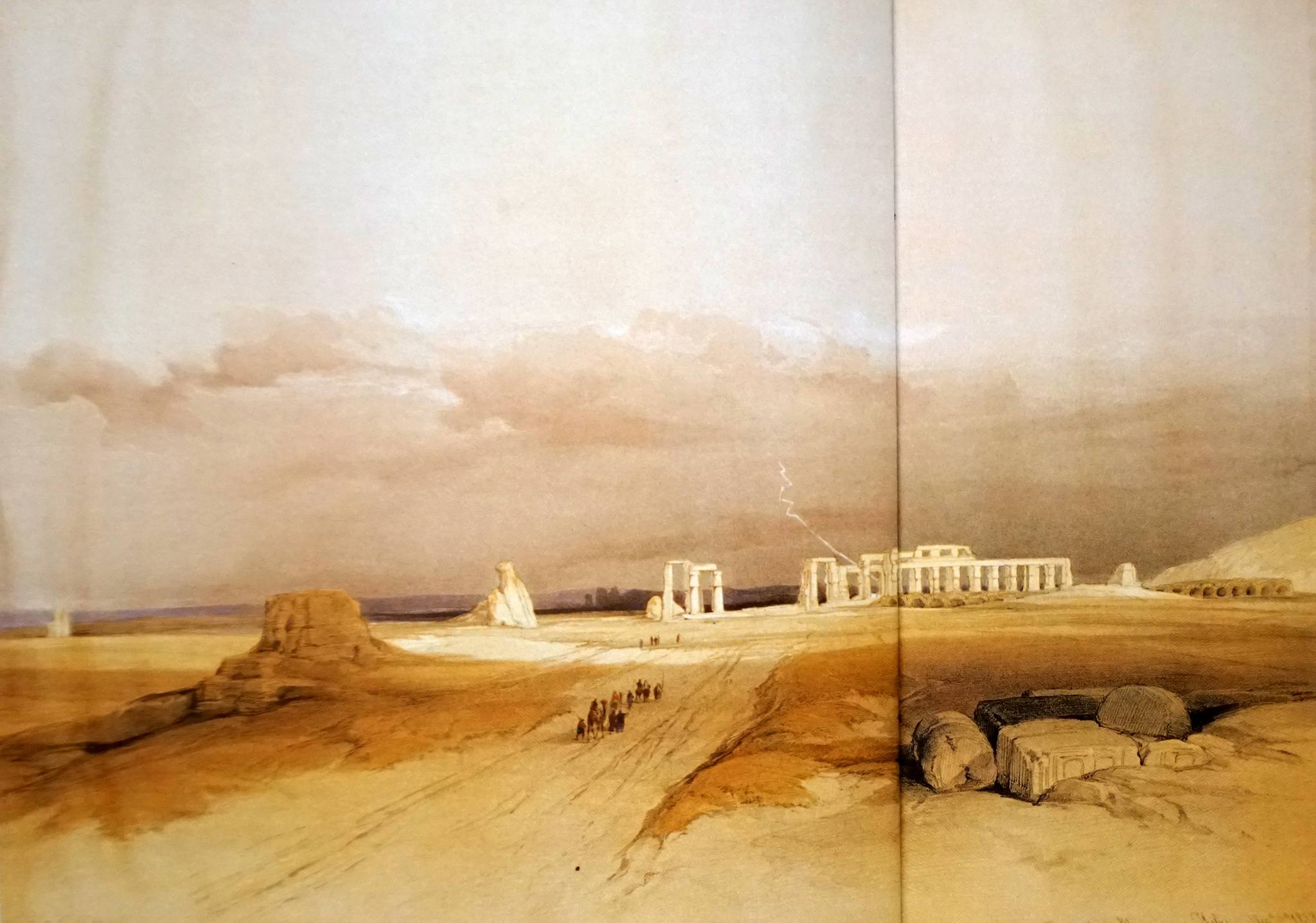
Originariamente, il Ramesseum era costituito da diversi edifici racchiusi in un recinto edificato con mattoni crudi. Tra questi, il tempio per il culto reale, dove si celebravano le imprese del faraone, un piccolo santuario dedicato alla madre Tuia e all’adorata moglie Nefertari, magazzini dove si custodivano le derrate per il sostentamento degli addetti ai servizi di culto, nonché la residenza reale dove Ramses II risiedeva durante le cerimonie. Sebbene sia entrato nell’uso comune definire questi complessi come “templi funerari”, appare chiaro, in considerazione delle molteplici funzioni cui erano destinati, che il termine sia sostanzialmente inesatto e, soprattutto, fuorviante; in realtà, questi sontuosi edifici erano utilizzati dai sovrani mentre essi erano ancora in vita e gli egizi, infatti, li indicavano come “Castelli dei Milioni di anni”. Tra l’altro, i faraoni vi celebravano la festa “heb-sed”, una sorta di giubileo, attestata sin dalle prime dinastie, che si teneva (almeno nominalmente) durante il trentesimo anno di regno e aveva lo scopo di rigenerarne magicamente la forza e la vitalità. Solo dopo la morte del re, divenuto egli stesso divinità, ed in associazione ad Amon-Ra, vi si svolgevano i servizi di culto funerario in suo onore.

La seconda tavola disegnata da Roberts ha per soggetto il colosso di Ramses II in trono che giace a terra ridotto in pezzi tra le rovine del tempio (Immagini 3-4). La gigantesca statua era posta dinanzi al secondo pilone e, in origine, era alta circa 18 metri. Realizzata in un sol blocco di granito rosso di Aswan, raffigurava il sovrano assiso in trono il cui nome è ancora ben leggibile nei cartigli incisi sugli avambracci e sul sedile. Sono state avanzate diverse teorie per spiegare la distruzione di questa meraviglia – tra cui un terremoto abbattutosi sulla regione nel 27 a.C. – ma è molto probabile che la responsabilità di un tale scempio sia da attribuire ai cristiani che ritenevano blasfema ogni immagine ricollegabile al “paganesimo” dell’antica religione egizia.
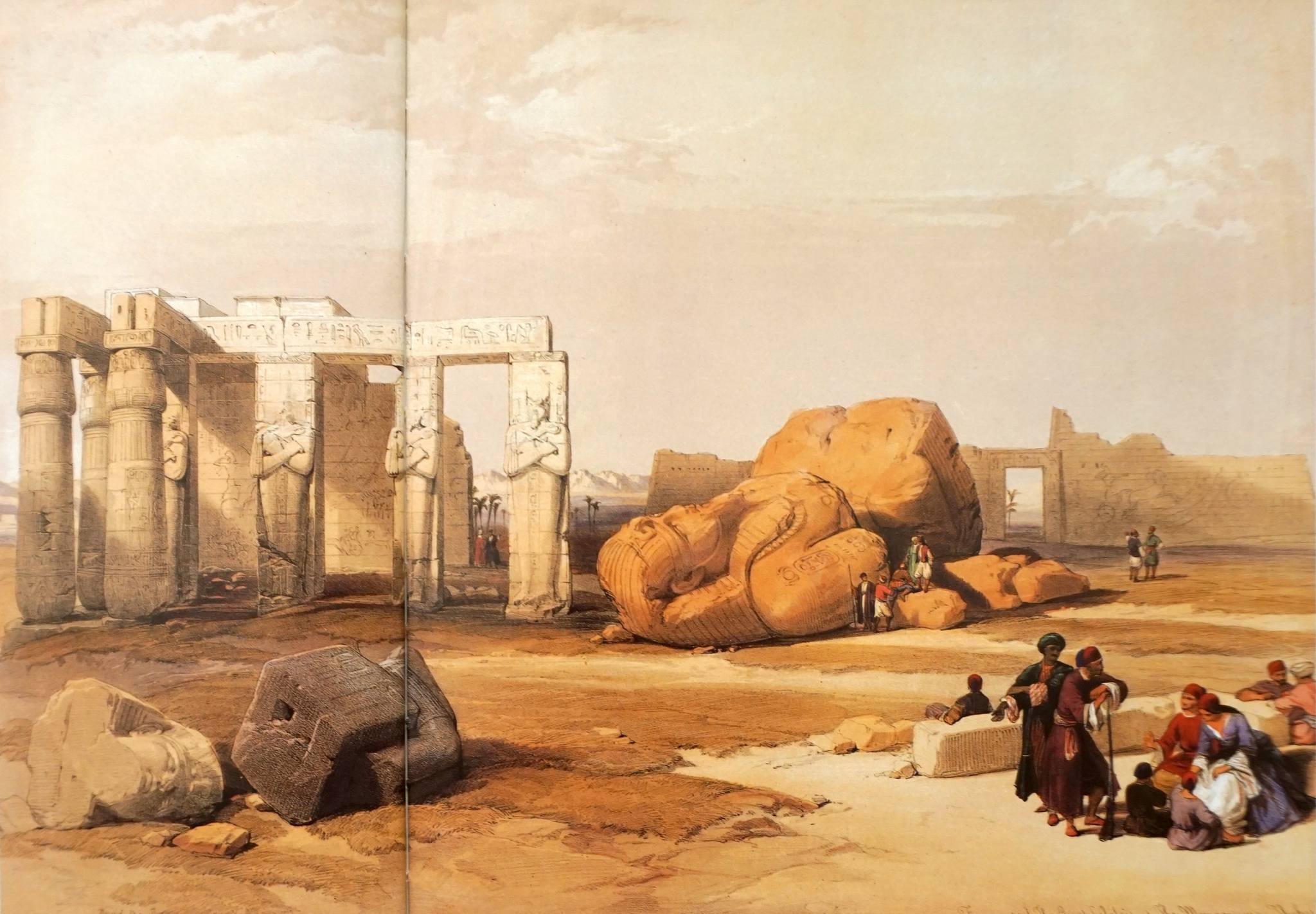
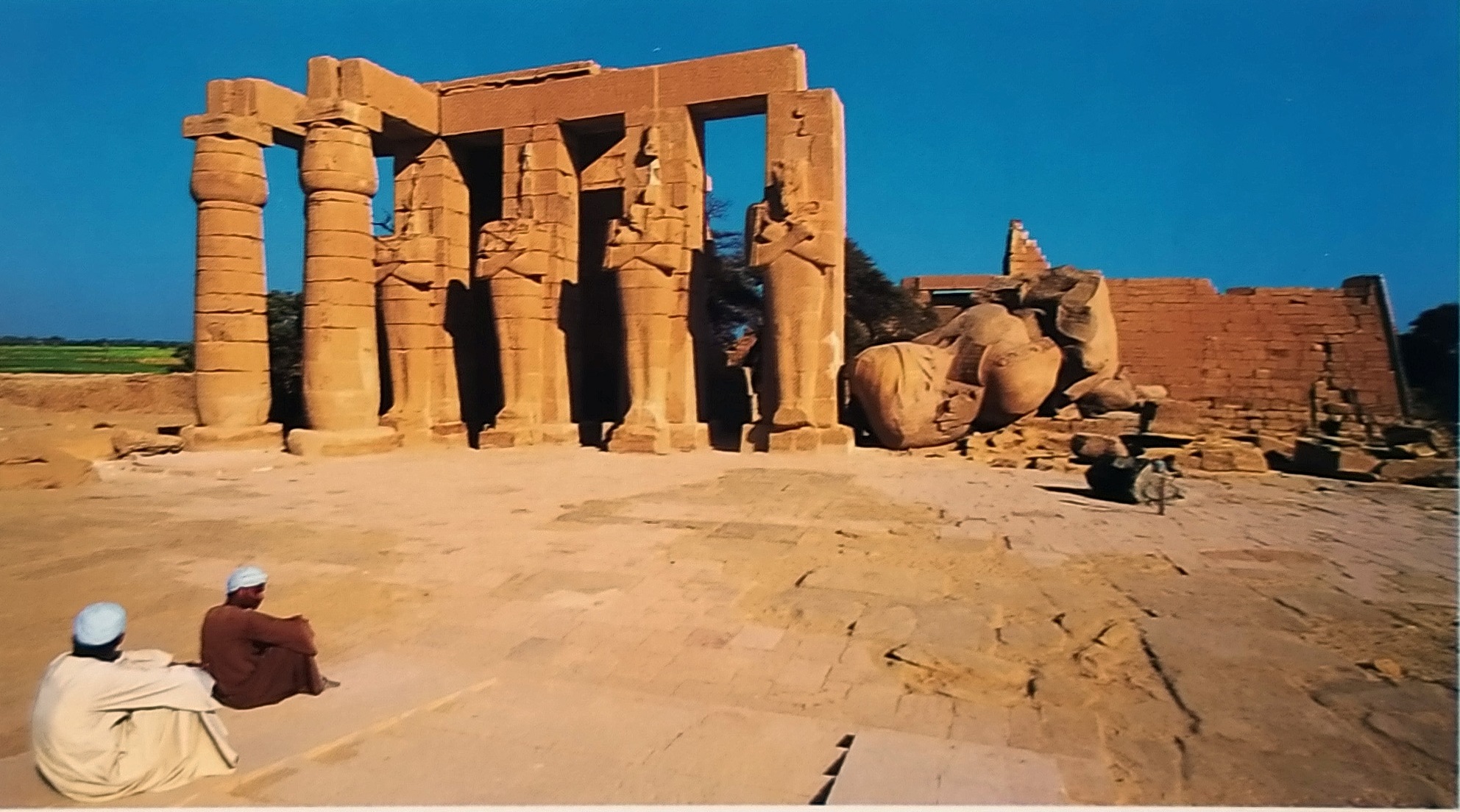
A sinistra dell’enorme busto giacente si ergono quattro pilastri osiriaci, resti del porticato che correva attorno al secondo cortile e, alle spalle, si ravvisano le scarse vestigia del secondo pilone. Ben visibili sullo sfondo a destra sono invece i ruderi del primo pilone con i bassorilievi che celebrano Ramses II mentre ferma gli Hittiti nella battaglia di Kadesh. In primo piano, giacciono i frantumi delle due imponenti statue del faraone che erano poste di guardia alla grande sala ipostila; la magnifica testa di una di esse,con parte del busto, soprannominata il “Giovane Memnone”, fu recuperata da Giovanni Battista Belzoni e trasportata al British Museum (Immagine n. 5).

Immagine n. 5 Testa e parte superiore del corpo della statua monumentale di Ramses II in granito rosa/grigio (facente parte di una coppia di statue posta davanti al portale del Ramesseum) con indosso un copricapo nemes e un diadema con urei (circa la metà del quale è perduta). Lo scultore sfruttò la bicromia della pietra per enfatizzare la distinzione tra corpo e viso; la parte dorsale è iscritta con registri verticali di geroglifici che riportano il nome e i titoli del re e parte di una dedica ad Amon-Ra. Nel 1817 si notò che sulla statua erano presenti tracce di colore e potrebbe quindi essere stata dipinta di rosso in antichità. (© British Museum, Sala 4 Descrizione: Busto colossale di Ramsete II, “Memnone il Giovane” Dal Ramesseum, Tebe, Egitto. XIX dinastia, 1250 a.C. circa.) (© ph.: Mujtaba Chohan durante una visita al British Museum)
Tebe. Parte tredicesima: Il tempio di Medinet Habu, 5 dicembre 1838.
A Medinet Habu, poco distante dal Ramesseum, si ergono le spettacolari rovine del tempio funerario di Ramses III, secondo faraone della XX Dinastia. L’area cultuale è delimitata da una possente cinta muraria in mattoni crudi sul cui lato meridionale si apre la bella “Porta del Sud”, incassata tra due alte torri, alla quale gli archeologi al seguito della spedizione napoleonica diedero il nome di “Il Padiglione” . Questa particolare struttura, individuabile nella litografia nel corpo di fabbrica più elevato, è interamente ricoperta di bassorilievi, per lo più di carattere bellico, che inneggiano alla gloria del faraone, seguendo la tradizionale rappresentazione propagandistica dell’epoca. Il tempio funerario di Ramses III propriamente detto sorge all’interno di una seconda cinta muraria oggi praticamente scomparsa. E’ uno degli esempi stilisticamente più riusciti ed eleganti dell’architettura egizia: due cortili, preceduti ognuno da un alto pilone, si succedono allineati lungo la direttrice sud-ovest/nord-est, seguiti, sempre in linea retta, da una parte coperta costituita da tre sale ipostile ed infine il naos. A sinistra del tempio sono ancora presenti i resti del palazzo reale, costituito da una sala ipostila per le udienze, dalla sala del trono e da numerosi ambienti sussidiari. Scavi archeologici hanno inoltre riportato alla luce tracce di un complesso abitativo che si estendeva all’intorno del palazzo. Nella litografia sono riconoscibili, sulla destra, gli accessi alle cosiddette “Tombe dei Nobili”, scavate nei contrafforti rocciosi della pianura tebana* (Immagini n. 1-2)
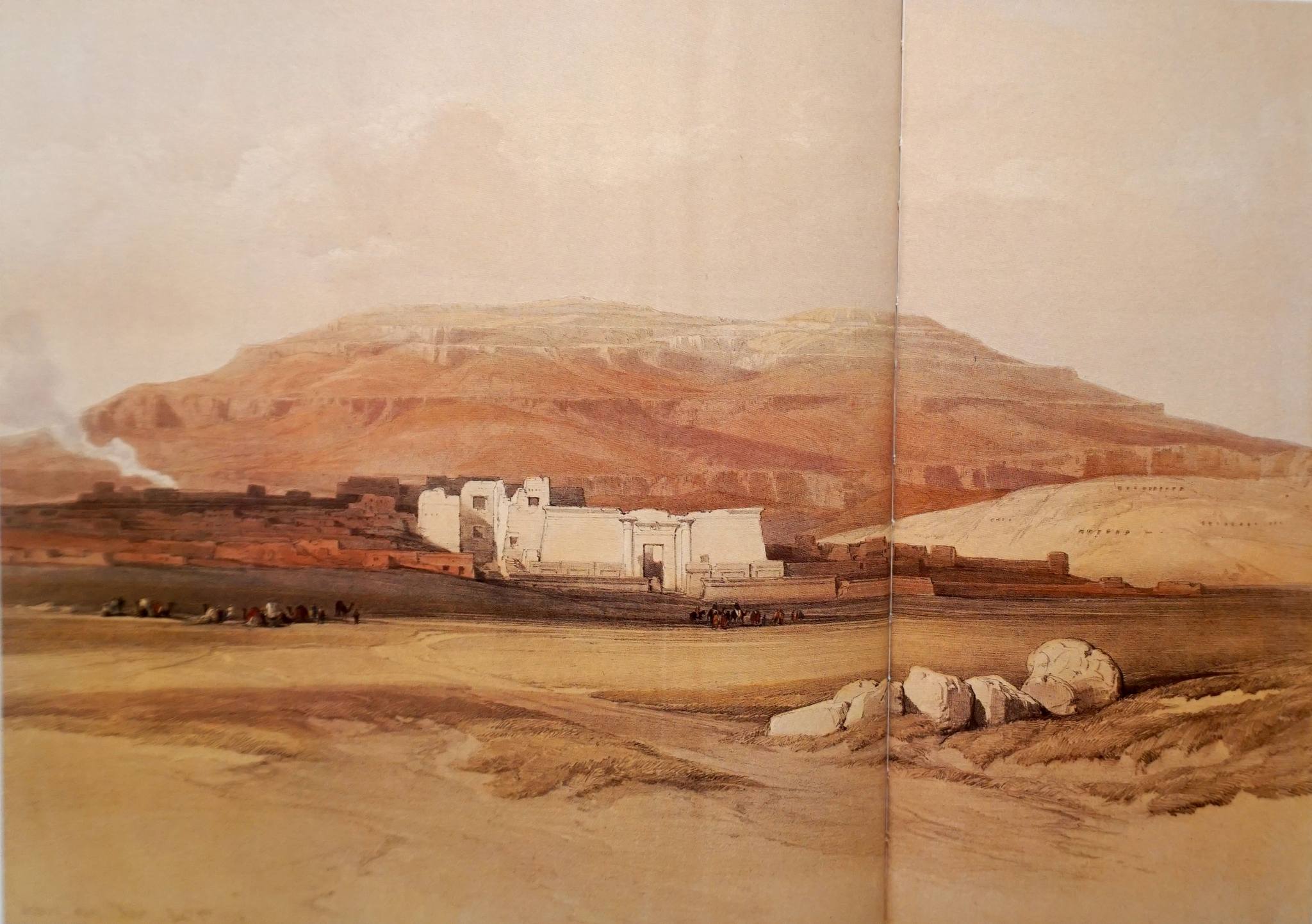

Nel 380 d.C., con l’editto di Tessalonica, l’imperatore Teodosio proclamava il Cristianesimo religione ufficiale dell’ Impero Romano, condannando implicitamente ogni forma di culto “pagano”. Questo portò, in Egitto, alla progressiva chiusura dei templi, molti dei quali furono trasformati in chiese.
Il tempio di Ramses III a Medinet Habu, divenne il nucleo di un grande centro abitato copto i cui resti erano ancora presenti, come si vede nella litografia precedente, all’epoca della visita di Roberts. All’interno del tempio, i monaci eressero addirittura una basilica dopo aver accuratamente ricoperto di intonaco le antiche strutture al fine di cancellare ogni traccia della religione egizia. Le navate della basilica erano sorrette da colonne in porfido sormontate da capitelli corinzi che Roberts ebbe modo di vedere ancora in situ e ritrasse nella sua veduta (Immagine n. 3).

A partire dal 1858 ebbe inizio, grazie ad Auguste Mariette, la campagna di scavi destinata a riportare i luoghi all’aspetto originario. Furono così abbattuti i resti del centro abitato e quelli della basilica interna al tempio, sicché le tavole dell’artista hanno assunto un importante valore documentario. Riportato alle sue antiche forme (Immagine n. 4), il secondo cortile appare oggi cinto da portici su ogni lato: a nord e a sud sono presenti i tradizionali pilastri osiriaci, gravemente danneggiati dai monaci cristiani, mentre a est e ad ovest si ergono dieci colonne a forma di papiro chiuso.

I rilievi che animano le pareti che, ironia della sorte, si sono ottimamente conservati proprio grazie all’intonacatura voluta dai monaci nell’intento di cancellarli per sempre, mostrano immagini di tipo militare, con chiari intenti propagandistici, oppure scene di devozione religiosa in cui sono rappresentate la solenne processione al seguito della barca sacra, l’apparizione del dio Min, l’uscita del faraone dal palazzo e il suo ingresso al tempio.
* Chi desiderasse saperne di più sulle Tombe dei nobili, può consultare lo splendido articolo pubblicato da Giuseppe Esposito sul nostro sito a questo link: https://laciviltaegizia.org/2023/12/12/le-tombe-dei-nobili/
Dendera. Parte prima: l’interno del tempio, 6 dicembre 1838.
Dopo circa 10 giorni di permanenza, nel tardo pomeriggio del 5 dicembre 1838, Roberts si accomiatò dall’ antica Tebe. Grazie al vento favorevole che aveva permesso l’utilizzo delle vele, alle undici del mattino successivo l’imbarcazione giungeva a Dendera. Una prima breve sosta, l’artista l’aveva già effettuata il 19 ottobre, durante la quale non poté fare a meno di ritrarre una panoramica sul tempio e sull’attiguo Tiphonium
Questa volta vi si sarebbe soffermato per tre giorni mettendosi immediatamente all’opera, completamente rapito dalla sconvolgente bellezza del tempio di Hathor. Il grande santuario, già dalla prima visita, aveva esercitato su di lui un fascino ammaliante, come testimonia un grande olio su tela conservato alla City Art Gallery diBristol dipinto nel 1841 sulla scorta dei bozzetti realizzati sul posto (Immagine n. 1).
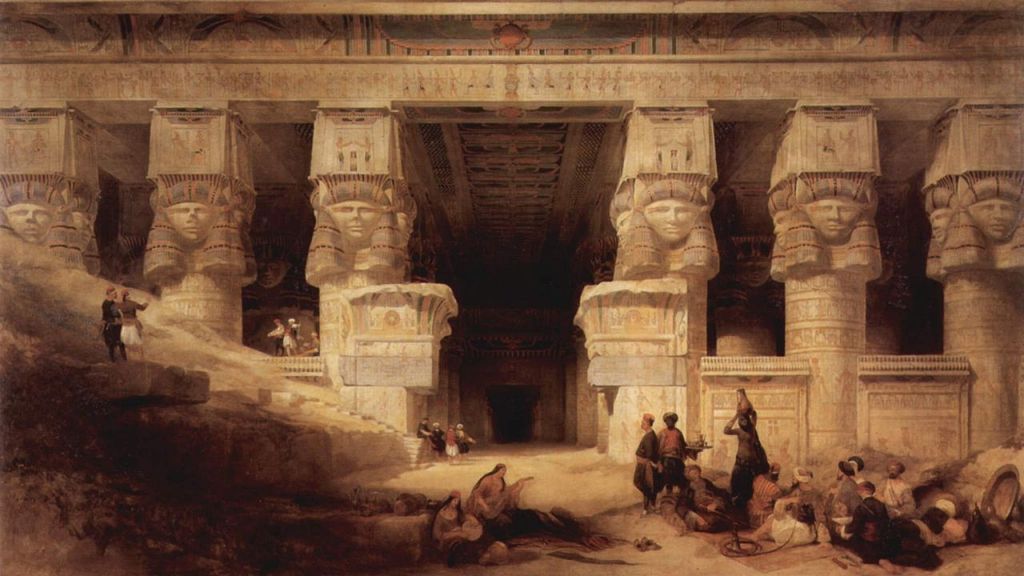
Dendera (Iunet ta-neṯeret, in antico egizio, poi Tentyris in epoca ellenistica) fu uno dei centri religiosi più importanti dell’ Antico Egitto. La città, infatti, era sede di ben tre santuari consacrati rispettivamente ad Horus, Ihy e ad Hathor. Solo quest’ultimo ci è pervenuto quasi intatto, mentre degli altri due non restano che sparute tracce. Così come accadde a Roberts, i viaggiatori e gli archeologi che si spinsero nel cuore dell’Alto Egitto rimasero puntualmente incantati dal tempio dedicato alla dea dell’amore e del piacere; all’epoca era per una buona metà sepolto sotto la sabbia, tuttavia emanava già quel fascino che oggi, dopo le intense campagne di scavo e di restauro, si manifesta in tutto il suo splendore. Quando cominciò l’esplorazione sistematica del sito ci si rese conto che l’orientamento verso sud e la grande immagine di Hathor presente sul muro meridionale avevano un significato ben preciso. Infatti, sulla medesima sponda del fiume, ma molti chilometri a monte, a Edfu, sorge il tempio dedicato ad Horus. Le due località erano i maggiori centri di culto di queste due divinità per le quali a maggio di ogni anno si celebrava una grande festa durante la quale di simulacri di Horus e Hathor venivano portati in processione sul Nilo a bordo delle imbarcazioni sacre. Tracce di edifici emerse durante i lavori di scavo del sito, dimostrano che Dendera fu un importante centro cultuale già a partire almeno dall’Antico Regno con un complesso templare più volte distrutto e ricostruito. L’assetto attuale, risalente all’epoca tardo tolemaica e romana, è caratterizzato dal prevalere di un gusto più sfarzoso rispetto alla maestosa ieraticità dei templi egizi più antichi. Questa caratteristica è ben evidente nella prima litografia realizzata da Roberts, che ritrae l’interno della prima sala ipostila, un grandioso ambiente profondo circa venticinque metri sostenuto da diciotto gigantesche colonne ricoperte di bassorilievi (Immagini n. 2-3)
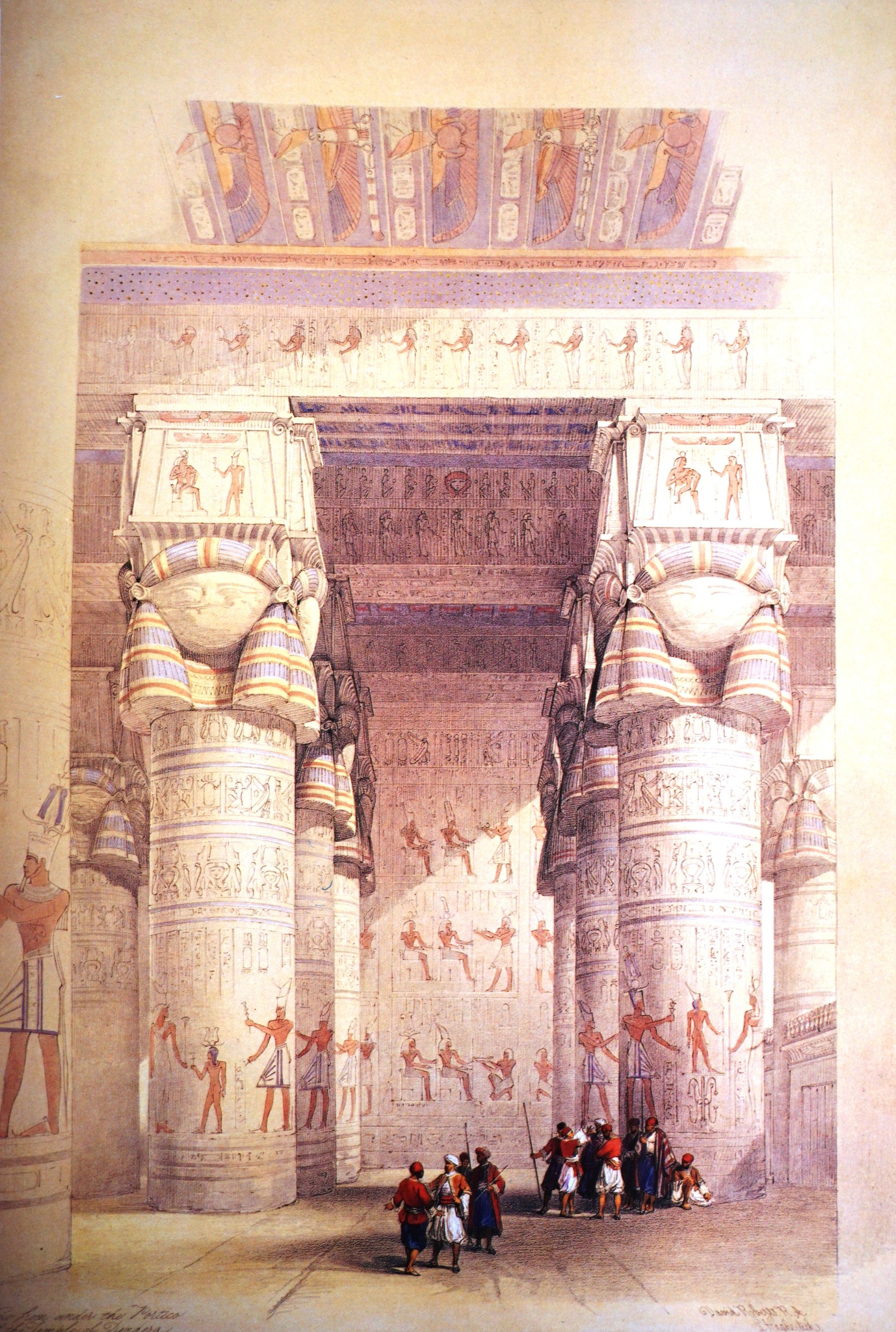
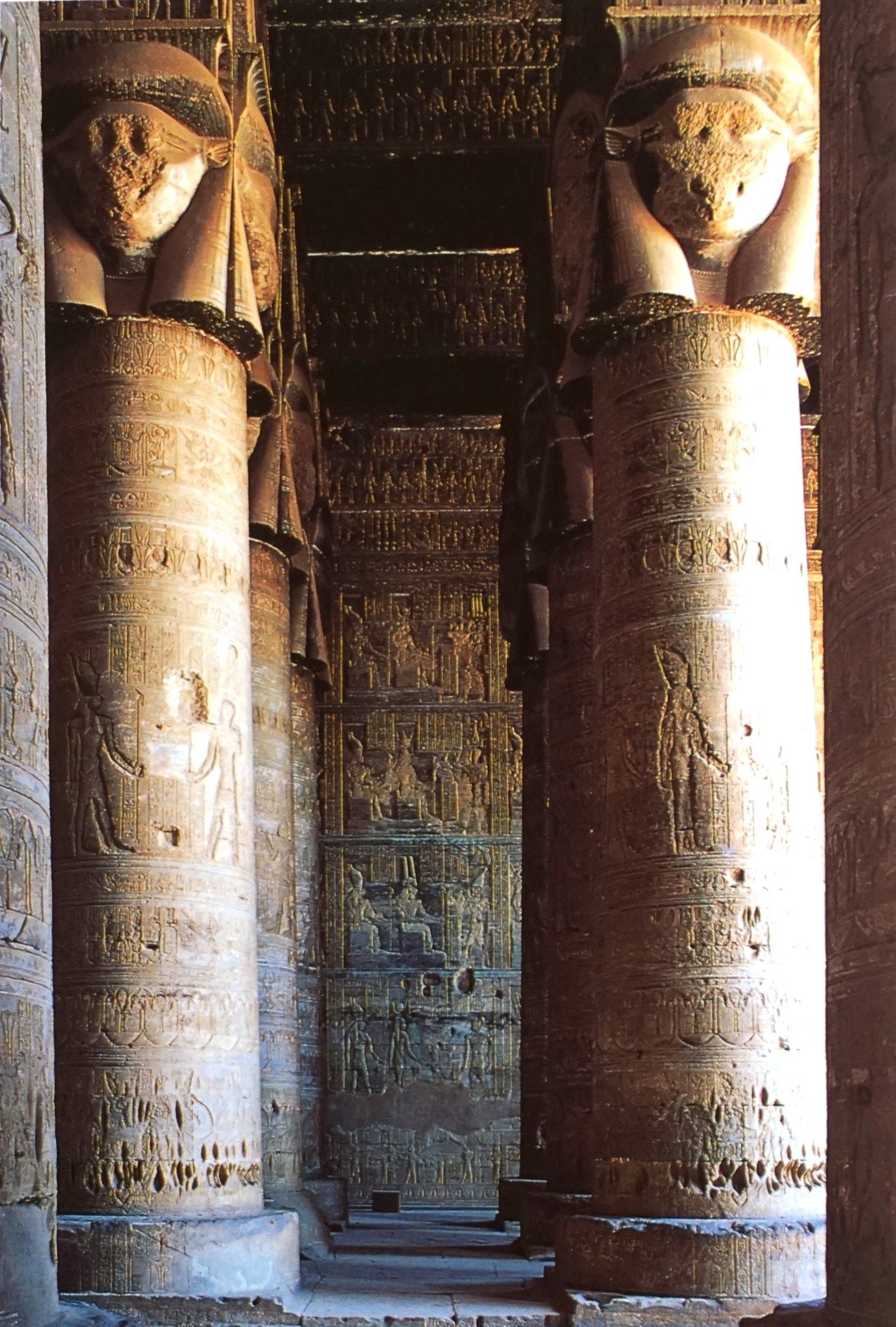
Dendera. Parte seconda: la facciata del tempio, 7 dicembre 1838.
Il tempio di Hathor, diversamente dalla tipica tradizione egizia, non presenta alcun pilone, elemento solitamente onnipresente nell’architettura sacra; lo sviluppo frontale dell’edificio è risolto con una possente struttura, larga 42 metri ed alta 18. Sei colonne, presenti lungo la facciata, sorreggono un’imponente cornice, mentre gli spazi intercolumnari sono riempiti fino a mezz’altezza da pannelli ricoperti di testi geroglifici e bassorilievi. Al centro, formando un alto spazio vuoto, si apre l’ingresso che permette l’accesso all’interno del tempio dove, su tre file, sono disposte altre diciotto colonne i cui capitelli riproducevano un tempo il volto sorridente della dea Hathor. Elevandosi oltre l’altezza del resto del tempio, questa sala ipostila, aggiunta sotto l’imperatore romano Tiberio, in un certo qual modo svolge la funzione del pilone mancante. L’insieme, con la sua sagoma marcatamente trapezoidale e le massicce colonne, potrebbe far pensare ad un edificio grossolano e sgraziato: invece, il perfetto equilibrio tra pieni e vuoti e i raffinatissimi particolari della ricca decorazione, ci restituiscono un vero e proprio miracolo architettonico.

Un miracolo che dovette provocare in Roberts un bel po’ di soggezione dal momento che lo stesso artista ci informa che trascorse buona parte del 7 dicembre alla ricerca dell’angolazione ottimale per realizzare un disegno che rendesse giustizia a questo capolavoro. A dispetto delle remore dell’autore, la tavola che ne è venuta fuori è di qualità elevatissima, estremamente illuminante sulla squisita tecnica utilizzata e qui, più che mai, assecondata dall’arte sopraffina del litografo Louis Haghe (Immagini n. 1-2).

Dendera. Parte terza: il chiosco di Iside sul tetto del tempio, 8 dicembre 1838.
I templi di Edfu e di Dendera, essendo legati ai culti di Horus e di Hathor, e pressoché coevi, presentano soluzione architettoniche piuttosto simili, ma nonostante siano entrambi ben preservati, solo il secondo conserva la “cappella dell’irradiazione” situata sul tetto a terrazza presso l’angolo sud-ovest. Ogni anno la statua della dea, solitamente dimorante nel naos, veniva portata in questo luogo affinché, esposta ai raggi del sole, ne uscisse rigenerata. La processione di sacerdoti percorreva una lunga scala ricavata nel corpo del muraglione di sinistra le cui pareti – decorate con figure che salgono in un senso e scendono nell’altro – ci illustrano lo svolgimento della cerimonia. Il chiosco, in cui si celebrava il rito della presentazione della dea a Ra, è un edificio estremamente elegante che presenta dodici colonne hathoriche collegate a metà altezza dai consueti pannelli (Immagini n. 1 e n. 2).
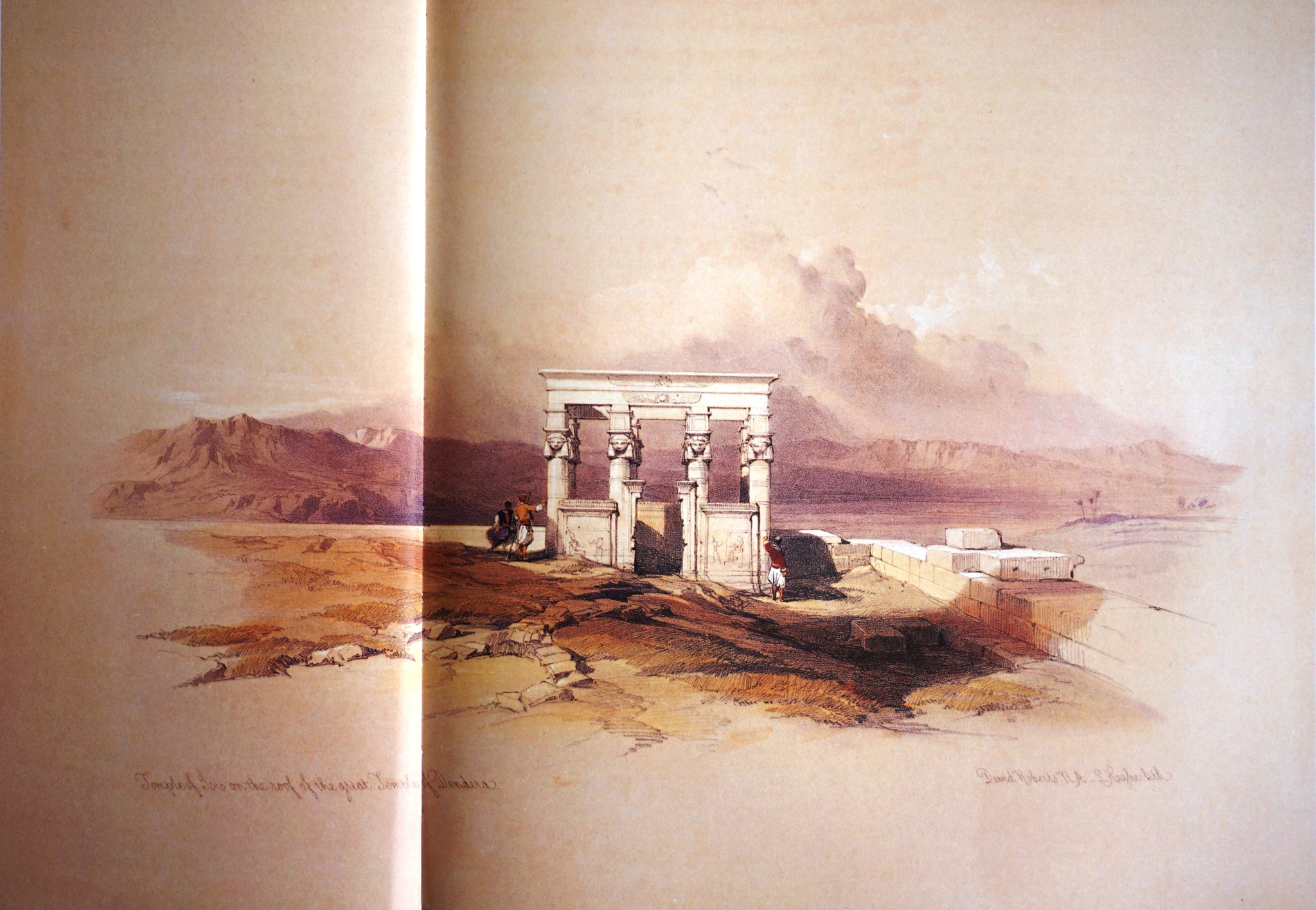
Nella zona settentrionale della terrazza sorge una piccola cappella dedicata ad Osiride che, all’epoca della visita di Roberts doveva essere ancora sepolta da sabbia e detriti. A Dendera, era custodita una delle parti del dio fatto a pezzi dal crudele fratello Seth e ciò, insieme ai legami che univano Hathor, Iside, Osiride e Horus, lo resero probabilmente il centro di culto di queste divinità più importante dopo Abydos. Sarebbe troppo lungo e anche di difficile comprensione spiegare perché, nel corso dei millenni Hathor (l’antichissima dea il cui culto ha origini nel lontanissimo predinastico), assume in sé caratteristiche e identità di altre divinità. Basti pensare che, per il continuo processo di sincretizzazione, incorporerà così tanti miti locali che, ad un certo punto sarà considerata, tra le altre, come madre, sposa e figlia di Ra, ma anche madre di Horus (quindi, Iside).

Dendera. Parte quarta: il grande portale d’accesso al recinto sacro, 8 dicembre 1838.
Il tempio di Dendera è posto al centro di una vasta area delimitata da un muro di mattoni crudi, quasi completamente in rovina, i cui lati sono lunghi tra 280 e 300 metri. Sul lato settentrionale e su quello orientale si aprono due grandiosi portali costruiti durante la dominazione romana.
Roberts ritrasse quello volto ad est, il meglio conservato dei due e, come appare evidente nella litografia, all’epoca della sua visita era in gran parte interrato, così come lo erano il tempio di Hathor e gli altri edifici che lo circondano.

Oltre al grande santuario, infatti, nel recinto sacro sono presenti altri monumenti di pregevole fattura. Poco disgiunte dalla facciata posteriore del grande tempio sono presenti i resti piuttosto rovinati di un piccolo santuario dedicato alla nascita di Iside con dei rilievi superstiti che raffigurano Nut, la dea del cielo, mentre partorisce seduta su uno sgabello. Non molto lontano, verso occidente, si trova un profondo bacino rettangolare delimitato da una cinta in muratura: è ciò che resta del lago sacro, l’elemento imprescindibile di ogni santuario egizio nel quale i sacerdoti compivano le loro abluzioni rituali più volte al giorno.
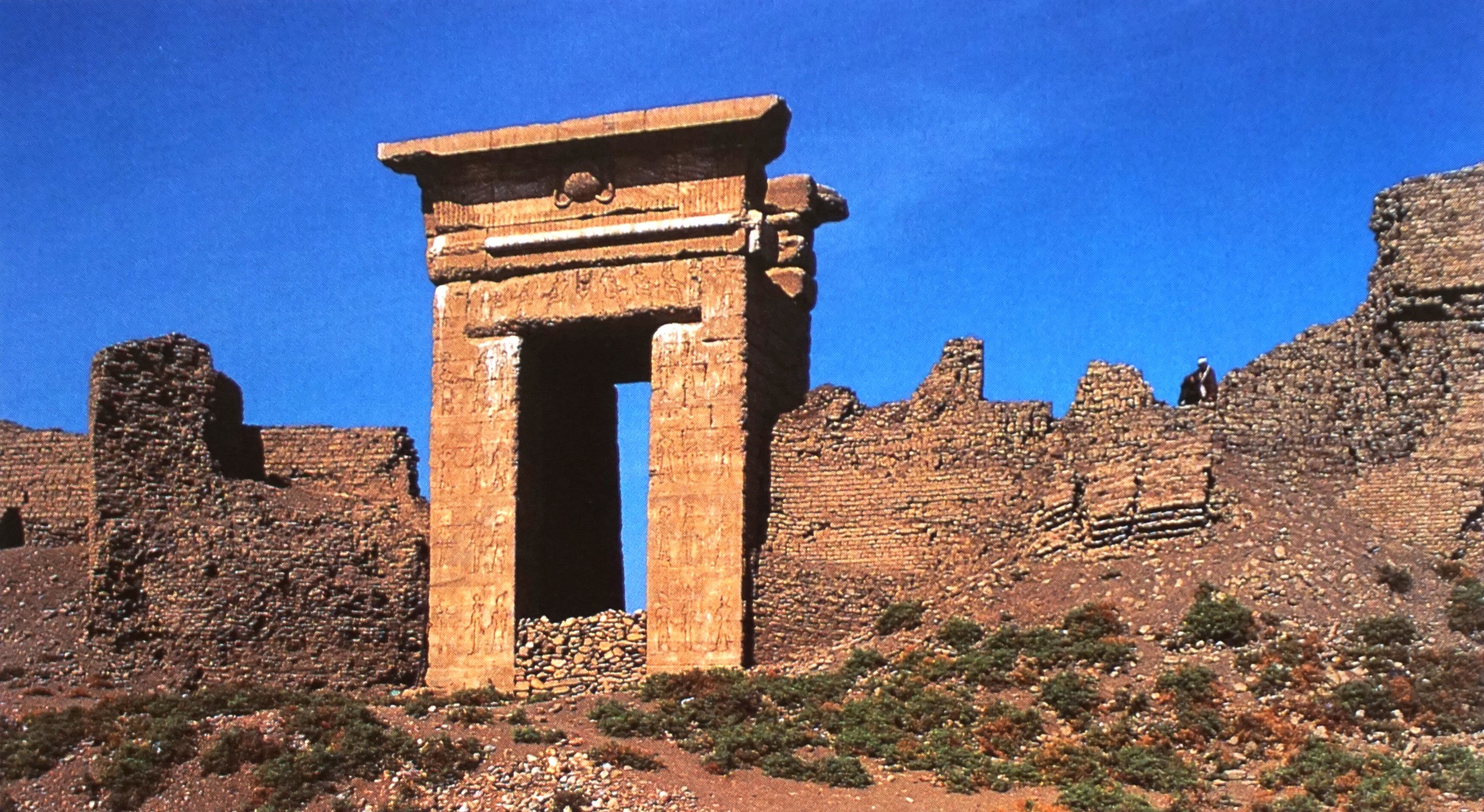
Altri resti molto interessanti sono presenti lungo il muro occidentale e l’angolo nord-ovest del tempio di Hathor: un pozzo, un sanatorio di età romana, una chiesa copta e due mammisi, uno di epoca tolemaica, l’altro di età romana. Quest’ ultimo, erroneamente definito Typhonium (che ripropongo nell’immagine n. 3), appare in una tavola che presumibilmente fu disegnata, o quanto meno abbozzata da Roberts il 19 ottobre 1838, dal momento che da allora l’artista non ne fece più menzione.
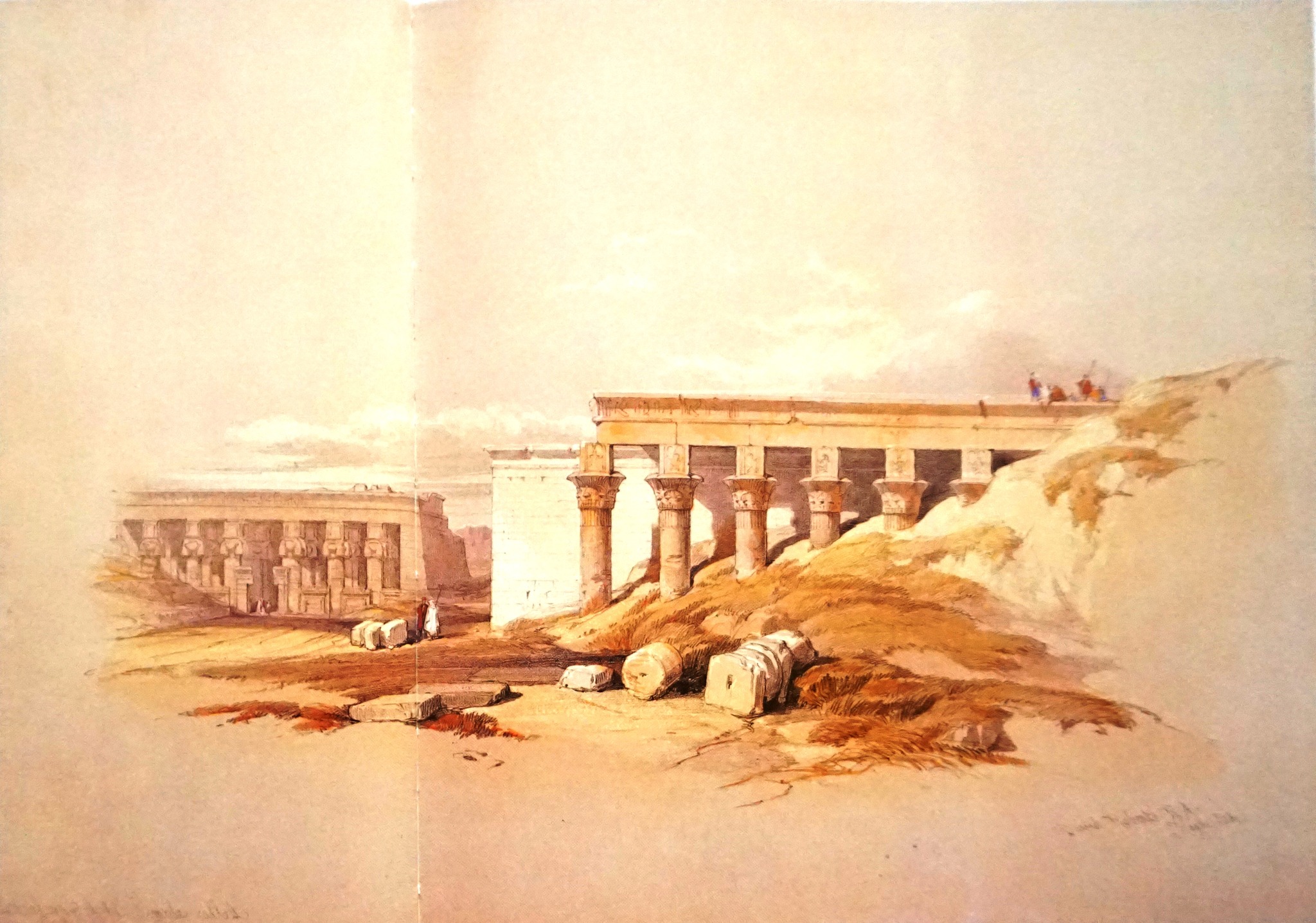
I mammisi* sono dei tempietti, caratteristici della Bassa Epoca, nei quali, col pretesto di venerare la nascita degli dei, in realtà si onorava la progenie dei faraoni. Il primo edificio di questo genere fu fatto costruire da Nectanebo I, tra il 378 e il 360 a.C. proprio a Dendera.
La sera dell’ 8 dicembre 1838 , Roberts soddisfatto del lavoro svolto a Dendera, riprese la navigazione.
Per approfondire la conoscenza di questo magnifico tempio e delle sue straordinarie decorazioni potete consultare il seguente link: https://laciviltaegizia.org/2024/05/04/il-tempio-di-dendera/ dove Grazia Musso e Patrizia Burlini vi condurranno tra le meraviglie di questo magnifico tempio.
*il termine lo si deve a Champollion che lo mutuò dal copto, vale a dire la fase finale dell’antica lingua egizia, con il significato di “luogo della nascita”
Il Nilo, nei pressi di Dashur e Saqqara, 20 dicembre 1838.
Trascorsi tre giorni a Dendera e pago del lavoro svolto, il 9 dicembre Roberts ordinò di far vela verso il Cairo; dopo essersi tanto dedicato ai templi dell’Antico Egitto, desiderava ora occuparsi anche dell’architettura islamica. I primi giorni di navigazione, li trascorse essenzialmente nella rifinitura degli oltre cento disegni che aveva, fino a quel punto, realizzato. “Niente male” – scrisse nel suo diario, con comprensibile orgoglio – “ per un mese di lavoro. Forse non avrò reso giustizia a queste antiche vestigia, ma pochi altri artisti nelle mie condizioni avrebbero potuto permettersi il lusso di trattenersi in quei luoghi più a lungo e mi chiedo quanti avrebbero potuto produrre di più nel medesimo tempo”.
Il giorno 10 fece scalo per qualche ora ad Abydos, la città sacra ad Osiride per eccellenza, della quale all’epoca solo pochissimi resti del complesso templare di Seti I erano visibili; solo ventuno anni più tardi, infatti, questo splendido monumento sarebbe stato riportato alla luce da Auguste Mariette.
Il 13 dicembre, giunto a Siout, si accorse sgomento, di aver lasciato la cartella con i suoi preziosi disegni sulle alture di Girgeh, dove era salito due giorni prima per verificare alcuni schizzi realizzati durante il viaggio di andata. Fortuna volle che era di passaggio, diretta a sud, un’ imbarcazione che issava bandiera inglese: il proprietario, venuto a conoscenza del problema si offrì di ospitare a bordo Ismail e Hassan Amoris che, una volta giunti a Girgeh, avrebbero tentato di recuperare i disegni. La trepidante attesa di Roberts si protrasse sino al giorno 17, allorquando i due fecero ritorno con il prezioso materiale su una barca presa in affitto. Nel frattempo, il tempo andava guastandosi e le giornate cominciavano ad essere piuttosto fredde, per cui fu presa la decisione di sfruttare il vento favorevole per giungere al più presto a destinazione. Finalmente, il 20 dicembre giunsero in vista delle piramidi di Dashur, delle quali Roberts non poté fare a meno di realizzarne una veduta ripresa dal Nilo (Immagini n. 1 e n. 2).

<< Questa mattina siamo giunti in vista di quelle che vengono chiamate le False Piramidi. Gli uomini hanno cantato tutto il tempo, felici all’idea di giungere finalmente a casa entro questa notte. Mi sono talmente abituato alla loro compagnia, che mi sento triste all’idea dell’imminente addio. Il viaggio è stato affascinante e senza dubbio il più importante della mia vita. Penso che i miei disegni siano di grande interesse, a prescindere dalla loro bontà artistica.>>
(© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg. 192-193).
Nella litografia sono riconoscibili, a sinistra, la “Piramide Romboidale” e la “Piramide Rossa”, entrambe costruite durante il regno di Snefru, mentre all’orizzonte si intravede il complesso meridionale della necropoli di Saqqara. In primo piano è ritratta un’imbarcazione con un carico di schiave, il cui proprietario – un greco dall’aspetto sgradevole – ne decantava le lodi. Roberts, estremamente contrariato, si rammaricò di non conoscere che poche parole di greco o di arabo, insufficienti per esprimere al losco individuo l’indignata riprovazione per la sua occupazione.

Le piramidi di Giza, 17 gennaio 1839
Giunto a Il Cairo il 21 dicembre 1838, Roberts vi si trattenne a lungo dedicandosi, stavolta, a ritrarre gli splendidi monumenti d’architettura islamica che fanno della capitale egiziana un vero e proprio scrigno di quell’arte sopraffina. Non essendo in tema con il periodo storico trattato, tralasciamo le litografie che Louis Hage, trasse dai disegni dell’artista.
Ma, a breve distanza, si estende la piana di Giza che ospita i monumenti più iconografici di tutto l’Egitto faraonico e Roberts, di certo, non poteva esimersi dal dedicare a queste meraviglie la sua entusiastica attenzione. Il 17 gennaio 1839, infatti, dopo una prima fugace presenza il 3 ottobre dell’anno precedente, era di nuovo al cospetto delle tre Piramidi e della Sfinge, che ancora una volta lo lasciarono attonito sia per le mastodontiche proporzioni, sia per lo splendore e la purezza delle linee. D’altra parte non poteva essere diversamente dal momento che già dai tempi più remoti le colossali tombe dei faraoni della IV Dinastia avevano suscitato ammirazione e incredulità: basti pensare che la piramide di Khufu (Cheope) era annoverata tra le sette meraviglie del mondo antico, l’unica che sia giunta sino a noi. Tutto ciò ha contribuito a generare una vasta letteratura, ricca di ipotesi (talvolta ridicolmente fantasiose) sulla loro costruzione, sul significato recondito delle loro proporzioni e sull’esoterico segreto dell’orientamento in funzione del quale furono allineate su basso plateau di Giza. Già nel lontano passato si hanno testimonianze dei visitatori dell’epoca che cercarono di fornire spiegazioni ai numerosi quesiti che sollevano queste stupefacenti costruzioni. Lo storico greco Erodoto, ad esempio, che visitò l’Egitto nel 450 a.C. (ben due millenni dopo che le piramidi erano state erette!), ci racconta nel secondo libro delle “Storie”che per la costruzione della Grande Piramide vennero impiegati centomila uomini, in turni di tre mesi, Cheope viene descritto come un tiranno che impose al suo popolo due decenni di stenti e fatiche immani. Commenti analoghi furono espressi da un altro storico, Diodoro Siculo vissuto quattro secoli più tardi. In epoca recente ci fu chi si improvvisò pioniere di una nuova pseudo-scienza, “la piramidologia”, caratterizzata da astruse interpretazioni che pretendevano di dimostrare come dalla maggiore delle piramidi fosse addirittura possibile ricavare, applicando opportuni calcoli, informazioni sulla distanza terra-sole, sulla sfericità terrestre, e finanche una storia completa dell’umanità scritta nella pietra!*
Ovviamente, i recenti studi degli egittologi che lavorano da decenni sul campo ci raccontano una storia del tutto diversa e demoliscono anche quel mito, introdotto da Erodoto, avallato dalla Bibbia e perpetuato in tempi recenti attraverso un certo tipo di filmografia, che nell’immaginario comune resta ancorato all’idea di decine di migliaia di uomini ridotti in schiavitù e costretti ad immani patimenti sotto la sferza dei capi-squadra.**
La prima litografia delle piramidi fu disegnata da Roberts dalla riva orientale del Nilo, nei pressi dell’imbarcadero del traghetto per Giza (Immagini n. 1-2)
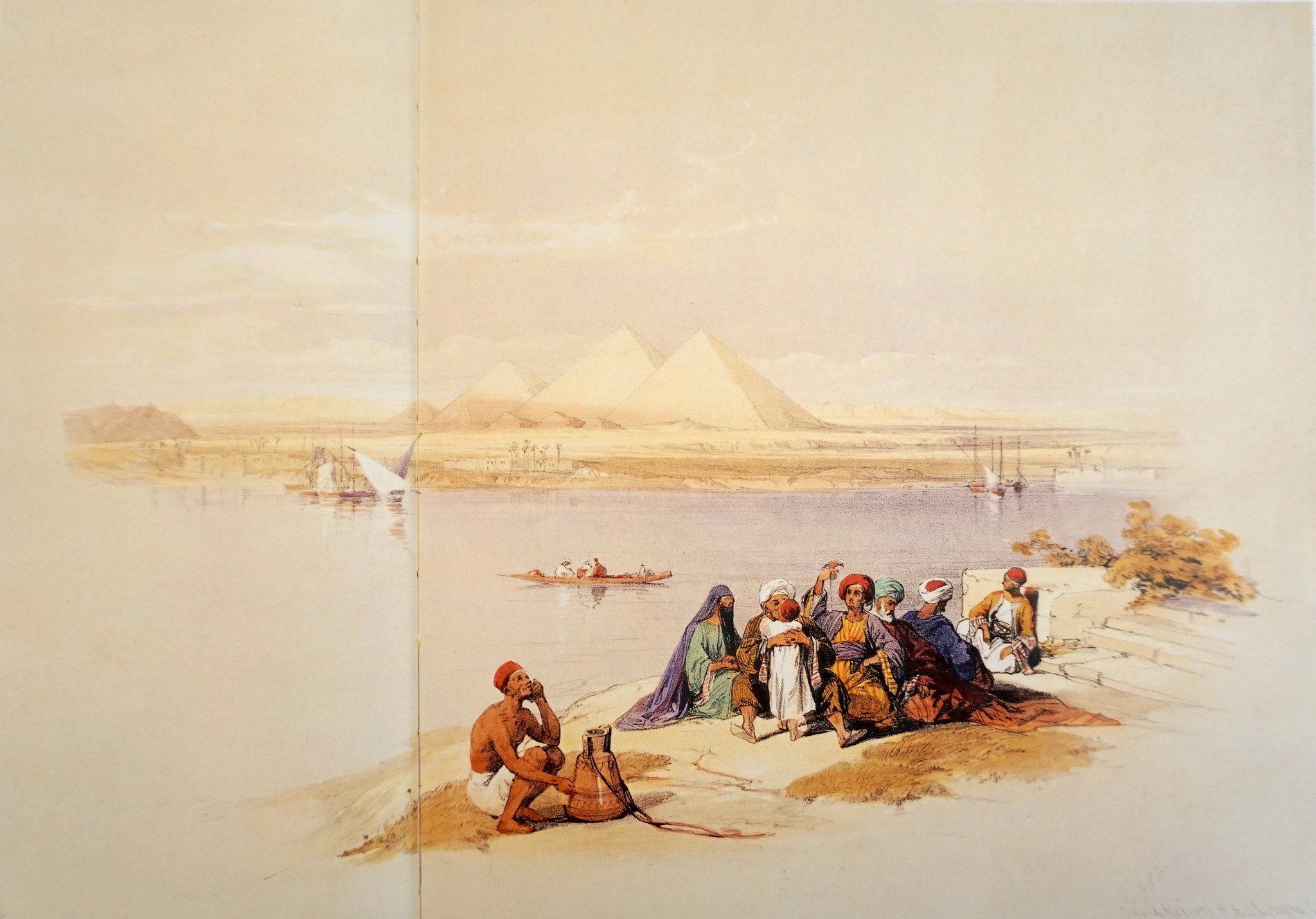

Nella seconda litografia, invece, Roberts focalizza la sua attenzione principalmente sulle piramidi di Khufu e Kaefra (Immagini n. 3-4).

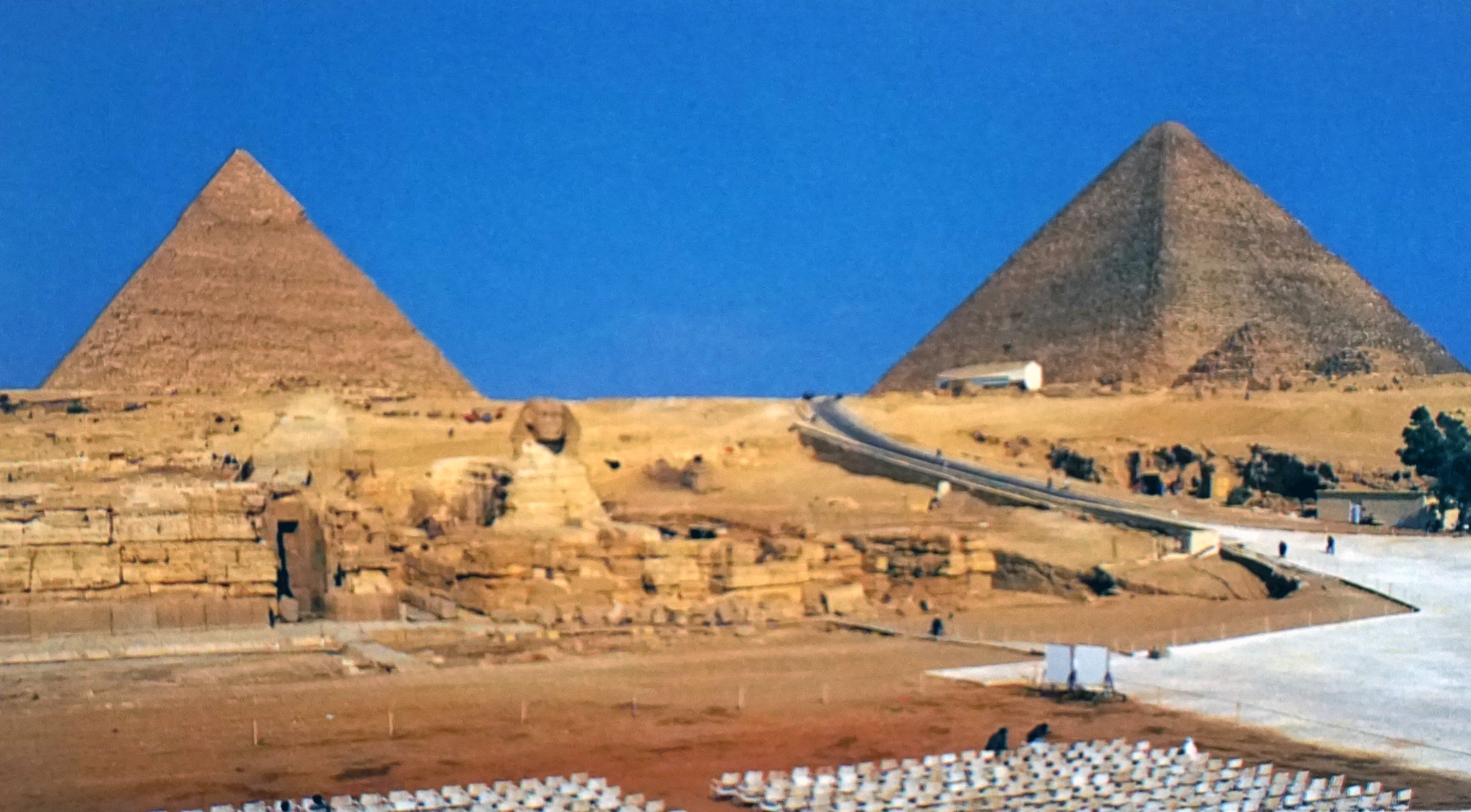
* Per approfondimenti sul fenomeno della “piramidologia”, rinvio al seguente link: https://laciviltaegizia.org/2021/09/24/i-piramidologi/
** Per quanto riguarda le ricerche scientifiche effettuate in questi ultimi decenni sul sito di Giza e sui ritrovamenti che hanno gettato nuova luce sui suoi straordinari monumenti, troverete una serie di articoli nella rubrica “Luce tra le ombre” al seguente link: https://laciviltaegizia.org/luce-tra-le-ombre/
La Sfinge, 17 gennaio 1839.
L’impressionante monumento, efficacemente chiamato dagli arabi “Abu el-Hol”, vale a dire “il Padre del Terrore” , si erge sulle sabbie del deserto davanti al lato orientale della Piramide di Khaefra. E’ alta 20 metri e giace adagiata per una lunghezza di circa 73 metri. L’enorme simulacro, dal corpo leonino, fu ricavato da uno sperone di roccia calcarea, originariamente utilizzato come cava di materiali di costruzione. Anche su questa favolosa realizzazione si sono sprecate le più fantastiche teorie proposte da pseudo-scienziati ed egittologi improvvisati, interessati, evidentemente, più al profitto economico derivante dalla pubblicazione di volumi ad alto impatto sensazionalistico, che allo studio serio e rigoroso delle evidenze storiche, archeologiche e geologiche. (Per chi volesse approfondire troverà un’ampia trattazione dell’argomento a questo link: https://laciviltaegizia.org/2021/10/09/quanti-anni-ha-la-sfinge/)
Quando visitò la Sfinge, Roberts, ne vide, emergente dalla sabbia, quasi solo il volto che all’epoca presentava tracce policrome molto più evidenti di quanto non lo siano oggi (Immagini n. 1-2). La titanica scultura fu soggetta già dai tempi antichi all’insabbiamento; ai tempi di Erodoto, ad esempio, doveva essere addirittura del tutto invisibile, dal momento che lo storico non ne fece alcuna menzione.


Nella seconda litografia, Roberts riprese la Sfinge frontalmente (Immagini n. 3-4), mentre la terza (Immagine n. 5) ce la presenta al tramonto durante una furiosa tempesta di sabbia.
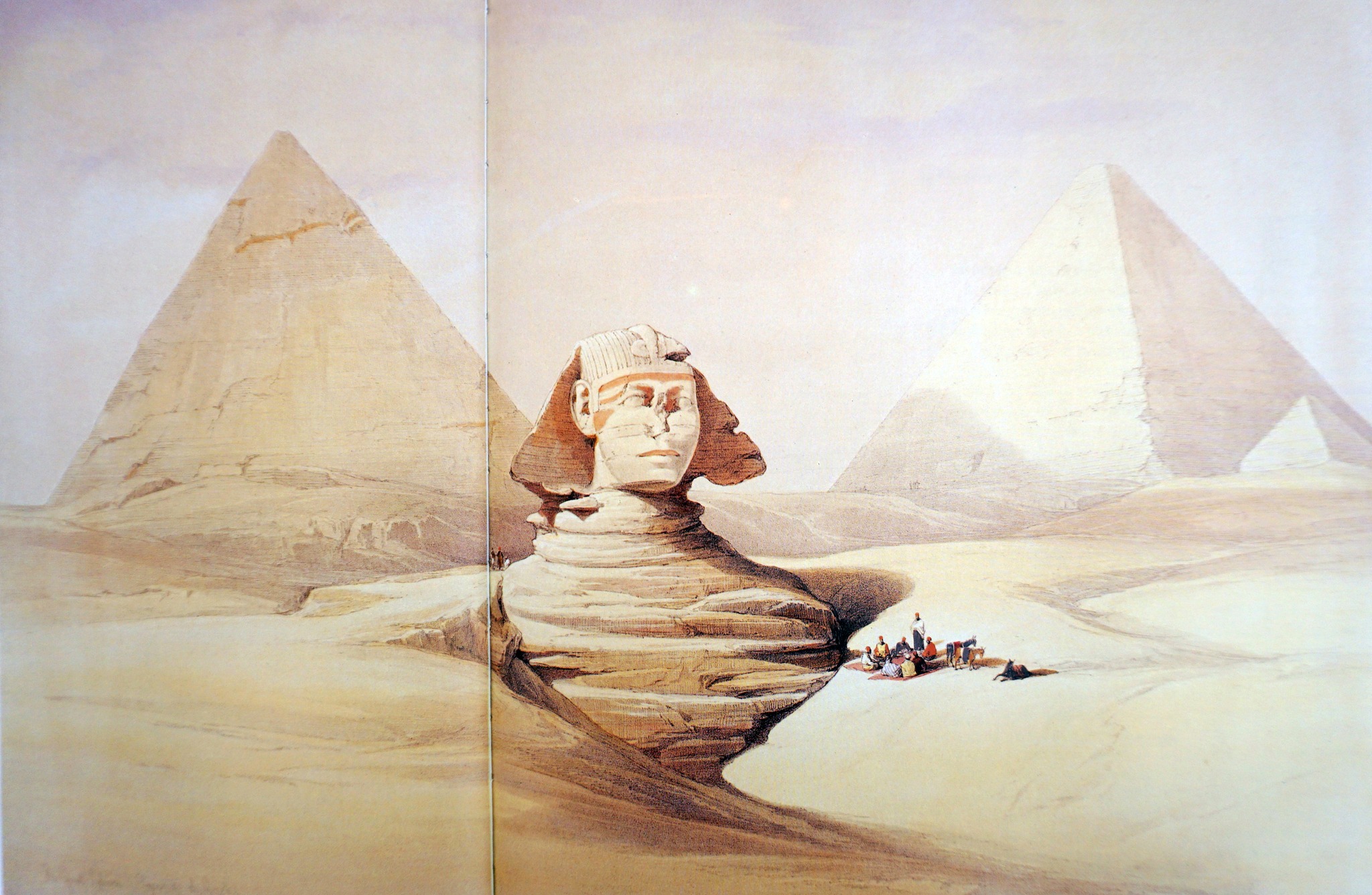


Quest’ultima rappresentazione si presta a numerose considerazioni sia riguardo alla data di realizzazione sia perché si discosta enormemente dal rigore documentaristico che l’artista aveva costantemente espresso nei suoi lavori. Probabilmente il disegno preparatorio per questa splendida litografia fu eseguito una volta rientrato in patria e l’autore, questa volta, si concesse più di una licenza rispetto al vero. La composizione, infatti, va vista come una sorta di tributo al fascino misterioso dell’Antico Egitto. Il soggetto ci presenta una scena in cui una furiosa tempesta di sabbia sta per scatenarsi mentre il cielo divampa sotto gli ultimi raggi del sole al tramonto; un gruppo di carovanieri cerca riparo dalla furia del Simùn nei pressi della Sfinge, il cui sorriso ieratico sembra esprimere un’imperturbabile indifferenza all’ imminente violenza del vento. Il monumento, che nella realtà è rivolto verso il sole nascente, è qui orientato verso ovest, mentre l’astro sta tramontando a sud; la piramide di Menkaure è troppo vicina e quelle delle regine sono sperdute all’orizzonte. Inoltre, il Simùn, il vento caldo e secco che si scatena d’improvviso con incredibile violenza, spira di solito nei mesi primaverili ed è quanto meno improbabile che l’artista possa essere stato testimone di un evento simile a quello ritratto. Tuttavia, questa veduta è sicuramente una tra le più drammatiche ed emotivamente coinvolgenti dell’intera raccolta. Nel gennaio del 1850 Roberts dipinse un piccolo olio di soggetto analogo che donò all’amico Charles Dickens: alle critiche di quanti si avvidero delle incongruenze presenti, il grande scrittore replicò che “agli artisti è consentita la licenza poetica”.
L’ obelisco di Sesostris I a Heliopolis, 20 gennaio 1839.
Il giorno 20 gennaio 1839, Roberts si recò ad Heliopolis, “il luogo dove lo storico greco Erodoto era stato iniziato ai misteri del clero egizio”. Sorta in epoca remotissima con il nome di Iunu, e ben presto divenuta luogo di irradiazione del culto del dio Ra, la città è più volte citata nella Bibbia sotto l’appellativo di On.
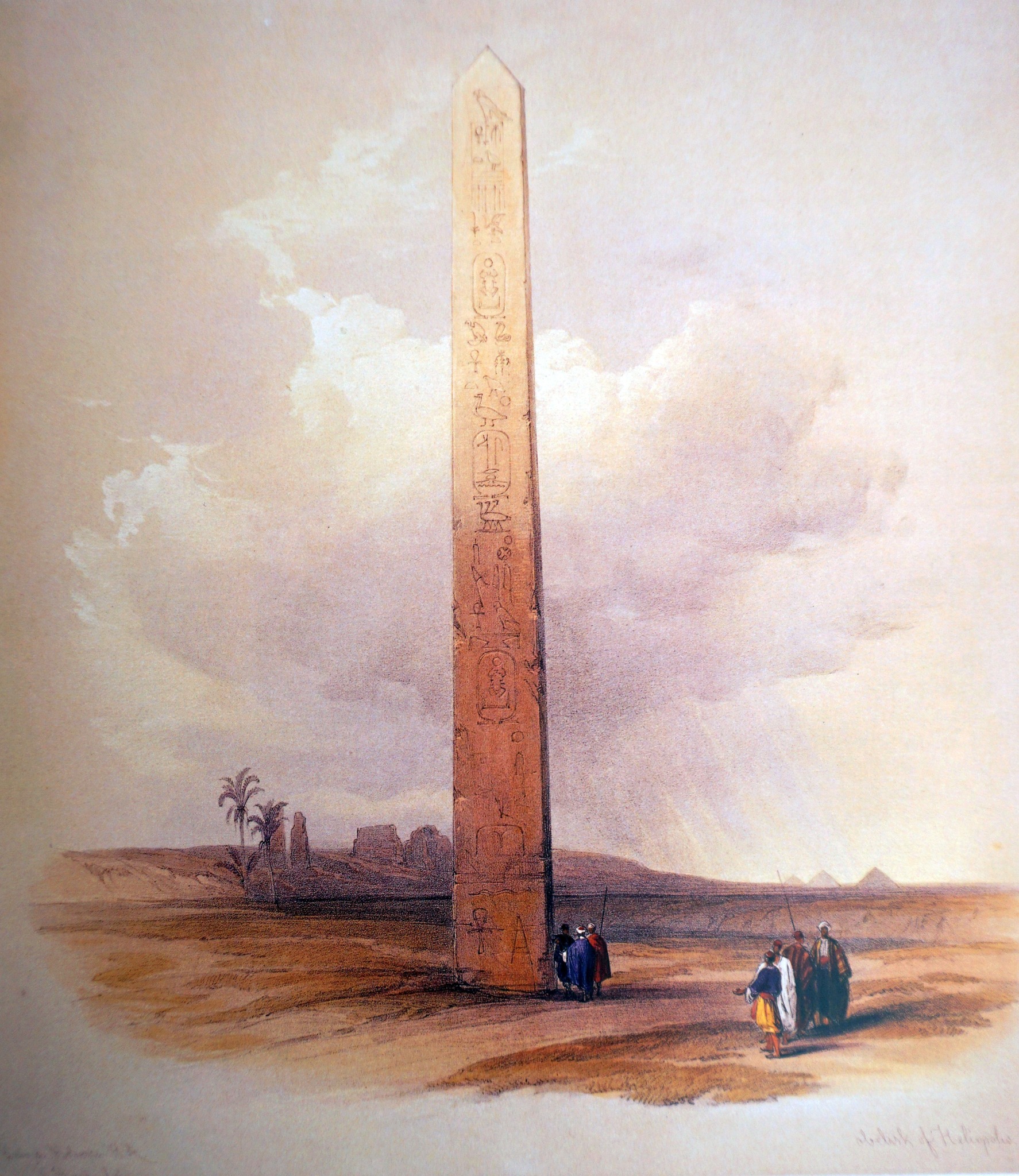
Heliopolis fu uno dei centri culturali e religiosi più prestigiosi di tutto l’Egitto Antico. Qui, si sviluppò una delle più importanti cosmogonie religiose, nota come Enneade Eliopolitana, e vi fu eretto un gigantesco tempio che più tardi, in epoca ramesside, fu secondo per importanza solo a quello di Tebe; i suoi sacerdoti erano celebri in tutto il mondo antico per la loro cultura e saggezza e la tradizione vuole che anche Platone vi si fosse recato per apprenderne il sapere. Del grande santuario, probabilmente per il suo utilizzo nei secoli come cava per la costruzione della città del Cairo), non ci è pervenuto praticamente nulla fatta eccezione per uno dei due obelischi fatti erigere da Senwosret (Sesostri I, 1964-1919 a.C. circa). Il monolite, in granito rosso di Aswan è alto più di venti metri e pesa circa 120 tonnellate. La tavola che Roberts disegnò (Immagini n. 1-2), fu l’ultima che l’artista dedicò alle rovine dell’Antico Egitto e, a causa di un temporale che stava scatenandosi, fu realizzata in tutta fretta; nonostante ciò risulta essere molto suggestiva e ci restituisce il fascino che il luogo, all’epoca sgombro dalle abitazioni moderne e con le piramidi visibili in lontananza, era capace di suscitare nel visitatore.
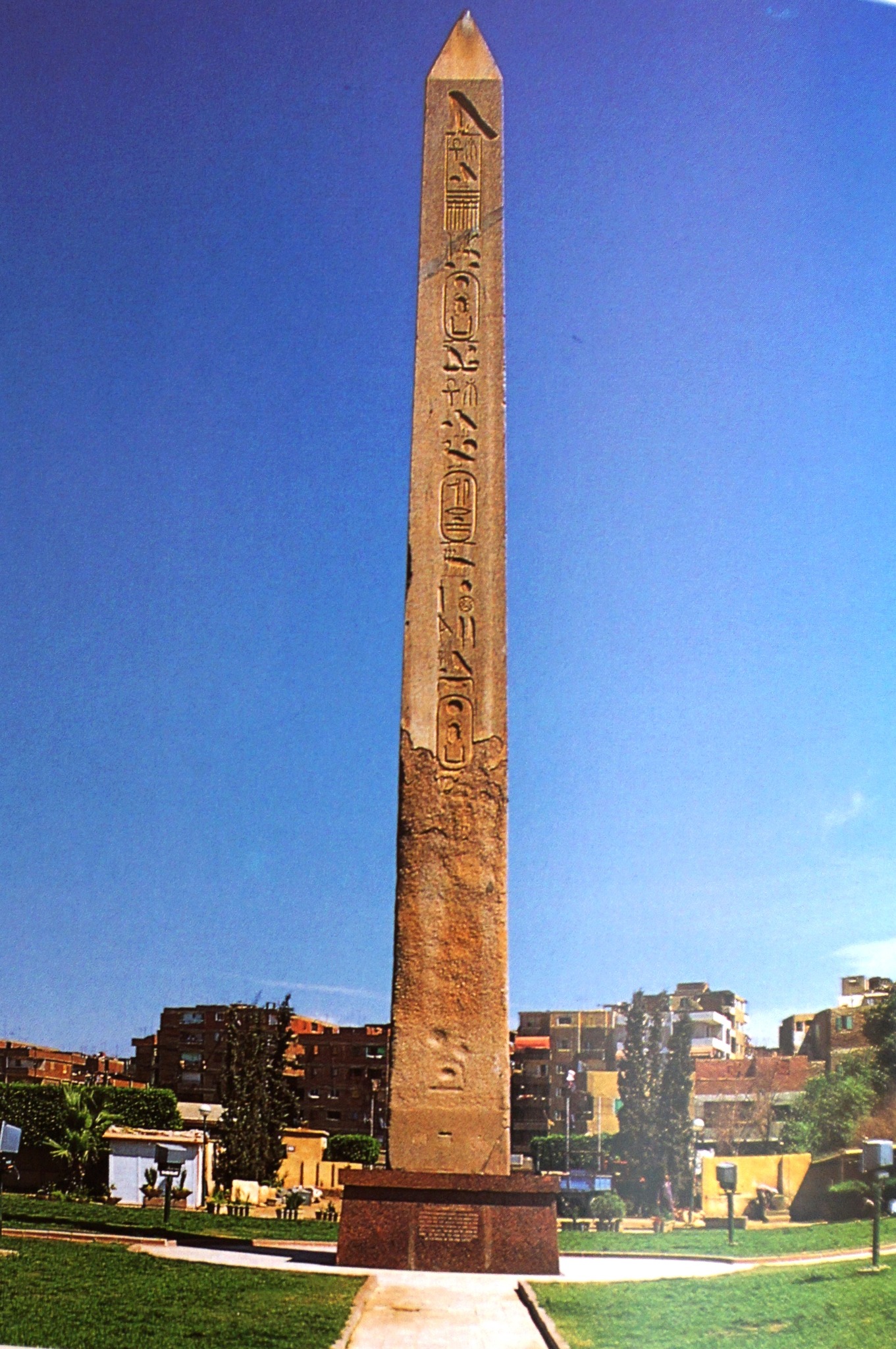
Fonte:
Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts (testi di Fabio Bourbon, fotografie di Antonio Attini). Ediz. White Star